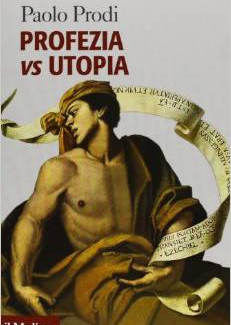Cari amici, è concessa questa volta, una lettura colta, forse neppure semplicissima, ma sicuramente illuminante? Viene da un intellettuale di nostra conoscenza, Gianmario Italiano, che nel recensire un volume uscito di recente (Paolo Prodi, Profezia vs Utopia, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 251) mette in evidenza come, ai tempi di Savonarola, le questioni politiche e sociali fossero simili a quelle odierne. Lasciamo a voi considerazioni e commenti. Ai politici chiediamo di comparire qualche volta in meno in tv e passare una serata rileggendo queste cose.
(per facilitare la lettura, sono evidenziati i passaggi più significativi)
Uscito per i tipi dell’editore Il Mulino, la raccolta di saggi di Paolo Prodi, uniti in un solo libro al fine di confrontare i concetti di “profezia” e “utopia”, al di là del valore dei nove contributi, cui ovviamente si rimanda, merita di essere segnalato per la capacità di evidenziare elementi di continuità nella storia di talune situazioni politiche. La storia, infatti, ha certamente due funzioni fondamentali, ossia la “memoria” e la “delegittimazione”: “come memoria nel senso di indagine di quanto del passato è presente nella nostra identità attuale; di delegittimazione nel senso di fornire alla coscienza pubblica gli elementi necessari per demistificare e svelare i meccanismi del potere che si celano in una società che tende a cancellare il passato per una visione totalmente appiattita sul presente” (p. 237). Secondo Prodi, la profezia non è “predizione del futuro: la profezia può contenere previsioni e minacce, ma rimane soprattutto contestazione del male dominante del mondo, pronunciata a nome di Dio”, ma essa è scomparsa “nel passaggio tra il medioevo e l’età moderna […] sostituita nella modernità dall’utopia”. La profezia nell’Antico Testamento era contestazione “al sistema”, per condannare l’ingiustizia e proclamare un cammino di redenzione, pace e salvezza del popolo ebraico, ma con il Vangelo essa viene “istituzionalizzata: la Chiesa è una proclamazione della Parola di Dio non più solamente da parte di un singolo uomo, ma da parte di una comunità che partecipa” (pp. 8-9). Secondo l’Autore, vi è stato tra profezia e utopia “uno scambio delle vesti”, che ha portato l’utopia ad avere “una carica di sacro” e la profezia ad assumere “all’interno della Chiesa cattolica la funzione di un «non luogo» a difesa di una deriva al di fuori della storia” (pp. 14-15). L’epicentro di tale trasformazione è da ricercarsi tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento, tra le prediche di Savonarola su Aggeo del novembre 1494 e la prima edizione dell’Utopia di Thomas More nel 1516.
Non è quindi certo per caso che la figura di Savonarola si stagli prepotentemente all’interno del libro. Tra gli articoli merita di essere analizzato, specie per la sua attualità, il contributo Gli affanni della democrazia. La predicazione del Savonarola durante l’esperienza del governo popolare in Savonarola e la politica, nel quale l’Autore, analizzando oltre 200 prediche pronunciate da Savonarola tra il gennaio 1495 e il marzo 1497, delinea un domenicano “molto più politico di quanto l’accentuazione del suo profetismo abbia lasciato trasparire” (p. 51). Sin dal 1496, infatti, molti dei mali che ai giorni nostri sono rimproverati alla politica -alla “casta”, si direbbe- erano già evidentissimi. A novembre, Savonarola propose la terminologia profetica dell’«elettro», «oro e argento mescolati insieme» e dei «tiepidi» (anche se poi trionferanno per i suoi fautori i nomi di “piagnoni” contrapposti ai “bigi” e “arrabbiati”), ma oramai si potevano già individuare due “parti politiche” ben definite, quasi “partiti” nel senso moderno. Il Consiglio Maggiore, organo preposto alle funzioni legislativa ed elettiva, era rallentato a causa della mancanza di una sede, ma soprattutto dalla presenza di “intelligenze” tra gruppi privati, alla preconcetta contrapposizione dei “partiti” e infine alla numerosità degli eletti. A maggio, Savonarola aveva segnalato un altro inconveniente per la sopravvivenza e lo sviluppo della democrazia: “la noia per la politica, l’allontanarsi dei cittadini dalla partecipazione al consiglio per il moltiplicarsi delle riunioni e l’estrema lentezza delle procedure assembleari” (p. 65). Ormai Savonarola riconosceva la necessità di una “intelligentia” in suo favore, insomma di una maggioranza, e aggiungeva due elementi di riflessione di grande modernità sulla mancata approvazione di una legge di riforma dei costumi delle donne. La prima è che durante la discussione in Consiglio erano stati introdotti degli emendamenti (“frasche”) allo scopo di ridicolizzare il progetto di riforma stesso, la seconda che i consiglieri sembravano troppo succubi del “Palazzo”. Ad agosto, forse l’inizio del declino del frate ferrarese, in una lucidissima analisi politica Savonarola delineò tre motivi di crisi. Il primo, è la presenza di due partiti, dai quali i voti non sono più dati in Consiglio a seconda della validità del progetto o della persona in discussione, ma in base a preconcette ragioni di schieramento. In secondo luogo, l’assenteismo: “quando e’ suona la campana”, segnale di convocazione del Consiglio, “quello si sta a bottega, quell’altro ne va in villa”, avrebbe asserito. Il terzo luogo, la scarsa libertà di parola in Consiglio, da tutelare con apposita legge. Gli aggiustamenti proposti al funzionamento del Consiglio non approderanno a nulla: il sistema democratico non era in grado ancora di funzionare, visti anche i limiti di rappresentanza (pp. 66-70).
Se non bastassero questi accenni alla politica dei nostri giorni, possiamo esaminare la procedura per le nomine alle cariche pubbliche, fatto fondamentale per l’evoluzione della concreta linea politica del Savonarola. Le esortazioni del frate al bene comune avevano riportato evidentemente risultati modesti, se il 18 ottobre 1496 Savonarola invitava di nuovo a conferire gli incarichi “a quelli che sono atti e buoni, e non li date allo amico o al parente”, come peraltro era usanza anche all’interno del suo stesso partito (“Diamoli la fava nera o bianca [il voto] perché egli è della tal parte”, si sosteneva), ma è chiaro che nella realtà quotidiana Savonarola fu costretto a trasformare un giudizio morale in uno politico, quando oramai i risultati della selezione della classe dirigente erano sotto gli occhi di tutti: “Vediamo qualche volta uno di questi cittadini sciocco che […] vuol governare lo Stato, e pure el si ingerisce suso e la brigata poi se ne ride de’ fatti sua. Tu doveresti dire: «Se io mi metto qua su in questo magistrato, io farò come la scimmia che quanto più sale in alto, tanto più mostra le sue vergogne» [7 marzo 1496]”, (pp. 73-74).
Anche sul deficitario bilancio pubblico, Savonarola incontrò difficoltà paragonabili alle odierne. Nel dicembre 1494, il frate aveva proposto dal pulpito di risanare il debito pubblico e di impostare in maniera diversa il bilancio dello Stato con la “tassazione diretta sulla ricchezza immobiliare -la decima-“ (oggi: tasse sulla casa), che però non riuscì a concretizzarsi. Nell’attesa dell’entrata in vigore della gabella, ci si orientò sulla tassazione indiretta (oggi: le accise, IVA, ecc.) e sugli “accatti”, prestiti forzati in auge anche sotto il precedente regime (oggi: titoli di Stato, seppure non forzosi). Sempre in campo economico, al di là di continue esortazioni alla carità cristiana, all’istituzione del Monte di Pietà, il convincimento di Savonarola era che la tirannide, adusa a drenare risorse per autoalimentarsi fosse peggiore di una democrazia con minori entrate, però potenzialmente più forte perché in grado di tagliare sprechi e corruzione. Del resto, in questi anni di crisi, nella predicazione del ferrarese ricorre all’idea che la miglior elemosina per i ceti abbienti fosse dare lavoro ai poveri (p. 87).
Nel campo delle immunità fiscali ecclesiastiche, Savonarola legittimò l’imposizione fiscale sul clero in caso di estrema necessità, mentre l’immunità ecclesiastica non poteva essere rispettata quando in gioco era la salute delle anime e della patria. In ogni caso, Savonarola cercò di fondare nuovi rapporti tra Stato e Chiesa, non “su millenarismi profetici, ma concretamente opposta alla dominante politica concordataria dei principi e del papato; e sarà questa battaglia perduta a condannarlo a morte”. Forse nell’accenno a un nostalgico richiamo al tempo perduto, possiamo ritrovare un accenno ante litteram alla burocrazia incombente: “Al tempo antico non si faceva tanti patti e tante scritture; […] è venuto un viver tanto sottile che non si può più” (p. 107). Da tutto il quadro proposto, emerge insomma un frate con una certa mobilità di pensiero, oltre a essere lucidamente profetico del futuro democratico.
Altri saggi si incentrano sulla figura del frate ferrarese, la cui proposta politica, sebbene consapevole della “realtà crudele del potere”, fu “un repubblicanesimo democratico con recupero della tradizione comunale” (p. 131), ma la democrazia mancava ancora “degli strumenti e delle tecniche di rappresentanza e di organizzazione che possano permettere il governo di «molti»”, tanto che la sconfitta del Savonarola giunse proprio dal suo embrione di partito, non più inteso come banda armata o fazione di stampo medievale, ma come “portatore pubblico di un progetto e di un programma collettivo” (pp. 133-134). Sul piano religioso poi l’opposizione al doppio potere, spirituale e temporale della Chiesa romana e del papato è chiara sin dal 1496 (come poi avrebbe scritto anche Guicciardini), ma Savonarola rifiuta la simbiosi tra potere politico e potere ecclesiastico, e dunque le emergenti Chiese territoriali e stati confessionali nelle mani dei principi (pp. 136-137).
Alla corposa parte di saggi dedicata a Savonarola, seguono altri esempi di profetismo, come quello di Angela Merici oppure sul domenicano Melchior Cano (1509-1560) o ancora sulla figura di Rosmini, che sarebbe lungo analizzare. La “Storia” cerca sempre di difendere il cittadino che la conosce dalle false verità propinate dai politici, come la bizzarra idea di non poter distinguere tra persona e persona dinnanzi a una scheda elettorale, pensiero le cui estreme conseguenze furono espresse da Rosmini (Delle cinque piaghe della Chiesa, a cura di A. Valle, Roma, Città Nuova, 1981, p. 93, citato a p. 206) molti decenni orsono: “Ogni società libera ha essenzialmente in diritto di eleggere i propri ufficiali. Questo diritto le è tanto essenziale è inalienabile come quello di esistere. Una società che ha ceduto in altrui mani l’elezione de’ propri ministri, ha con questo alienato se stessa: l’esistenza non è più sua”.