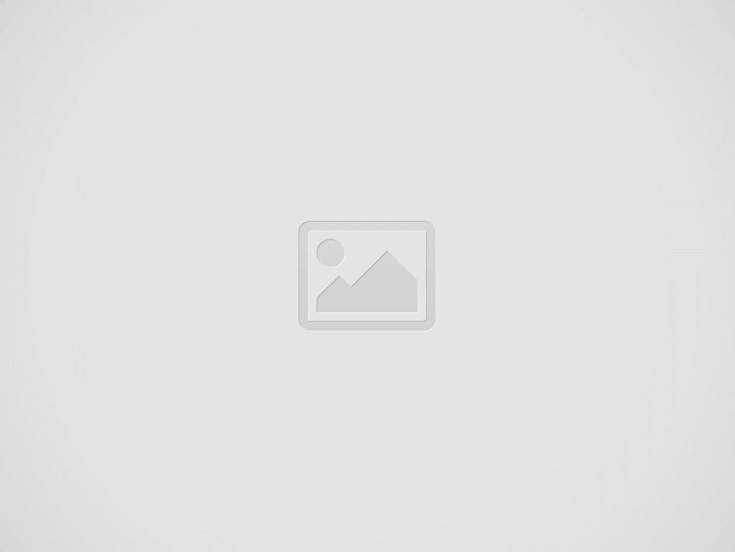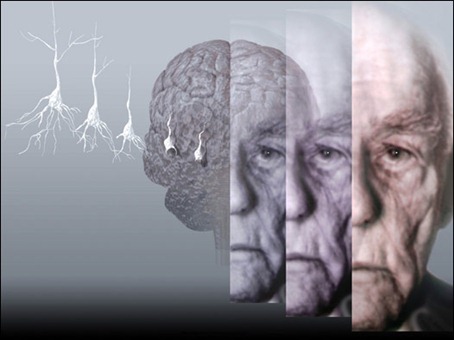Diamo volentieri spazio, in queste pagine, a un argomento difficile e a una lettura complessa, scientificamente rilevante. Il contributo è di Alessia Macrì, neo laureata, che ringraziamo per aver voluto condividere con noi una sintesi significativa della sua tesi di laurea. Gli amici grey-panthers amano approfondire gli argomenti e non hanno pregiudizi nell’escluderne alcuni. Tra i fantasmi all’orizzonte della terza età c’è sicuramente anche l’Alzheimer, ed è per questo che affrontiamo coraggiosamente l’argomento.
Paziente: “Magari mi vergogno a volte.”
Conversante: “Di che cosa?”
Paziente: “Mi sembra di non sapere parlare… non lo so, non lo so.”
La demenza di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa causata dall’accumulo patogeno di una particolare proteina (la beta-amiloide) in determinate aree cerebrali; tale eccesso proteico causa il blocco del rilascio di un particolare neurotrasmettitore (l’acetilcolina), da cui dipende il corretto funzionamento delle connessioni tra i neuroni. Col passare del tempo (il decorso della malattia può durare anche oltre 10 anni), in pratica, i neuroni non comunicano più fra di loro: tra le aree maggiormente colpite vi sono quelle adibite alla memoria e al linguaggio.
Che il malato Alzheimer faccia fatica – sempre più fatica – a parlare è cosa dolorosamente riconosciuta e, in particolare, ritengo che la consapevolezza che lo stesso malato ha circa i suoi problemi di comunicazione sia un dato ancora più straziante. Egli, di fatto, sa di non essere capito e tale coscienza di sé è sicura fonte di tristezza (Conversante: «Grazie a lei che ha accettato di parlare un po’ con me.» – «Paziente: Sono… faccio fatica io.» – «C: Sono?» – «P: Sono… mi vergogno a parlare.»).
Inizialmente ha “le parole sulla punta della lingua” (ad esempio: «dove sta lui? Sta dove c’è la… la… come si chiama… domani glielo dico»); poi le sue frasi si fanno brevi e sempre più spesso lasciate a metà («la campagna… la campagna è un lavoro… faticoso… allora poi, perché adesso, adesso ormai, adesso ormai è s… si comincia…»), fino a pronunciare soltanto quelle che paiono “parole a caso” («non so quello che dico… no siccome ho l’arule invecchiata… ronemida… tutto a posto ma… ma non sono mai riuscita a fare la centoventicinque… di là ce ne sono due… magari lo trovano…»), per infine arrivare a mugolii e quindi al silenzio. Ciò che invece ancora non è stato fatto è studiare approfonditamente le fasi di questo decadimento linguistico e i fenomeni che lo contraddistinguono.
La mia tesi di laurea ha dimostrato che il deterioramento cognitivo causato dal progredire della malattia corre parallelo al deterioramento linguistico: l’analisi del linguaggio rappresenta un nuovo, non ancora sfruttato né studiato, modo di monitorare l’andamento della malattia. La neurolinguistica ha individuato da tempo il legame tra la lingua e l’Alzheimer, ma ha studiato tale rapporto sempre da un punto di vista quantitativo (lunghezza delle frasi; percentuale dei nomi, degli aggettivi; numero di risposte corrette date a partire dalla somministrazione di test con prove di denominazione – quali animali conosci il cui nome inizia per F? – ); io, a partire dalla mia formazione umanistica di studentessa di Lettere, mi sono concentrata sull’analisi qualitativa della parola dei dementi.
Lo studio del linguaggio Alzheimer è stato condotto su 45 testi (trascrizioni di conversazioni registrate) e ha sondato ogni livello della lingua tenendo conto anche del grado di demenza dei parlanti (lieve-moderato, moderato-severo, severo). I fenomeni individuati variano di intensità nel corso del tempo riguardano: il lessico e la semantica, cioè le parole considerate singolarmente e nel loro significato; la morfosintassi, cioè il modo in cui le parole si formano (i meccanismi, ad esempio, da cui dipendono i verbi: parl-o, parl-i, parl-av–o, e i nomi: ross-o, ross-a, ecc.) e come vengono organizzate nella costruzione della frase; la stilistica la retorica, cioè le caratteristiche del discorso nel suo insieme.
È essenziale, in prima battuta, presentare quello che è uno dei tratti generali della lingua dei malati Alzheimer, e che influisce su tutti i livelli del parlato sondati nel mio lavoro; tale tratto consiste nella crescente e sempre più grave dissociazione tra la “coerenza” e la “coesione”: i pazienti riescono per molto tempo a formulare frasi ben costruite dal punto di vista morfosintattico e quindi formale (coesione), mentre molto presto diventano incapaci di comunicare, mediante queste frasi, concetti logicamente chiari e coerentemente comprensibili. In parole povere: nel corso della malattia si capisce sempre di meno cosa gli Alzheimer, quando parlano, vogliano dire, a cosa si riferiscano, anche se costruiscono frasi grammaticalmente corrette. Una frase del tipo «lui fa questo coso e poi lo porta di là per fare l’altra roba mia» è esemplificativa della dissociazione coesione/coerenza, perché è corretta, ma ha significato oscuro. Ancora, ecco un altro esempio: «adesso le figlie sono grandi… una è ufficiale una è da un’altra parte. L’ufficiale giudiziario da noi altri… no lontano. Vicino… Ho sempre fatto bene, mi è piaciuto tanto. Delle volte dico, professore! Che parola è! Non mi piacciono tanto quelle parole lì, e, me le dia buone altrimenti la mando via!». Formalmente si tratta di frasi ben costruite: gli accordi di genere e numero (le figlie sono grandi) e di soggetto e verbo (quelle parole lì non piacciono tanto alla parlante) sono solidi, ma il significato del discorso è inafferrabile: la mia tesi ha cercato di capire i meccanismi linguistici che comportano tale incomprensibilità.
Poiché, si diceva, la capacità di legare le parole tra di loro si conserva bene fino alla fase avanzata della malattia, i fenomeni più interessanti riguardano il lessico e la stilistica. Per quanto riguarda il primo livello, i tratti salienti che ho individuato possono essere riassunti mediante il seguente profilo: il lessico dei pazienti Alzheimer si impoverisce costantemente, ma non in maniera casuale né uniforme; il primo tipo di parola ad essere colpito è il nome: quelli astratti e i più difficili (di uso non comune) scompaiono in fretta, mentre quelli più resistenti sono quelli riferiti alla sfera familiare e domestica (ed è curioso che gli ultimi a scomparire siano “mamma” e “papà”, i primi pronunciati dai bambini).
Altro dato assai caratteristico è l’uso dei pronomi, cioè delle particelle che sostituiscono i sostantivi già emersi nel discorso, usate per evitare la ridondanza e le ripetizioni (“Quando ho visto Marco mi sono girata per salutarlo”); gli Alzheimer se ne servono in abbondanza, ma spessissimo non per sostituire nomi già noti: li inseriscono nel loro discorso come se dessero per scontato che gli interlocutori sappiano a che cosa essi si riferiscano (ad esempio: «vado a prenderlo e poi lo do a lei così glielo porta»; o ancora: «io stavo bene, a parte che sono vecchia… Stavo bene, però siccome mi avevano portato via i cosi… allora ho detto, lei me l’ha portato, è andata a cavarlo e poi me l’ha dato, allora io dovevo ridarle le scarpe. Ma le scarpe non è che lei me le ha rubate o io gliele ho date. Gliele ho date perché praticamente erano state portate via dal loro, erano in girò lì adesso… e allora non le ho prese.»); tale elemento, unito al sempre crescente uso delle parole passepartout (quelle estremamente generiche: cosa, coso, fare, roba, ecc., si osservi il seguente esempio: «adesso coso, ha preso un po’ di… un po’di cose» ), contribuisce ad aumentare l’incomunicabilità dei pazienti.
L’altro piano della lingua sicuramente molto interessante, dicevo, è quello della stilistica; ho notato: un altissimo tasso di ripetizioni, vale a dire che uno stesso concetto (“io sono di Milano” oppure “a me piace fare l’orto”:) si ritrova numerose volte nello stesso discorso. Il brano che riporto è necessariamente lungo, ma chiarisce efficacemente tale fenomeno (C= Conversante; P: Paziente; i numeri indicano il numero del turno verbale di riferimento):
5. C: E di solito cosa fai?
6. P: Niente, c’ho la mia casa, che abbiamo la casa fatta quasi quasi vicino al cimitero dalla parte del dietro del cimitero, niente, c’ho un pezzettino di giardino, un pezzettino di orto, mi faccio da mangiare…
7. C: Quindi ti occupi dell’orto.
8. P: Sì sì sì, quello mi piace, il giardino e l’orto mi piacciono. Niente… figli non ne ho, c’ho una sorella qui, ma c’hanno la sua famiglia perciò li vedo rare volte.
11. C: E tu, oltre ad occuparti dell’orto…
12. P: Quello è la mia passione! l’orto e il giardino, perché c’ho un bel pezzettino di terreno dietro la casa, un po’ sul davanti che mi faccio il mio giardino, la mia passione è quella lì!
15. C: Ti basta avere tutto quello che ti serve, insomma.
16. P: Certo certo, faccio un po’ di tutto, perché mi hanno insegnato di fare di tutto… poi son stata già abituata anche in campagna, c’ho il mio orto, mi piace il giardino, è così!
26. P: D’estate si andava a spigolare, a fare tutte le nostre cose, avevamo un bel pezzettino d’orto, a me piace il giardino e insomma il passatempo c’è.
30. P: […] comunque a me l’orto piace, il giardino mi piace tanto, c’ho la casa proprio la via che va al cimitero dal di dietro, a Gallarate, c’è altre due case e poi c’è il cimitero, basta.
38. P: Ma guardi, è bravo mio marito perché sarei una vigliacca di dire… è bravo, e così siamo sempre andati d’accordo… vede, anche essere senza figli, perché delle volte anche senza, basta andar d’accordo, anche in due si va bene lo stesso e così… mi piace fare l’orto, il giardino, perché per i fiori vado matta.
39. C: Certo te ne occupi tu.
40. P: Sì sì, perché mi piace tanto… lui andava a lavorare dove c’era da andare a lavorare, però io tra la casa e il mio giardino e il mio orto e così m’arrangiavo […]
53. C: Va bene Chiara, grazie!
54. P: Grazie cosa?
55. C: Di questa chiacchierata.
56. P: Vi ho insegnato se volete fare gli ortolani o i giardinieri!
Altra caratteristica è una significativa frequenza di filastrocche, rime interne alle frasi, modi di dire, proverbi, canzoncine spesso incoerenti con quanto si sta dicendo (sono tutte soluzioni stilistiche che valgono più per il loro suono che per il loro significato, ad esempio: «signora, deve mangiare la frutta», la paziente risponde: «bella o brutta son qui tutta»; o ancora «ciao Anna, che viene di notte con le calze tutte rotte»); ancora, ho notato una grandissima presenza di frasi sospese e bucate, in aumento al progredire della malattia (“io non so… perché… i bambini… quando ero giovane… lavorare… è così la vita) tipico della tendenza a “perdere il filo del discorso”.
I fenomeni linguistici emersi dall’analisi del parlato spontaneo dei malati Alzheimer rivelano che la patologia coinvolge anche la loro lingua, in modo significativo e variabile a seconda del grado di demenza. Essa si contraddistingue per una serie di tratti individuabili solo attraverso una sua analisi qualitativa, che studia la parola da ogni punto di vista. Ciò che mi sento di affermare con sicurezza, in qualità non solo di linguista, ma anche e soprattutto di persona che per mesi ha captato, studiando i discorsi dei pazienti Alzheimer, un dolore, una sofferenza e una consapevolezza delle proprie difficoltà nel comunicare a dir poco terribili, è che l’attenzione alla parola del malato non deve mai venire meno: per chi studia la malattia rappresenta, agli esordi, un elemento utile per la diagnosi e costituisce, lungo il decorso, uno strumento di monitoraggio dell’andamento della malattia; per chi la vive in qualità di caregiver professionale e non: la parola degli Alzheimer è sì una parola malata (che sarebbe utile conoscere a fondo mediante attraverso seminari e corsi formativi), ma non per questo inutile né da ignorare: noi non riusciamo a capire cosa i pazienti vogliono comunicarci, e questo è vero e doloroso, ma ciò non significa assolutamente che essi non abbiano né contenuti da condividere né esigenze da soddisfare. L’isolamento sociale e l’estinguersi delle relazioni con gli altri è – almeno in parte – dovuto anche alla tendenza a liquidare i disturbi del linguaggio dei dementi come causa della loro assoluta incapacità di comunicare: questo viene percepito dai pazienti stessi, e contribuisce alla depressione, molto diffusa tra gli Alzheimer.
Coltivare la comunicazione con i malati di Alzheimer è certamente difficile: non capire cosa un familiare ci sta dicendo – dopo aver condiviso insieme le parole di una vita– è una grande fonte di disorientamento e tristezza, senza dubbio; ma non per questo il paziente deve essere colpevolizzato dei suoi deficit linguistici. È necessario conversare con loro accantonando l’obiettivo (primario negli scambi verbali normali) di ricavare informazioni logiche, focalizzandosi invece – alla luce delle peculiarità della lingua individuate e analizzate nella mia tesi – su ciò che rimane, sulla parola come strumento sociale, come suono benefico e rasserenante, che permette al soggetto di non rinunciare a qualcosa di fondamentale per tutti gli esseri umani.
Quindi, per riassumere e concludere, gli elementi del binomio lingua e Alzheimer sono reciprocamente “utili” l’uno all’altro: la lingua, l’allenamento della parola e il mantenimento della conversazione sono utili al malato Alzheimer e a chi si prende cura di lui perché permettono il mantenimento di una parte importantissima della sua vita di relazione; inoltre, sono in corso studi che stanno valutando se l’esercizio della parola sia in grado non solo di rallentare il decadimento cognitivo, ma anche di contrastarlo. Dall’altro lato l’Alzheimer, inteso – da me linguista – come linguaggio alzheimeriano, è utile allo studio del linguaggio stesso, e permette di inaugurare e tener vivo un circolo virtuoso per cui l’attenzione alla parola dei dementi si traduce in un aumento del materiale linguistico da studiare, da analizzare e, si spera, da cui poter continuare a ricavare dati importanti circa la conoscenza e l’evoluzione di questa terribile malattia.
Una bella chiacchierata fa bene a tutti: chi non si sente meglio dopo aver parlato con qualcuno; e anche se non capiamo cosa i malati Alzheimer vogliono dirci, non importa, ascoltiamoli e parliamo con loro semplicemente perché a loro fa bene: sia come pazienti sia come persone, soprattutto come persone. Non trovo miglior modo per chiudere che lasciar loro la parola:
«il dottore mi diceva, parla parla… e se sono a casa da sola con chi parlo? Con chi parlo, con il muro?»; «ne ho tante cose da raccontare io…»; «mi piace, mi piace parlare…». La tenerezza e l’eloquenza di affermazioni come la seguente: «a me mi fa piacere parlare, dei nipoti, dei figli, degli strafigli» è semplicemente commovente.
(1) Tesi di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica Italiana, Università degli Studi di Torino aa 2013-2014- di Alessia Macrì