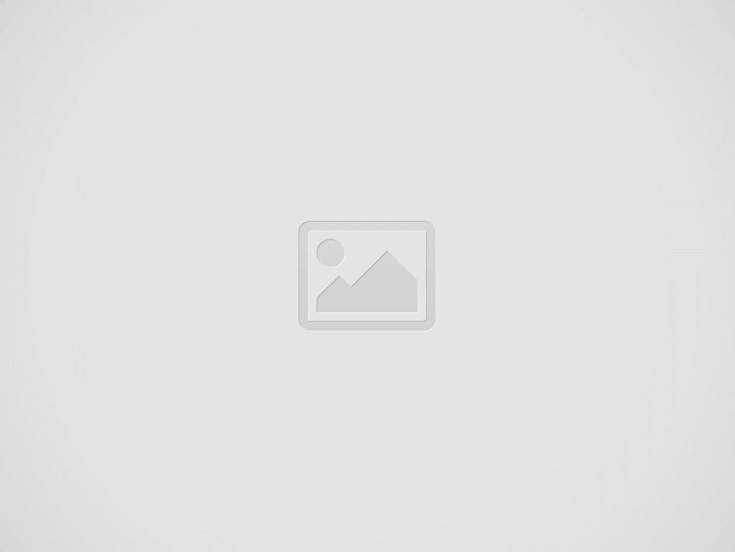Lei
regia e sceneggiatura: Spike Jonze, cast: Joaquim Phoenix (Theodore), Rooney Mara (Catherine), Amy Adams (Amy), Olivia Wide (ragazza dell’incontro alla cieca), Portia Doubleday (ragazza), Scarlett Johansson (Micaela Ramazzotti nella versione doppiata: voce di Samantha), durata: 126′.
Theodore scrive lettere d’amore e d’amicizia per conto terzi. Nella Los Angeles di un futuro imminente una società di servizi offre questa opportunità a chi è troppo impegnato o incapace di trovare le parole giuste per ogni situazione importante della vita (nascite, matrimoni, anniversari, lauree, viaggi ecc). Nel suo lavoro Theodore è bravissimo, tanto bravo a sbrogliare e mettere in bella scrittura le vite altrui quanto incasinato e impacciato nella propria: un matrimonio agli sgoccioli, pochi amici, avventure sentimentali di una sera, ma soprattutto un mondo virtuale fatto di chat, videogiochi e cybersesso.
Un ritratto molto verisimile del mondo che verrà dove tutti parlano e gesticolano per strada ignorandosi l’un l’altro perché immerso ciascuno in una propria realtà virtuale. Ciliegina sulla torta, Theodor si dota di un sistema operativo (OS, nell’originale) di ultima generazione in grado non solo di mettere finalmente un po’ di ordine nella sua confusionaria agenda quotidiana, ma capace di capirlo, di motivarlo o rimbeccarlo a seconda delle necessità. Proprio come una vera persona amica, anzi: come una compagna fedele e sincera. A tal punto che Theodor si innamora di “lei”. Della voce, calda e profonda, che gli parla e della “persona” che virtualmente si cela dietro quelle onde sonore.
Premiato con l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, il film di Jonze dopo una buona partenza si dilunga inutilmente (a che scopo, per esempio, la gita in montagna?) annacquando un po’ troppo la buona idea di fondo: il mondo virtuale dei clienti di Theodor non è poi così diverso dal suo mondo reale e per uscire dalle proprie angosce il (de)scrittore delle emozioni altrui deve alla fine guardare dentro se stesso e trovare le parole in prima persona. Senza più neppure l’aiuto di Samantha.
Phoenix ha la faccia giusta per l’inespressivo e scialbo Theodor e i comprimari fanno egregiamente la loro parte. Ottime le scene che rimandano a un futuro ormai alle porte, eccessivamente condizionato dalla cibernetica e che ha perso molto della sua purezza originale. Soprattutto quando sono in gioco i sentimenti.
Consiglio per gli acquisti: chi può (purtroppo solo nelle grandi città) veda il film in lingua originale con i sottotitoli. Oltre che una buona abitudine a prescindere, in casi come questi, in cui il sonoro ha un ruolo determinante e uno dei protagonisti è soltanto una voce, è meglio non perdere tutte le sfumature che il doppiaggio fatalmente sopprime.
CINETECA
L’uomo e l’intelligenza artificiale ovvero l’uomo e la macchina, il computer, l’automa. L’uomo e un oggetto meccanico, spesso con le sue stesse sembianze, ma privo di anima. Eppure quante volte, in letteratura e al cinema, i robot l’hanno cercata e perfino trovata, un’anima. Fino a sviluppare sentimenti, provare emozioni, fino a fondersi e confondersi con i loro stessi creatori. Come il sistema operativo Samantha di “Lei”.
Nel 1968 Stanley Kubrick aveva anticipato il tema in 2001 Odissea nello spazio con Hal 9000, il computer di bordo dell’astronave Discovery. Nell’epoca in cui i cervelli elettronici erano armadi che occupavano intere stanze, ma con capacità infinitesimali rispetto a un qualsiasi attuale Pc, il regista americano immaginava che l’intelligenza artificiale potesse prendere il controllo della missione e sopprimere l’intero equipaggio. Fino a essere disattivato dall’ultimo superstite (Keir Dullea) destinato perciò a perdersi a sua volta nell’infinito.
Più o meno l’opposto di quanto avviene invece nell’altrettanto celebre (ma assai meno rilevante) Blade Runner (1982) di Ridley Scott. Qui sono i replicanti (androidi del tutto simili agli umani) a tentare di emanciparsi e a essere perseguitati.
Altri “classici” della fantascienza in cui compaiono macchine simili a noi con ambizioni di entrare a far parte dell’umano consorzio sono i quattro film (dal 1994 al 2002) della seconda serie di Star Trek. In essi l’androide Data (Brent Spiner) è portatore di una “umanità” semplice, ingenua, a volte umoristica proprio per la sua totale assenza di sovrastrutture emotive. In robot, insomma, come il buon selvaggio degli illuministi.
Il desiderio di umanizzazione delle macchine e dei computer viene sviluppato in chiave ironica da due pellicole: Corto circuito (1986) di John Badham, e Corto circuito 2 (1988) di Kenneth Johnson. Il protagonista è un robottino cingolato (Johnny Five) progettato per scopi militari che termina il suo processo di umanizzazione e integrazione sociale con il giuramento sulla Costituzione Usa, come ogni nuovo cittadino. Nulla di strano: nient’altro che una “razza” in più nel melting pot americano.
Su un’ipotesi simile si regge anche il più serioso L’uomo bicentenario (1999) di Chris Columbus, tratto da un romanzo di Asimov. Il robot Andrew Martin (interpretato da Robin Williams) si umanizza progressivamente nel corso di due secoli sino a ottenere, ma solo in punto di morte, la sospirata “patente” di umanità. Del resto a distinguerci dalle macchine è proprio in nostro essere mortali.
Da Asimov è tratto, molto più liberamente, anche Io robot (2004) di Alex Proyas, con Will Smith. Ambientato nel 2035, quando i robot umanoidi sono ormai dei comuni “elettrodomestici”, punta decisamente sul thriller e l’azione piuttosto che sulle implicazioni etiche ed esistenziali connesse allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
A questo tema di fondo si rifà invece il cartone animato Il gigante di ferro (1999), di Brad Bird e Jeffrey Lynch, che racconta la tenera storia d’amicizia tra un bambino e un automa creato per distruggere, ma capace di sacrificarsi per gli umani grazie a un’acquisita coscienza morale.