Nel corso degli anni e nei vari generi cinematografici sono passati sugli schermi diversi film dedicati al mondo delle api. Si dividono sostanzialmente in due tipologie: si passa infatti dal film di serie B al cinema d’autore
The Beekeeper non che l’ultimo (per ora) dei film che, per un verso o per l’altro, tirano in ballo il mondo delle api, gli insetti più importanti per la vita dell’uomo. Può essere interessante vedere cos’altro è passato sugli schermi in fatto di api nel corso degli anni e nei vari generi cinematografici. Escludendo documentari e cartoni animati ne abbiamo contato una quarantina, incluso anche un piccolo numero in cui le api e il loro sistema sociale non compaiono in scena, ma vi figurano nella struttura narrativa in riferimenti o metafore culturali ed etologiche.
Numero non amplissimo, forse neppure tale da costituire un sottogenere autonomo, ma comunque sufficiente per prestarsi a qualche riflessione. A cominciare dal fatto che i film con o sulle api si dividono sostanzialmente in due tipologie, quasi uguali per numero, ma molto diverse tra loro quanto a risultati estetici. Si passa infatti dal B-movie (film di serie B) al cinema d’autore.
In apertura: Giochi nell’acqua
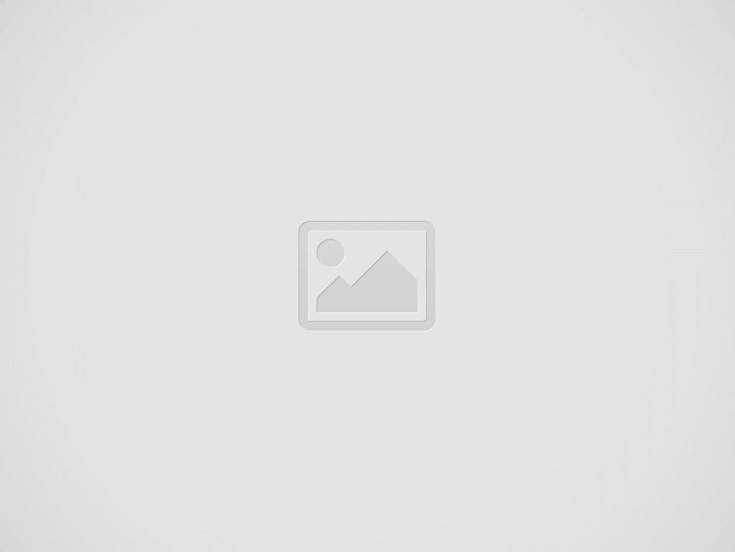

Thriller, fantascienza, horror, catastrofico
Cominciamo con il gruppo che rientra nella categoria detta minaccia animale, sottogenere, per lo più, di film horror, fantascientifici o catastrofici. All’origine del filone api assassine sta il film inglese The Deadly Bees (1967) diretto da Freddie Francis e distribuito in Italia con il titolo Il mistero dell’Isola dei gabbiani. Si tratta di un giallo più che di un horror, in quanto lo sciame omicida è una sorta di “arma impropria” in mano a un fantomatico killer di cui si deve scoprire l’identità. Anche a distanza di 57 anni un film che conserva un certo appeal proprio nell’ambito di quel classico filone del cinema britannico basato su misteri e omicidi.
Il sottogenere vero e proprio conosce invece il suo apice nel decennio dei ‘70 in concomitanza, e in qualche modo al traino, dei numerosi film congeneri di successo a partire dallo Squalo (1975) di Spielberg. Una mezza dozzina di titoli che non hanno certo fatto la storia del cinema, ma all’interno dei quali si possono trovare alcune peculiarità che meritano di essere segnalate.
L’invasione delle Api Regine (1973) di Denis Sanders può avere un qualche interesse come specchio del mutamento sociale avvenuto in America tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70. È l’epoca delle contestazioni e delle rivolte (studentesche, razziali, sessuali…) e Hollywood ha da poco abbandonato le norme di autoregolamentazione, note come Codice Hays, che dal 1930 avevano condizionato l’industria cinematografica con rigidissime regole etiche ed estetiche. Crollata la diga moralista, sullo schermo si cominciano a sentire parolacce e a vedersi seni nudi. L’invasione delle Api Regine si può collocare nel genere fantascienza sexy. L’ambiente è quello della provincia americana in cui si trova un laboratorio dove si svolgono segrete ricerche genetiche. La protagonista, versione femminile del classico scienziato pazzo, trasforma le mogli dei suoi colleghi in api assassine utilizzando il genoma degli insetti. Canonico il finale con salvezza dei “buoni” e perdizione dei “cattivi”.
Killer Bees, TvMovie del 1974 di Curtis Harrington, ha la sola peculiarità di avere nel cast, in una delle sue ultime, stanche interpretazioni, Gloria Swanson nel ruolo di Madame Van Bohlen, anziana imprenditrice agricola californiana che regge con pugno di ferro le sorti economiche dell’azienda e i destini familiari disponendo del misterioso potere di controllo su uno sciame di api.
Lo slogan di lancio del film Bees-Lo sciame che uccide (1976) di Bruce Geller, recita: “Uno sciame di morte è in libertà. E si sta dirigendo verso New Orleans!”. E in effetti uno sciame di api sfugge da una nave da carico e attacca la città del jazz durante le feste del mardi gras (martedì grasso). Gli unici in grado di fermare gli insetti-killer sono un vecchio sceriffo, un medico legale, la sua fidanzata entomologa e un ragazzo a cui piacciono le api. Particolarità: è l’unico ad aver avuto un sequel: Il terrore viene dal cielo (1978) di Lee H. Katzin.
The Bees, coproduzione statunitense-messicana del 1978 di Alfredo Zacarías (o Zacharias, all’americana), comincia invece con piglio documentaristico spiegando che cos’è l’ape africanizzata (apis mellifera scutellata), un ibrido creato da apicoltori di paesi tropicali passata poi dall’Africa al Brasile e da lì propagatasi nel resto del continente americano. Siccome si tratta di un insetto più aggressivo dell’ape mediterranea (apis mellifera) la fantasia degli sceneggiatori di Hollywood ha avuto buon gioco a trasformarla nel killer di cui ci stiamo occupando. Apocalittico l’epilogo, con tanto di invasione degli insetti nella sede Onu di New York dove uno dei protagonisti sta sostenendo, davanti alla solita platea incredula, che la mutazione delle api è una reazione della natura contro l’inquinamento e la distruzione degli ecosistemi provocata dall’uomo. A suo modo, un film ecologista ante litteram.
Dello stesso 1978 è Swarm-Lo sciame che uccide il film più ambizioso e famoso del filone. Il regista è Irwin Allen, specialista del genere fantascienza-catastrofico, produttore nel 1974 dell’Inferno di cristallo. L’intento era replicare il successo di quest’ultimo titolo tanto che si mette insieme un cast “stellare” con Michael Caine, Henry Fonda, Katharine Ross e Richard Widmark. Anche qui sono in ballo le solite api africanizzate, insensibili a ogni contromisura, che fanno strage di persone nel Texas fino ad assediare Huston come un vero e proprio esercito in assetto di guerra. Per contrasto, fa quasi tenerezza, nella sua retorica fanciullesca, la didascalia finale: “Le api assassine africane rappresentate in questo film non hanno nulla a che fare con le solerti, laboriose api domestiche americane a cui siamo debitori per la vitale opera di impollinazione dei raccolti che nutrono la nostra nazione”. L’eccessiva lunghezza, la debolezza della trama, alcune situazioni lambiccate, effetti speciali scadenti determinano però un clamoroso flop al botteghino che cala anche la pietra tombale sul genere per quasi un ventennio.
Si ricomincia infatti negli anni ‘90 con una serie di film che non aggiungono nulla a quanto detto finora né nella totale assenza di fantasia nei titoli né sul piano degli effetti speciali nonostante l’evoluzione tecnologica avvenuta nel frattempo. Film a basso costo, per lo più, ed estremamente ripetitivi nella struttura narrativa. Deadly Invasion: The Killer Bee Nightmare, produzione televisiva del 1995 di Rockne S. O’Bannon è un fanta-horror sulle solite api africanizzate che riprende il tema della rivolta della natura contro l’uomo unito al classico stilema claustrofobico di una famiglia assediata in casa da uno sciame di insetti. Bees (1998) di Gil Rosenblum, è un TvMovie horror. In Swarm-Minaccia dalla giungla (2001) di Jeff Hare con Rutger “Blade Runner” Hauer, api geneticamente modificate sfuggono al controllo e seminano morte a New York. Api assassine (2002) di Penelope Buitenhuis è un TvMovie canadese-americano insolitamente ambientato nel settentrionale Stato di Washington. Abbiamo poi Swarm 2-Sciame assassino (2003) di Paul Andersen seguito da Killer Bees-Api assassine (2008) di Michael Karen, thriller catastrofico di produzione tedesca ambientato a Maiorca (Isole Baleari), flop al botteghino. Tsunambee (2015) di Milko Davis è un horror fantascientifico-apocalittico con api assassine giganti. Volendo si potrebbe includere nel novero anche Black Swarm (2007) horror canadese di David Winning, che mescola insetti killer e zombie (discreti gli effetti speciali), ma gli imenotteri scelti in questo caso sono vespe e non api.
Dopo 50 anni dall’Isola dei gabbiani il cerchio si chiude tornando in Inghilterra con Bees Make Honey, dark comedy del 2017 diretta da Jack Eve, fratello di Alice Eve, l’interprete principale, rampolli entrambi dell’attore Trevor Eve, a sua volta incluso nel cast. Ambientato nel 1934 nella classica dimora di campagna, vede l’ispettore di polizia Shiro Shoerope (Wilf Scolding) indagare sul misterioso delitto avvenuto un anno prima di cui era rimasto vittima il marito della padrona di casa. Il tutto nella rutilante cornice della notte di Halloween con i giochi e il concorso per il miglior travestimento. Qui niente api, ma solo il nome della protagonista (Honey), il suo costume giallo a strisce nere e il gioco delle parti con lei, ape regina della casa, a tirare le fila del plot.
Similitudini e metafore
L’ultimo film citato introduce a quel piccolo gruppo di opere in cui non si percepisce nemmeno un ronzio – nel senso che le api non sono presenti in scena – ma entrano nella composizione drammaturgica del narrato come riferimento simbolico, evocazione storica o culturale, metafora, metonimia… Come nel caso della scena finale di Kill Bill: Vol. 2 (2004) di Quentin Tarantino in cui Bill (Davide Carradine) si rivolge a Beatrix Kiddo (Uma Thurman) con queste parole: “Sto dicendo che sei un killer. Killer per diritto di nascita. Lo sei sempre stata e lo sarai sempre. Trasferirti a El Paso, lavorare in un negozio di dischi usati, andare al cinema con Tommy, collezionare punti premio, quella sei tu che cerchi di camuffarti da ape operaia, sei tu che cerchi di mimetizzarti nell’alveare. Ma tu non sei un’ape operaia. Sei un’ape killer ribelle. E puoi bere tutta la birra che vuoi, mangiare hamburger e ingrassare il culo a dismisura, ma niente al mondo cambierà tutto questo”. L’alveare è dunque evocato come società organizzata, simbolo della quotidianità piccolo borghese, mentre all’individuo tocca la ribellione. Più recente, Honey Bee (2019), della regista canadese di origini indiane Rama Rau, è la storia di una baby-prostituta che lotta per emanciparsi dal suo protettore dopo essere stata mandata a vivere in una famiglia affidataria nell’Ontario settentrionale. Il film prende il titolo dal soprannome della protagonista Natalie “Honey Bee” Sorensen, interpretata da un’intensa Julia Sarah Stone.
Risalendo più indietro nel tempo emergono due titoli, quasi uguali tra loro ma relativi a film del tutto diversi per origine, contenuti e spessore artistico.
Il più remoto è Ape regina (1955) di Ranald MacDougall, classico melodramma tagliato a misura della diva (Joan Crawford) in una parte di donna fatale. Le api entrano nel racconto come metafora dei rapporti sentimentali e familiari dei personaggi in una sorta di suggestione culturale che umanizza i comportamenti animali. Con risultati peraltro modesti.
Ben diverso è invece Una storia moderna-L’ape regina (1963) di Marco Ferreri. “Con questa amara favola ho voluto rappresentare in chiave paradossale e satirica quanto squallida è una vita matrimoniale deviata da una volgare ed egoistica concezione del piacere e da un formalismo bigotto, frutto del tutto superficiale ed esteriore dei solidi ed immutabili principi della morale e della religione”. Così avverte la didascalia iniziale del film imposta dalla censura al regista. Che il dissacrante e ateo Ferreri parli di “solidi ed immutabili principi della morale e della religione” fa un certo effetto, ma il merito è tutto della censura che spiana la strada a un’offensiva giudiziaria culminata nel rinvio a giudizio del regista per offesa al pudore e vilipendio della religione di Stato.
Attraverso le vicende matrimoniali di Alfonso Ercolani (Ugo Tognazzi), Ferreri scardina il concetto tradizionale della famiglia rendendola il crogiolo di nevrosi, tare, violenze che la società, basata sul “contratto sociale”, esercita nei confronti dell’individuo e della sua libertà. Al mero scopo di perpetuazione della specie. Prima e dopo il matrimonio Alfonso è infatti circondato da preti, frati e suore con cui è imparentata sua moglie Regina (Marina Vlady) che lo guidano e lo indirizzano alla procreazione. Ferreri appaia uomini e animali al livello istintuale più basso, convinto che lo “spirito” che ci anima non sia molto diverso da quello che guida, per esempio, l’intelligenza collettiva di un alveare. Non per nulla la parabola umana e sentimentale del protagonista si conclude sulla sua lapide cimiteriale in concomitanza con la nascita del tanto sospirato erede.
Miele e alveari sono invece metafora di pacificazione e riconciliazione nel film di Nanni Moretti Tre piani (2021). Gli insetti compaiono all’epilogo della storia di Vittorio Bardi (Nanni Moretti), sua moglie Dora (Margherita Buy) e il loro figlio Andrea (Alessandro Sperduti). Dopo un periodo trascorso in carcere a seguito di un incidente stradale in cui, ubriaco, aveva travolto e ucciso una donna, Andrea rompe i rapporti con i genitori fino al momento in cui la madre, rimasta vedova, lo ritrova in una sperduta fattoria della campagna laziale con una compagna e un figlio neonato. L’incontro, ancora una volta burrascoso, avviene nel luogo in cui il giovane alleva api. Di ritorno in città, Dora si reca per la prima volta a casa del marito della vittima per una tardiva, anche se doverosa richiesta di perdono e qui scopre, attraverso un barattolo di miele, che già da tempo suo figlio aveva compiuto lo stesso passo. Anche se i due incontri non sortiscono gli effetti sperati, il prodotto degli alveari resta il simbolo di nuovi, più dolci rapporti tra esseri umani in conflitto.
Spagna: Franco prima e dopo
Nel 1973, anno di uscita del film di Victor Erice Lo spirito dell’alveare, benché ormai vecchio e malato, Francisco Franco è ancora saldamente al potere e la struttura dello stato spagnolo è sostanzialmente identica a quella uscita dalla Guerra Civile (1936-39) e, tra le altre cose, il governo esercita ancora un rigido controllo sulle attività culturali inclusa la produzione cinematografica. Tra le maglie della censura passa però questo racconto libertario ambientato in una realtà rurale a un anno dalla conclusione del conflitto. Qui vive un’agiata famiglia composta da Fernando (Fernando Fernán Gómez), Teresa (Teresa Gimpera) e le loro due bambine, Isabel (Isabel Tellería) di 8 anni e Ana (Ana Torrent, qui al suo esordio), di 6. Tra i genitori c’è una discreta differenza d’età e molta indifferenza. Le due sorelline sono inseparabili e curiosissime, capaci di inventare storie magnifiche. Specialmente dopo aver visto in un cinema ambulante il Frankenstein (1931) di James Whale con Boris Karloff. Un covile in mezzo alla campagna è l’immaginario nascondiglio di altrettanto immaginari mostri simili a quello visto sullo schermo. Fino a quando diventa effettivamente il rifugio di un giovane repubblicano braccato dalla Guardia Civil. Forse un antico amore di Teresa nonché destinatario delle numerose lettere che la donna scrive quasi ogni giorno.
La prima di queste lettere offre la chiave di lettura del film: “È difficile tornare a provare nostalgia dopo quello che ci è toccato vivere in questi ultimi anni. Però, a volte, quando guardo attorno a me e scopro tante assenze, tante distruzioni e allo stesso tempo tanta tristezza, qualcosa mi dice che forse con quelle se ne è andata la nostra capacità di sentire davvero la vita”.
La principale attività di Fernando è l’apicoltura. Riprodotta anche tra le mura di casa mediante un’arnia di cristallo, che consente di vedere i favi. Qui Fernando siede quando scrive su un libretto alcune considerazioni sul suo lavoro. Testo che controbilancia la lettera della moglie di cui abbiamo detto: «Qualcuno a cui ultimamente mostravo il mio alveare di cristallo lo guardava e, una volta passato lo smarrimento, non tardò a distogliere lo sguardo in cui si leggeva non so quale triste spavento». Sono parole tratte, come lo stesso titolo del film, dal libro Vita delle api dello scrittore francese Maurice Maeterlinck (1862-1949) e stanno chiaramente a indicare l’alveare come metafora della società umana. In particolare della società spagnola appena plasmata dal fascismo in cui “smarrirsi” e da cui “distogliere lo sguardo”.
Ben altra Spagna è quella in cui, nel 1982, Mario Camus gira La colmena (L’alveare), Orso d’oro a Berlino, tratto dall’omonimo romanzo di Camilo José Cela (1916-2002). Il narrato si struttura come una storia a più voci nella Madrid del 1942, dunque tre anni dopo la fine della Guerra Civile. Catalizzatore delle varie esistenze è il caffè La Delicia di doña Rosa, energica matriarca che ha in camera il ritratto di Hitler. Qui troviamo i vincitori e i vinti. I primi sono gente volgare, prepotente e senza scrupoli che fa soldi facili con affari illegali. I secondi dei poeti bohemien, perennemente in bolletta, la cui vita è condizionata dalla repressione politica e dalle difficoltà economiche.
Tema centrale del film (e del romanzo) è l’incertezza dell’esistenza. I personaggi sono esseri impauriti, senza prospettiva, dall’esistenza vuota, conformista, volgare e, in molti casi, indegna. Come le giovani che si prostituiscono perché non hanno altra via d’uscita alla miseria materiale e morale in cui sono precipitate. Senza api in scena, l’alveare del titolo non è altro che la città, spazio personificato che si fonde con i suoi abitanti. Elemento sottolineato nella sequenza finale: una lunga carrellata all’interno del caffè mentre la voce off di Ricardo Sorbedo (Francisco Rabal), leader dei poeti, recita questo brano del romanzo: «La mattina, quella mattina eternamente ripetuta, sale come un verme nei cuori degli uomini e delle donne della città colpendo, quasi con tenerezza, gli sguardi appena svegli. Quegli sguardi che non scoprono mai orizzonti nuovi, nuovi paesaggi, nuove decorazioni. La mattina, quella mattina eternamente ripetuta, gioca un poco, senza dubbio, a cambiare il volto della città: questo sepolcro, questa cuccagna, questo alveare…».
Tra i temi che affiorano con sempre maggiore frequenza nel cinema contemporaneo dei paesi occidentali vi è quello relativo all’identità o alla fluidità (queer) di genere. Inclusi bambini e adolescenti. Ne tratta anche 20.000 especies de abejas (20mila specie di api, 2023) opera prima della regista spagnola di origini basche Estibaliz Urresola Solaguren. Ambientato in una casa rurale dei Paesi Baschi ruota attorno l’apiario di due sorelle, Lita (Itziar Lazkano) e Lourdes (Ane Garbarain), che allevano gli imenotteri e praticano anche l’apiterapia. Per loro l’alveare non è solo attività lavorativa, ma anche luogo quasi mistico di riti ancestrali come quello di comunicare agli insetti la nascita di un nuovo membro della famiglia. Durante l’estate Ane (Patricia López Arnais), figlia di Lita, in crisi lavorativa e sentimentale, torna al paesello con i suoi suoi tre bambini, l’ultimo dei quali, Aitor, otto anni, vuole vestirsi con abiti femminili e farsi chiamare Lucia. Dunque tre generazioni di donne a confronto, l’ambiente chiuso e retrogrado della provincia, ma anche l’esempio della comunità dell’alveare governata da una regina, consentono il necessario rimescolamento di carte che fa riflettere ciascun personaggio sul proprio destino.
Alla fiera dell’Est
Altro quadrante geografico e altra dittatura: il comunismo in Europa Orientale fino alla caduta del Muro di Berlino, nel 1989. Sei anni prima il cecoslovacco Juraj Jakubisko gira L’ape millenaria, film che mette in scena la saga di una famiglia contadina slovacca attraverso tre generazioni negli anni tra il 1887 e il 1917, quando il paese apparteneva all’Impero Austroungarico. Il patriarca, Martin Pichanda (Jozef Kroner), è un apicoltore e la saga della famiglia è assimilata alla vita di uno sciame del suo alveare. La madre (ape regina) simboleggia le radici della casa e della nazione, la forza della tradizione. Il destino dei vari membri della famiglia è fatto d’amore, speranza, lavoro difficile, ma anche tragedie come la crisi economica, la guerra, l’odio politico. «Il soggetto riguarda il periodo della mia infanzia, la sua natura e la sua magia – ha detto il regista -. È il mio sguardo di bambino sugli avvenimenti storici che hanno coinvolto la generazione dei miei genitori e dei miei nonni».
Mastroianni apicultore
Altro film molto interessante è Il volo (1987) del regista greco Theòdoros (Theo) Anghelòpoulos che qui raggiunge uno dei risultati più maturi e compiuti della sua poetica. Sceneggiato con Tonino Guerra e ambientato in una Grecia invernale grigia, piovosa e fredda, narra la tragica odissea senza approdo di Spiros (Marcello Mastroianni), maestro elementare, che dopo il matrimonio della figlia minore decide di tagliare ogni relazione con la famiglia e tornare all’antico mestiere dei suoi antenati: l’allevatore di api. Caricate le arnie su un autocarro percorre le strade secondarie del paese secondo antichi tracciati utili agli insetti. Il percorso diventa ben presto una discesa agli inferi. Antichi amori e amicizie dissolte, vecchi ricordi di gioventù, legami familiari spezzati e non più riannodati, squallide locande e alberghi fatiscenti costellano il cammino di Spiros la cui cupa esistenza non viene rasserenata neppure dalla giovane globe trotter (Nadia Mourouzi) che lo affianca per un lungo tratto e con la quale vive una storia d’amore malato. Quando capisce di essere ormai privo di un futuro, Spiros si consegna alla furia delle api da lui stesso scatenata.
Storie di vita nel profondo Sud americano
Benché la cinematografia americana si sia occupata di api soprattutto nell’ambito del B-movie, non mancano un paio di opere che possiamo invece ascrivere al cinema d’autore. Il primo è L’oro di Ulisse (1997), scritto e diretto da Victor Nuñez, regista indipendente che vive in Florida dove ha ambientato questa storia minimalista, girata a basso costo (2,7 milioni di dollari) prodotta da Jonathan Demme. La storia vede il classico quiet man (uomo tranquillo) invischiato suo malgrado in faccende losche dalle quali si deve districare salvando se stesso e suoi cari. Ulysses “Ulee” Jackson (Peter Fonda) è un apicoltore, veterano del Vietnam, vedovo, sulla cinquantina, che deve crescere due nipotine, Casey (Jessica Biel), adolescente inquieta e ribelle, e la più piccola Penny (Vanessa Zima). Il loro papà, Jimmy (Tom Wood), figlio di Ulee, è in carcere mentre la madre, Helen (Christine Dunford), tossicodipendente e sbandata, vive con due vecchi amici e complici del marito, Eddie Flowers (Steven Flynn) e Ferris Dooley (Dewey Weber), che la sfruttano. Nella casa accanto a quella di Ulee vive l’infermiera Connie Hope (Patricia Richardson) che avrà un ruolo rilevante nello scioglimento del plot e, forse, nella vita di Ulee. Nuñez ha dichiarato di amare molto i film neorealisti italiani soprattutto per la loro caratteristica di mettere in scena «Il dramma delle vite ordinarie». Anche il suo film presenta un aspetto simile, rafforzato da un’intensa interpretazione di Peter Fonda che qui ricorda molto alcuni personaggi del padre Henry. Detto delle qualità non bisogna però nascondere alcuni limiti del film. Una colonna sonora troppo convenzionale, per esempio, e la psicologia eccessivamente schematica di alcuni personaggi come l’adolescente Casey, i “vilain” Eddie e Ferris e la “buona samaritana” Connie.
Più ambizioso (e costoso) del precedente, ma forse meno riuscito, è La vita segreta delle api (2008) della regista di colore Gina Prince-Bythewood. Storia di amore e violenza collocata nel 1964 in South Carolina ovvero nel momento storico in cui il presidente Lyndon Johnson firma la Legge sui Diritti Civili che, dopo anni di violenze razziste, garantisce agli afroamericani pari dignità rispetto agli altri cittadini. Qui si racconta di una quattordicenne bianca, Lily Owens (Dakota Fanning), che scappa di casa con la governante nera Rosaleen Daise (Jennifer Hudson) per sottrarsi a un padre violento (Paul Bettany). Le due fuggiasche trovano rifugio presso tre sorelle di colore che anni prima avevano accolto e aiutato la madre di Lily. August Boatwright (Queen Latifah), la matriarca, alleva api e insegna alla ragazzina il senso della vita con la classica metafora: «Devi imparare che l’apiario ha una sua etichetta. Il mondo non è che un alveare gigantesco e le medesime regole si applicano a entrambi i luoghi». Film di buoni sentimenti, a tratti eccessivamente “melenso”, presenta caratteri stereotipati e la tesi di fondo, ossia la dignità e l’emancipazione della popolazione nera degli Stati Uniti, è schematica e convenzionale.
Uno sguardo dall’Islam
In un’edizione di Terra Madre/Slowfood, la rassegna torinese dedicata alla biodiversità e all’agricoltura sostenibile, sono stati presentati i mieli della valle del Firtina. Si tratta di una remota area rurale della Turchia vicina al confine con la Georgia. Qui è ambientato il film di Semih Kaplanoglu intitolato Bal (miele, 2009), terzo capitolo della cosiddetta Trilogia di Yusuf iniziata nel 2007 con Yumurta (uovo) e proseguita nel 2008 con Süt (latte). Mai uscita in Italia, la trilogia è disponibile in cofanetto dvd in edizione inglese con i titoli di Honey, Milk ed Egg. Vale la pena considerare i tre film nel loro insieme anche perché il regista procede a ritroso. In Yumurta (uovo) l’affermato poeta Yusuf torna nella sua città natale, che non visitava da anni, alla morte della madre. Una ragazza, Ayla, lo aspetta nella sua vecchia casa ormai fatiscente. Yusuf non sapeva dell’esistenza di questa lontana parente che viveva con sua madre da cinque anni. In Süt (latte) Yusuf è un neolaureato incerto sul suo futuro. Scrivere poesie è la sua più grande passione e alcune delle sue liriche sono state pubblicate su piccole riviste letterarie. Ma per il momento, continua a lavorare nell’azienda lattiera del villaggio dove vive con sua madre, vedova. Bal (miele) arriva all’infanzia di Yusuf quando, a sei anni, inizia la scuola elementare. Suo padre Yakup (Erdal Beşikçioğlu) è apicoltore, un mestiere rischioso perché deve arrampicarsi con lunghe corde sulle cime di altissimi alberi dove si trovano gli alveari. Ma l’annata è scarsa e l’uomo decide di portare le arnie in una zona ancora più impervia. Un giorno la mamma di Yusuf inforna dei biscotti per accogliere il marito di ritorno dai monti, ma lui non arriva. Un ramo spezzato rivela cosa è successo e Yusuf, quando capisce l’accaduto dall’affollarsi degli amici sulle scale di casa e dalle lacrime della madre, si allontana di corsa, solo, con gli occhi spalancati nel buio della notte. Orso d’oro a Berlino 2010.
Per una strana coincidenza, dieci anni dopo, a vincere l’Orso d’oro della kermesse berlinese è un altro film proveniente dall’universo islamico (in questo caso sciita, non sunnita) dove le api hanno un ruolo. Si tratta di Il male non esiste (2020) di Mohammad Rasoulof, regista iraniano dissidente, più volte ospite delle patrie galere e nel mirino del regime. Il film verte su un tema scabroso: la pena di morte. È noto che l’Iran è un paese stabilmente in cima alle classifiche mondiali degli “omicidi di stato”. Molto meno noto invece il fatto che l’esecuzione delle sentenze capitali sia spesso affidata a soldati di leva, ossia ragazzi normali, obbligati a prestare il servizio militare e quindi anche questa inumana corvè. Il film è suddiviso in quattro episodi, ciascuno dei quali sviluppa il tema da una diversa angolazione. Le api entrano in scena nel quarto, ambientato in una remota fattoria dell’altopiano iranico dove una coppia di mezza età alleva questi insetti. E dove arriva per qualche giorno una nipote venuta dalla Germania. Le api rappresentano una delle poche forme di vita in grado di sopravvivere al clima semidesertico dell’ambiente circostante e la loro cura si connota come una parentesi bucolica all’interno di un dramma, personale e collettivo, incombente dalla prima all’ultima inquadratura.
Perfida Albione
Peter Greenaway, regista tra i più anomali ed eccentrici del panorama internazionale ha messo in scena le api in Giochi nell’acqua (1988) di cui il regista ha detto: «È la storia di tre donne che uccidono i rispettivi mariti, uno nel bagno, uno in mare, uno in piscina. È una favola nera e ironica per adulti, in parte inventata da bambini innocentemente ossessionati dal sesso e dalla morte, specialmente dalla morte. È un racconto poetico e amorale, raccontato in forma di morale per ribadire la convinzione che i buoni sono raramente ricompensati, i cattivi rimangono spesso impuniti e gli innocenti sono sempre vittime». In linea generale si può concordare con l’autore su questo breve compendio della trama e sul suo significato.
Tra i protagonisti, Smut, un ragazzino di 13 anni, è colui che appunto inventa i giochi più disparati su cui spesso si dipanano le vicende degli adulti. Appassionato entomologo (come lo stesso regista in gioventù), Smut, compare a un certo punto in veste di apicoltore, ma di un genere del tutto particolare: lui infatti non accudisce gli insetti, ma li conta. Come, in altri momenti, conta i peli del mantello di un cane o le foglie di un albero. D’altra parte l’intero film è scandito dalla successione numerica da uno a cento. Nel film, le api si collocano all’interno di un affollato bestiario che comprende, oltre a una grande quantità di insetti di cui Smut va a caccia, anche lumache, ragni, uccelli, pesci, mucche e un onnipresente gregge di pecore. Tra i giochi inventati da Smut ce n’è uno che le riguarda: il Gioco delle api negli alberi. “Si tratta – spiega il ragazzino – di una variante del Gioco delle sedie e viene bene con una musica da funerale all’aperto. L’obiettivo è sedersi su una sedia vuota quando si ferma la musica. Se la sedia era stata occupata dalle api si perde un punto”. Nella sequenza successiva le api ritornano per un breve momento quando Smut raggiunge le tre donne omicide in piscina e mostra loro due api nel palmo della mano. Sul dorso di ciascuna è dipinto un numero, il 45 e il 46 mentre il 42 era dipinto su un’arnia. Numeri appartenenti alla sequenza che scandisce lo sviluppo narrativo. Dunque nel bestiario di Greenaway le api hanno un rilievo un poco eminente rispetto agli altri insetti. Del resto, afferma ancora Smut: «Quando muore qualcuno bisognerebbe comunicarlo alle api».
Quasi fosse una postilla al film precedente, Greenaway torna alle api in Il bambino di Mâcon (1992). Si tratta di due brevi accenni, collocati però in momenti topici dello svolgimento narrativo. Il primo cade all’inizio del secondo dei tre atti in cui si sviluppa il racconto, quando il bambino ha raggiunto i tre-quattro anni, viene considerato miracoloso e fatto oggetto di preghiere e richieste di grazie. Davanti a lui sfilano i questuanti. Per primi arrivano dei porcari, con relativo codazzo di animali, subito seguiti da quattro apicoltori con arnie di paglia dalla tipica forma ogivale. Nella simbologia del regista non è un caso che l’animale immondo per eccellenza della tradizione biblica preceda le creatrici del “cibo degli dei”. Sotto forma di metafora le api ritornano poi, al termine della scena, nel dialogo su “scienza e fede” tra la sorella del bambino e il figlio dell’arcivescovo. Costui dubita dei miracoli attribuiti al bambino al che la sorella gli ribatte che la gente, invece, ci crede e «I campi sono rigogliosi e le coppie si riproducono come api nell’alveare». «Coincidenze… L’opera di Dio non ha niente anche fare con te e col bambino» replica lo scettico, dopo di che il racconto culmina nella scena in cui la sorella seduce il figlio del vescovo e in una simbolica stalla gli si offre perché la renda «Da santa vergine a santa donna». È la chiave di volta del film, il ribaltamento di segno operato dal regista sul dogma cattolico della maternità virginale di Maria alla luce delle recenti scoperte della scienza. Oggi infatti, grazie alle tecniche di concepimento artificiale e procreazione assistita, è tecnicamente possibile far nascere una creatura da una donna conservandone la verginità.
Anche un altro noto autore inglese, Bill Condon, si è misurato con le api. Nel suo caso in maniera molto più lieve. Mr Holmes-Il mistero del caso irrisolto (2015) è una garbata commedia che mette in scena in maniera piuttosto anomala il famosissimo detective creato da Conan Doyle. Un crepuscolare Sherlock Holmes (Ian McKellen), affaticato, alle prese con gli acciacchi della quarta età e, in particolare, con la perdita di memoria, vive da tempo in campagna allevando api, convinto che la pappa reale possa rallentare i processi degenerativi dell’organismo. Con lui abita la governante irlandese Mrs Munro (Laura Linney) e suo figlio Roger (Milo Parker), un ragazzino dotato di spirito, intuito e acume superiori alla sua età. Siamo nel 1947 e Holmes ha 93 anni. Ma il passato ritorna, sotto forma di vecchi fogli annotati, che il curioso Roger legge con grande disappunto del vegliardo. Tra i due però ben presto si instaura un legame di simpatia, cementato anche dalla comune passione per l’apicoltura e dal mistero da risolvere relativo a una strana moria negli alveari.
Tell It to the Bees di Annabel Jankel è una produzione inglese del 2018, non uscito in Italia, che porta sullo schermo l’omonimo romanzo del 2009 di Fiona Shaw. La storia è ambientata in Scozia nel 1952 ed è narrata dal punto di vista di uno dei protagonisti, Charlie Weekes (Gregor Selkirk), un ragazzino di 12 anni. Suo padre Robert (Emun Elliott) è un reduce di guerra incapace di reinserirsi nella società e che maltratta la moglie Lydia (Holliday Grainger) la quale trova un appoggio solo in Jean Markham (Anna Paquin), nuovo medico condotto del paese e apicultrice. A unire le due donne è proprio Charlie che per primo si interessa agli insetti della dottoressa, ai quali racconta tutti i suoi segreti. L’amicizia tra le due donne si trasforma presto in un sentimento più profondo che, venuto a galla, genera naturalmente la riprovazione sociale dell’intera comunità e persino un tentativo di stupro di Jean da parte di Robert, sventato però da Charlie che scatena le api contro il padre. Alla fine tuttavia le due donne devono lasciarsi e Lydia parte con il figlio tra le lacrime dell’amica.
Storie dai Balcani
Storie di e con api anche dal mosaico di stati ed etnie usciti dallo sgretolamento dell’ex Jugoslavia e, più in generale dall’area balcanica. Honeyland (2019), di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, proviene dalla Macedonia del Nord, paese dove, accanto a slavi e albanesi, sopravvive una piccola minoranza di lingua turca e religione musulmana. A questa etnia appartiene Hatidze Muratova, donna sulla cinquantina, nubile, che accudisce l’anziana madre Nazife in un villaggio abbandonato di casupole in pietre a secco senza acqua corrente né elettricità. Siamo a qualche ora di autobus da Skopje, la capitale, ma qui il tempo sembra essersi fermato. O meglio: Hatidze lo scandisce giorno per giorno con i ritmi ancestrali della raccolta del miele da favi selvatici o da rudimentali arnie domestiche. Mantenendo i ritmi delle stagioni e, soprattutto, prelevando lo stretto necessario per vivere, per curare gli acciacchi della madre e concedersi qualche piccolo lusso, come una tintura per i capelli ormai ingrigiti che finiscono comunque sotto il velo islamico. Sicuramente senza saperlo, Hatidze applica il complicato Protocollo di Nagoya stilato dalle teste d’uovo di mezzo mondo in fatto di «Accesso alle risorse genetiche e all’equa condivisione dei loro benefici». In parole povere coltiva e mantiene la biodiversità. Ma anche il “piccolo mondo antico” di Hatidze non è esente dai rischi della globalizzazione. Rappresentato dall’esuberante famiglia Husein, nomadi che si insediano nei terreni incolti del suo villaggio con la loro mandria. Della sua stessa etnia, con la sua stessa lingua, ma lontani anni luce dalle sue radici. Specialmente quando il capofamiglia viene tentato dal diavolo più suadente dell’inferno capitalista: il profitto. O meglio: il profitto facile sotto le spoglie di un corpulento grossista di miele. Honeyland non è un documentario, anche se viene spacciato come tale per l’impiego di attori non professionisti. C’è una storia, una tesi, una dialettica anche nelle immagini che coprono l’intero arco dell’anno con le relative stagioni. Ci sono conflitti e complicità (tra Hatidze e uno dei figli di Husein, per esempio) e c’è soprattutto il senso autentico della vita.
Hive (Alveare, 2021) è l’opera prima della regista kosovara Blerta Basholli coprodotto da Kosovo, Macedonia del Nord, Albania e Svizzera. Il titolo della distribuzione internazionale fa riferimento all’alveare mentre quello originale (zgjoi=svegliatevi in albanese) rimanda piuttosto all’azione della protagonista nel contesto rurale della comunità in cui vive. La storia si basa sulle autentiche vicende di Fahrije Hoti, vedova delle guerre nei Balcani il cui marito, scomparso nel 1999, figura ancora nell’elenco dei dispersi. L’alveare del titolo è quello che Fahrije (Yllka Gashi) deve mandare avanti guadagnandosi una certa dose di punture per l’inesperienza. Il “risveglio” è invece quello che la donna impone a se stessa, alla sua famiglia, ad altre donne nella sua stessa condizione e, infine, all’intero villaggio governato dalle regole non scritte secondo cui le donne prive di marito devono restarsene a casa e non possono mandare avanti attività economiche. Dopo il miele, Fahrije dà impulso a un’altra attività produttiva: la preparazione dell’ajvar, la tipica salsa kosovara a base di peperoni. Senza mai smettere di battersi per ottenere gli elenchi degli uomini scomparsi e dei luoghi delle loro sepolture. Una storia, quella della vera Fahrije, che ha conosciuto un autentico lieto fine, con la cooperativa Kb Krusha che dà lavoro a un centinaio di donne.
Il bestiario di don Luis
Tra i film più remoti in cui le api abbiano un ruolo figura Las Hurdes-Terra senza pane mediometraggio che Luis Buñuel gira tra aprile e maggio del 1933 in una delle zone rurali all’epoca più arretrate ed emarginate della Spagna. Sono anni cruciali nella vita del paese. All’indomani della vittoria delle sinistre alle elezioni spagnole del 1931, le prime dopo la dittatura di Miguel Primo de Rivera (1923-1930), viene proclamata la Repubblica e il re Alfonso XIII costretto all’esilio. Con i soldi vinti alla lotteria da un amico anarchico il regista realizza questo pamphlet per immagini contro la condizione di degrado, ignoranza e malattia in cui versa ancora la popolazione più povera del suo paese. Può sembrare strano che un convinto repubblicano come Buñuel giri un film di denuncia così aspro proprio quando viene instaurata la repubblica, ma l’intento è palese: denunciare capitalismo e religione come le principali forme di oppressione dell’uomo sull’uomo. In buona sostanza il tema sviluppato dal film è la giustizia sociale. Che ovviamente prescinde dalla forma di governo. Ne risultano 32 minuti di arringa antropologica tanto forte che le deboli autorità della neonata democrazia iberica non hanno il coraggio di mostrare al mondo quelle immagini. Privo del nulla osta spagnolo, il film viene ultimato con la sonorizzazione a Parigi nel 1934 e uscirà solo in Francia due anni dopo, alla vigilia di quella Guerra Civile che spazzerà via il sogno repubblicano.
“La principale industria alimentare delle Hurdes è l’apicoltura – spiega la voce “off” che commenta le immagini – però la maggior parte delle arnie non appartiene agli Hurdanos. Inoltre, il miele che le api estraggono dai fiori di brughiera, è molto amaro. In primavera si trasportano le arnie in Castiglia. In quel periodo è normale imbattersi muli o asini carichi di alveari. Che a volte cadono causando la rabbiosa reazione degli insetti. E il regista ci mostra una di queste scene. È piuttosto breve (poco più di un minuto), ma di una violenza inaudita, pari solo alla denuncia che vuole sollevare con la metafora del “miele amaro”. Come dire: nelle Hurdes neppure il più dolce degli alimenti resta tale perché le condizioni di vita non lo permettono. Sulla genesi e la realizzazione di Las Hurdes nel 2018 è stato realizzato un bellissimo cartone animato dal titolo Buñuel nel labirinto delle tartarughe per la regia di Salvador Simó. Un garbato “omaggio” a un grande poeta dello schermo che include anche alcune sequenze originali del film.
Parlando di Violenza per una giovane (1960) il regista ha detto: “Il rifiuto del manicheismo fu, probabilmente, il motivo principale dell’insuccesso del film. Presentato a New York, fu attaccato da tutti. Anzi, non piacque proprio a nessuno. Io feci questo film con amore e dedizione, ma non ebbi fortuna. Il sistema morale non poteva accettarlo. Ma neppure in Europa ebbe successo e oggi non si proietta quasi più”. Nonostante la scarsa fortuna critica e l’ancor più scarsa attenzione riservatagli dagli studiosi, si tratta di uno dei film più lucidi e maturi di Buñuel.
La storia è ambientata su un’isola di proprietà privata, riserva di caccia, lungo le coste del North Carolina. Qui vivono il vecchio alcolizzato Pee Wee, sua nipote Evvie (Kay Meersman), acerba adolescente orfana, e il rude guardiacaccia Hart Miller (Zachary Scott). L’azione inizia con la morte di Pee Wee e il quasi simultaneo arrivo sull’isola di Travel (Bernie Hamilton), suonatore di jazz di colore, in fuga dopo essere sfuggito a un linciaggio in seguito alla falsa accusa di stupro da parte di una matura donna bianca. Tra Miller e Travel si scatena una caccia all’uomo, ma il temporaneo armistizio tra i due determina una svolta drammatica. Per non dormire con il nero, Miller impone a Evvie di lasciargli la sua baracca e di spostarsi nella propria. Con l’inevitabile violenza che ne consegue. La notte successiva arrivano, inattesi, due altri personaggi: il pastore Fleetwood (Claudio Brook) e l’incallito razzista Jackson (Graham Denton). Quest’ultimo è sulle tracce del fuggiasco mentre il primo ha il compito di battezzare Evvie e portarla in città in un educandato. Messo alle strette dal pastore, Miller confessa lo stupro ma manifesta l’intenzione di sposare la ragazzina. Intanto Jackson si mette sulle tracce di Travel deciso a ucciderlo, ma Miller lo ferma e fornisce al nero i mezzi per continuare la fuga. A loro volta Jackson, Fleetwood ed Evvie lasciano l’isola. La giovane è vestita con un abito nuovo e scarpe con i tacchi regalatele da Miller, ma sul pontile, con passo incerto, saltella come fanno i bambini quando giocano a “campana”.
Le api sono presenti in una colonia di alveari di cui si occupa Evvie. Questa sua attività è introdotta da due scene. In una prende da una mensola un grande barattolo di miele da cui attinge per la colazione, nell’altra schiaccia un grosso ragno mentre si reca all’apiario. Il valore nutritivo del miele (cibo metaforico) viene evidenziato dal regista nell’incontro tra Evvie e l’affamato Travel che affonda le mani nella cesta dei favi per placare il digiuno. Anche qui, come in Las Hurdes, il miele è qualcosa di più che uno squisito dono della natura: è il simbolo di una condizione umana (il negro fuggiasco) e di una innocenza che sarà presto violata.
Nel film successivo, Viridiana (1961), compare una sola ape. Pensato dal governo franchista come segno di apertura del paese verso il resto della comunità internazionale e gli spagnoli in esilio è il primo film che il regista gira nel suo paese dopo quasi 30 anni. Il copione passa il vaglio della censura, che impone solo una modifica al finale, ma l’opera, una volta realizzata, diventa un sensazionale boomerang che smaschera l’ipocrisia del regime e la sua natura antidemocratica. Premiato a Cannes con la Palma d’oro, il film non viene distribuito nel paese che l’ha coprodotto e, anzi, provoca il siluramento del responsabile della cinematografia di stato “colpevole” di aver ritirato il premio. Bisognerà aspettare il 1977, due anni dopo la morte di Franco, perché Viridiana passi sugli schermi iberici, ma come film messicano. Tale e tanto è il suo potere eversivo, inconciliabile con il modello di società plasmato dalla dittatura.
Viridiana (Silvia Pinal) è una novizia che prima di pronunciare i voti trascorre qualche giorno nella grande casa rurale del suo unico parente, lo zio don Jaime (Fernando Rey), rimasto vedovo lo stesso giorno delle nozze. Infatuato della giovane, somigliantissima alla moglie morta, don Jaime simula una violenza carnale per indurre la nipote a non tornare al convento, ma quando costei riparte si suicida. La morte di don Jaime induce Viridiana a restare compartendo l’eredità, ossia la casa e la tenuta, con Jorge (Francisco Rabal) figlio naturale dello zio. Mentre quest’ultimo intende far fruttare la proprietà introducendovi innovazioni, Viridiana vi accoglie invece una folla di mendicanti che, durante un’assenza dei padroni, devastano l’appartamento nel corso di un festino. La stessa Viridiana rischia di essere violentata da uno dei mendicanti, ma viene salvata da Jorge. L’epilogo suggerisce una sorta di ménage a trois con Jorge, Viridiana e Ramona (Margarita Lozano), la domestica di don Jaime già sedotta da Jorge, attorno al tavolo della cucina per una partita a carte.
All’inizio del film Viridiana domanda allo zio se è vero che questi abbia un figlio naturale. Mentre don Jaime le spiega le ragioni di quel lontano episodio, la macchina da presa inquadra in dettaglio un’ape che si dibatte nell’acqua che riempie un bidone. Con una cannuccia il vecchio toglie l’insetto dal liquido e lo depone sul bordo del recipiente. La breve sequenza è un caso da manuale di slittamento semantico. Il casto e pio don Jaime ha un enorme scheletro nell’armadio ed è obbligato a svelarlo. L’immagine proiettata sullo schermo non mostra però il suo volto mentre confessa il peccato di gioventù, né quello della sua interlocutrice, ma il dibattersi di un insetto che rischia di affogare. La tensione drammatica si cristallizza ed è come se l’ape incarnasse la stessa anima del personaggio, dibattuta nelle acque minacciose di una coscienza che non perdona. E anche la salvezza è solo apparente perché, come quella delle api, anche l’esistenza di don Jaime sarà comunque molto breve.
In conclusione, l’ape è donna
Pur nella grande difformità dei risultati stilistici ed estetici dei film sulle api che abbiamo preso in esame, non sono pochi gli elementi che li accomunano. Una costante trasversale è, per esempio, la presenza di apicultrici donne nonché di bambini o adolescenti accanto agli adulti nella gestione degli apiari. L’organizzazione dell’alveare è da sempre considerata pedagogica e probabilmente questo è elemento sufficiente a indurre sceneggiatori e registi a regolarsi di conseguenza. La presenza femminile accanto alle giovani generazioni è inoltre ancor più significativa, sia pur nei contesti diversissimi in cui si collocano i vari film, ai fini proprio della trasmissione di eredità cognitive. Un passaggio di testimone pratico e intellettuale allo stesso tempo caratteristico della funzione femminile in tutte le forme di organizzazione sociale. Dalle più arcaiche alle più evolute.

