Aggressioni, vandalismi, distruzioni gratuite, manifestazioni di disprezzo per le regole delle comunità nelle quali si vive, evidenziano la presenza di inclinazioni difficilmente tollerabili, ma anche lo sconcerto di chi non sa bene come procedere
Fare lo psicoanalista è continuo ripetersi: occuparsi di singoli casi che si succedono e di situazioni che si ripetono. Ci si allena, quindi, ad affrontare anche aspetti e tematiche molto complesse, addirittura contraddittorie, come la violenza, uno degli elementi costitutivi della struttura psichica di tutti gli esseri umani
La violenza è un motore potente di cui disponiamo, ma del quale portiamo anche la responsabilità, a meno di non volere rimanere eternamente fanciulli e quindi violenti, ma irresponsabili per antonomasia.
Come scrive Freud, ripetutamente nel corso della sua opera:”… la più alta impresa psichica possibile all’uomo consiste nel soggiogare la propria passione a vantaggio e in nome di una causa alla quale ci si è votati” e probabilmente non esiste una causa più importante di quella di portare la responsabilità della vita che ci è stata consegnata.
Al di là delle forme che può assumere, vi è nella violenza un aspetto che ci riguarda tutti, ma con una complicazione piuttosto sgradevole: la violenza attrae gli esseri umani, piace perché dà piacere.
Pur se si tratta di un’affermazione che contraddice le impostazioni psicologiche correnti, se non consideriamo questo aspetto, ogni tentativo di comprenderne la natura per darle un senso e, quindi, ridurne il potere non potrà che fallire.
Occorre portare responsabilità nella propria vita, instaurare una razionalità matura
Di norma noi consideriamo la violenza solo dal punto di vista dei suoi effetti finali, in modo statistico, classificabile, quindi sul piano dei fatti quali essi ci appaiono. In questo modo ci condanniamo a non comprenderne la sostanza profonda e a non poter incidere su quelle manifestazioni che ci turbano.
Tutti siamo stati bambini e non è mai facile riconciliarsi con quelle fasi dello sviluppo infantile in cui insorgono moti impulsivi socialmente inutilizzabili o addirittura pericolosi o ripugnanti, in breve violenti non tanto come intensità quanto come natura.
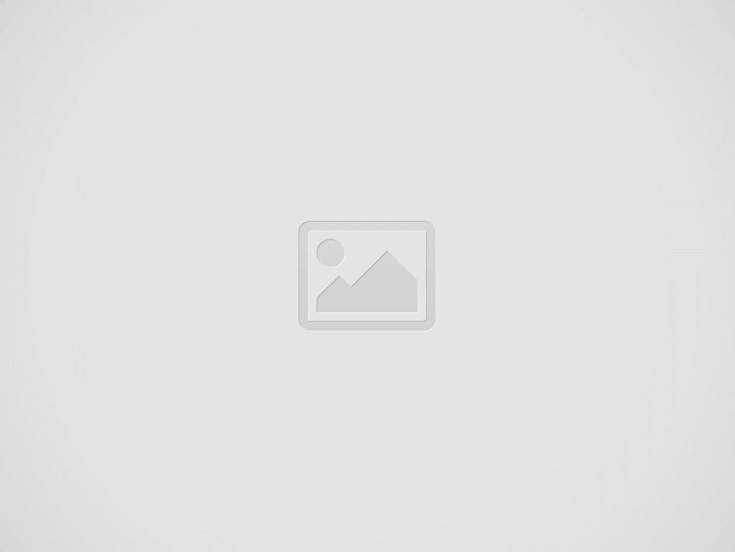

Questi moti sembrano oggi largamente pervasivi del tessuto sociale e, in misura sorprendente, persino favoriti dai moderni mezzi di comunicazione anche quando, invece, dovrebbero essere governati, almeno in parte, dal progressivo instaurarsi di una razionalità matura.
Come spiegare altrimenti il successo di film, serie televisive, videogiochi, spettacoli di vario genere, canzoni anche, dove la violenza si esprime in mille modi attirando milioni di spettatori senza sollevare grandi dubbi circa le possibili conseguenze? Almeno in apparenza.
Che dire, ad esempio di certi testi di canzoni che attraggono migliaia di giovani dei due sessi e che non possiamo leggere senza un certo disagio, a volte molto forte specialmente per chi, come la gran parte di noi senior ricorda i Beatles o altri che cantavano “All we need is love”? Questi testi, peraltro, si accompagnano a manifestazioni sessuali dove erotismo e violenza si intersecano in modo evidente.
L’allarme arriva da fenomeni temibili che coinvolgono giovani sempre più giovani
Vi è comunque una certa preoccupazione che va diffondendosi riguardo a fenomeni temibili che sembrano coinvolgere frange sempre più giovani della società. Aggressioni, vandalismi, distruzioni gratuite, manifestazioni di disprezzo per le regole delle comunità nelle quali si vive, evidenziano da un lato la presenza di inclinazioni difficilmente tollerabili ma dall’altro anche lo sconcerto di chi non sa bene come procedere nei loro confronti.
Basta osservare i continui interventi di esperti di ogni genere, in primis psicostar dei due sessi, che pensosamente disquisiscono sulle nefandezze di questa o di quella struttura storicamente affermata, attribuendole la responsabilità di quanto ci accade.
Le istituzioni servono ancora a costruire l’umanità?
In genere il modo in cui vengono discusse le “istituzioni” che l’essere umano ha creato nel tempo pecca di un evidente pregiudizio: spesso oggi esse sono presentate come cose superate, retaggi primitivi che non dovrebbero più esistere. ma che permangono mostrando i propri effetti devastanti.
Si potrebbe anche ipotizzare, al contrario, che la devastazione effettuata su certe formazioni istituite, ritenendo che si possa attaccarle per distruggerle senza conseguenze come se esse fossero solo frutto di qualche capriccio estemporaneo, non tiene conto né delle ragioni profonde della loro esistenza né del senso che esse danno a ogni singolo individuo circa la sua posizione nella vita, sua e della comunità di cui fa parte.
Ci si può chiedere se l’attacco a quel senso di identità dell’essere umano che poggia sulle costruzioni spirituali e legali che abbiamo costruito (istituito) nei millenni come “animale che parla”, non comporti conseguenze che possono sfuggirci di mano.
L’apprendista stregone in noi è sempre all’opera
Lo notava già Simone Weil negli anni ’40 del secolo scorso quando scriveva che “la rabbia di sradicare è la malattia più pericolosa delle società umane” e indicava nell’attacco indiscriminato alle istituzioni, tutte nessuna esclusa, il pericolo maggiore per il legame sociale e quindi per il genere umano.
Questa espressione, “genere umano”, in fondo indica solo l’unione dell’individuo e della società e rinvia al nucleo causale che anima la vita rappresentativa dell’essere umano, il teatro interiore che vive in ognuno di noi: struttura sessuale degli esseri umani e passione delle origini.
Da esse deriva l’ordine del mondo come noi lo conosciamo, ordine genealogico ossia ordinato per generazioni successive, generate da chi viene prima, che si tramandano il compito di permettere la vita, di proteggerla e di consegnarla, narrandone le vicende, a chi viene dopo.
In fondo, l’animale che parla, noi tutti, narra per essere ascoltato ossia perché qualcuno lo ascolti. Il mito di Edipo, raccontato da Sofocle nella tragedia che tutti conoscono, si occupa precisamente delle conseguenze che ricadranno su chi trasgredisce questo ordine fatale trattando le istituzioni, materiali e spirituali, come entità trascurabili.
Come può essere che accada tutto quello che ho brevemente e forse confusamente evocato?
Vietato vietare? Il rapporto tra libertà e regole
Posso fornire solo qualche ipotesi, con molta cautela e senza pretese di certezze assolute. Ripeto: uno psicoanalista non può che occuparsi di casistica, di singoli casi, presupponendo che ogni evento nel quale sia implicato un essere umano abbia caratteristiche che lo rendono unico. Quindi non posso che inferire qualche conseguenza di ordine generale con assoluta cautela.
Il presupposto della singolarità di ogni soggetto umano mi sembra bene mostrato da Wim Wenders, il regista tedesco, nel suo ultimo film intitolato “Perfect Days”. Ogni essere umano, anche il più umile, è un soggetto, qualcosa di assolutamente unico: vi è un modo personale in cui il genio del singolo esprime un’interpretazione irripetibile anche delle situazioni più semplici della vita di ogni giorno. Irripetibile, ma in grado di parlare a tutti e che tutti, quindi, possono comprendere perché li tocca. Comprendere: etimologicamente significa più o meno “fare proprio” ossia, alla fine, identificarsi in quanto si vede o si ascolta. Quindi, per tornare a noi, tutti siamo potenzialmente anche violenti, ma ognuno lo sarà, in base alle circostanze, a modo suo.
Torno alle ipotesi di cui all’inizio.
Il pensiero che ci domina oggi, il dogma della società industriale postmoderna occidentale, crea nuove forme di potere che si potrebbero chiamare “senza regole”. Dal “vietato vietare” di alcuni decenni addietro, pare si sia sempre più affermata un’idea della libertà come supremo valore assoluto che spinge a considerare tutto quanto abbia a che vedere con le regole, e quindi con la Legge, come incompatibile con essa e quindi invivibile.
Si potrebbe dire che per molti di noi sia impensabile un’idea di libertà al di fuori della rappresentazione che ne abbiamo come quella di meccanismi organizzati e ordinati scientificamente, interiorizzati da ogni individuo in modo automatico fino a sentirle come se fossero parti di se stesso in modo assolutamente indiscutibile, quasi come fossero parti del proprio corpo.
Vi è in tutto ciò un evidente controsenso: in nessun modo la libertà può ridursi solamente a questo. L’attività di incivilimento, ossia il fatto di diventare e sentirsi parte della civis, della città ossia di una comunità, significa innanzitutto produrre una funzione particolare che contesta questa concezione della libertà. Ne vediamo continuamente le conseguenze, poiché non si tiene conto di quanto vi è in noi di oscuro, di primitivo che richiama la necessità di questa funzione al fine di costruire e mantenere la società umana. Non possiamo fare a meno di regole, anzi di una Regola modulata in varie forme nella vita di ogni giorno, che funzioni da terzo sopra le parti, imparziale, in grado di tenere insieme le differenze regolandole per evitare che prevalga il più forte, il più ricco, il più astuto, il più prepotente: insomma chiunque faccia del proprio vantaggio o piacere, un principio di vita.
Sia chiaro: uso aggettivi declinati al maschile, ma vale per tutti.
La presenza di un elemento terzo, sopra le parti, un elemento normativo, la Legge, pilastro che sostiene l’edificio della nostra società, è una necessità razionale e perciò assoluta, un’autorità impersonale preposta alla formulazione delle regole. Tutti vi si dovrebbero attenere, a partire dai potenti, imperatori e re, laici e religiosi, giù fino all’ultimo, al più umile dei “sudditi” che dall’osservanza da parte di tutti del principio normativo trarrà il vantaggio di esigerne e ottenerne la protezione. Come, stando a quanto narra la leggenda, la vedova la esigeva e la otteneva da Traiano imperatore, oppure, come il mugnaio, ripreso da Brecht in una sua opera, da un giudice a Berlino nei confronti di Federico II° re di Prussia.
Ciò che più colpisce chi, come me, vi presta un minimo di attenzione, è il modo in cui attualmente la violenza viene trattata.
Non ci sono violenze deprecabili e violenze tollerabili: ma la società appare paranoica
Sembra esistere un presupposto secondo il quale la violenza è un problema solo quando ci colpisce, sia in modo diretto sia indirettamente. Detto altrimenti: vi sarebbe una violenza più deprecabile di un’altra che invece può essere tollerata. Si tratta di un errore: nulla cade dal cielo perché esistono i nessi causali e ignorarne l’esistenza può essere molto pericoloso.
Ho ricordato poco fa la violenza di certi spettacoli: pare si ritenga che essa non abbia conseguenze, oppure che, pur avendole, non si possa fare granché o anche che sia meglio non fare nulla.
Ci si potrebbe però anche chiedere se il modo di trattare la violenza non contenga alcuni presupposti che spingano a ignorarne le cause quando esse comporterebbero conseguenze, specialmente economiche o ideologiche, che si preferisce non siano messe in questione. Si tratta di un funzionamento mentale che definirei paranoico.
Espressioni come “vado” o “mi sento in paranoia” sono oggi abbastanza comuni, soprattutto nel mondo giovanile, ma a cosa si riferiscono? Cosa è quello che noi chiamiamo “paranoia”?
Paranoia è innanzitutto un modo di pensare la cui particolarità specifica consiste nello scindere la realtà in una serie di singoli fatti, separati fra loro e incapsulati in modo da isolarli senza alcun riferimento ai nessi causali che li generano, nessi logici che ne giustificano la presenza.
Questo procedimento del pensiero (e del giudizio) è posto a sostegno dell’illusione che controllando i singoli fatti si possa governare completamente l’insieme della realtà in cui viviamo, adeguandola a se stessi fino a farla coincidere con quello che ci passa per la mente.
Il paranoico coglie della realtà solo ciò che serve a confermare quello che ha in mente. Il resto non esiste o se esiste non conta. Si tratta, insomma, di una sorta di divide et impera applicato non agli esseri umani, ma alla realtà nella quale tutti vivono. Un magnifico esempio è rappresentato dalle “Memorie di un malato di nervi”, di D.P.Schreber, uno dei famosi casi clinici di Freud.
Nei fatti si soddisfa in questo modo il bisogno infantile di “avere sempre ragione”, di vedere confermato il proprio giudizio, o pregiudizio, dalla realtà dei fatti, un’impostazione ideologica che pretende che la realtà si adegui alle idee che si hanno in mente o ancora che queste stesse idee costituiscano il modello a cui adeguare la realtà.
Si tratta, ripeto, di un tipico funzionamento infantile, un funzionamento mentale assolutamente comune (tutti siamo stati bambini) che in sé non avrebbe nulla di patologico salvo poterlo diventare quando assuma un rilievo che, per le conseguenze sociali che comporta, a volte importanti quando le circostanze lo consentano, provoca qualche forma di disagio e quindi una reazione.
Per fare un esempio: qualora, per un caso del destino, accada che una sola persona accumuli abbastanza potere per imporre la sua visione della realtà a tutti, le conseguenze possono anche essere molto serie, come sappiamo bene.
In sé il pensiero paranoico è dunque solo una delle componenti del modo di pensare comune, che si giova di una notevole lucidità ma è da considerare sempre con una certa cautela. Non è facile trattare con chi presenta tratti marcati di personalità paranoide perché la logica che la caratterizza è quella dell’esclusione: o io o tu.
Tuttavia, nella sua accezione più corrente, si tratta in definitiva di un parametro comune del funzionamento mentale il quale, insieme ad almeno altri quattro contribuisce a costituire e a salvaguardare il legame sociale su cui si basa la nostra possibilità di vita in comune.
Gli inevitabili limiti di ogni gruppo sociale
Questi parametri, che derivo da un mio maestro, André Green, psicoanalista francese noto in tutto il mondo, per quanto fondamentali per il funzionamento della società, non godono di buona fama e in genere vengono passati sotto silenzio. Essi riguardano da un lato la questione di come il corpo influisca sulla nostra psiche e dall’altro il modo in cui ognuno di noi si rapporta all’ambiente in cui vive, al sociale, agli altri in quanto diversi da noi stessi e alla realtà nel suo insieme in quanto estranea al nostro modo di funzionare mentalmente.
Oltre alla paranoia, garante dell’identità e dei limiti di ogni gruppo sociale, giocano allora un ruolo importante
- l’esaltazione del sacrificio elevato a cemento della società,
- la ricerca volontaria di asservimento degli esseri umani, come notava già nel XVI° secolo Etienne de La Boétie,
- l’atteggiamento antisessuale di tutti i gruppi umani, evidente, per esempio, nella variegata sintomatologia di cui si occupa la psichiatria, che manifesta bene la diffusa difficoltà degli umani di accordarsi con se stessi,
- da ultimo, direttamente collegato al tema del titolo odierno, le regolazioni razionalizzate della distruttività umana. Per intenderci, quando fa comodo, un assassinio può anche diventare un incerto del mestiere o un danno collaterale.
Naturalmente esistono anche elementi o parametri che potremmo considerare positivi, ma essi non vengono taciuti o nascosti come invece accade a quelli che ho appena enunciato, della cui esistenza si è costretti a prendere atto solo attraverso le conseguenze che ne derivano.
E allora?
Si sorride un poco di fronte a certi sviluppi sociologici o filosofici che sembrano ritenere di poter spiegare quello che accade senza tenere conto della complessità nostra e della realtà, cioè di quello che lo psicoanalista chiama “inconscio”.
Pensare l’inconscio della psicoanalisi ci obbliga a vedere la nostra sostanza immateriale, spirito, anima o psiche se si vuole, una caratteristica dell’essere umano, in una prospettiva molto particolare dove non si può essere padroni di sé e della realtà se non in modo molto parziale.
Non basta la volontà o meglio ancora la “buona volontà” per renderci umani.
Essa è certamente necessaria e molto utile, ma occorre anche cogliere con franchezza l’inclinazione al piacere della violenza, del “male” se si vuole, che ci percorre e quindi la necessità razionale di regole che ci inquadrino, ci diano una cornice.
Se consideriamo il nostro funzionamento psichico, vediamo che esso potrebbe essere descritto come un tragitto tra due estremità. La prima di esse riguarda, come ho detto ripetutamente, i legami dell’individuo con la materia di cui tutti siamo fatti, il nostro corpo, l’altra invece riguarda i legami dell’individuo con l’ambiente nel quale esso vive, con il sociale come si dice. L’orizzonte è allora, come sempre, abbastanza problematico.
Il primo punto comporta un interrogativo sulla maniera in cui la materia influisce sul nostro personale modo di pensare. Il secondo, invece, riguarda il modo in cui noi ci poniamo all’ascolto, o meno, del modo di pensare degli altri. Preciso: del modo di pensare, non dei contenuti espressi da esso.
L’oscurità corrente dei fatti, testimoniata dalle diverse interpretazione che ne diamo, è aumentata dal peso dei pregiudizi e dei preconcetti che ci caratterizzano. La loro esistenza permette di dubitare fortemente della possibilità, invocata da molti, che si possa raggiungere una conoscenza serena ed aperta delle “cose”. Sembra invece facile da dimostrare che i preconcetti e le ideologie giocano il ruolo di “guardie del corpo” allenate a eliminare ogni situazione sospetta di minacciare qualsiasi forma di sapere ufficialmente riconosciuta, qualsiasi opinione predominante (A. Green).
La ragione è, in fondo, molto banale: certe discipline portano con sé degli schemi identitari per cui la minaccia ai dogmi dei quali esse si nutrono comporta logicamente un riflesso difensivo come sempre quando ci si sente in pericolo.
Lì affondano le radici che ci danno un senso o meglio che danno un senso al nostro modo di vivere. Ignoriamole e il nostro modo di vivere trarrà senso solo dalle passioni del momento, positive o negative poco importa.
Negli anni ’60 del secolo scorso, Pierre Legendre, un funzionario francese grande, erudito pensatore da poco scomparso, percorreva le contrade dell’Africa occidentale, un tempo colonia, per conto di un’importante agenzia dell’ONU. Egli notava la pretesa dei burocrati che si eliminassero le cosiddette “scuole coraniche”, sola fonte di scolarizzazione in quei luoghi, come condizione per ottenere gli aiuti internazionali. Certamente in queste scuole l’istruzione avveniva in modo particolare: gli allievi, dei due sessi, ripetevano sino a impararle a memoria, parti del Libro sacro di cui in realtà non comprendevano nulla.
Un aspetto fondamentale sfuggiva però a quei burocrati, ma non sfugge allo psicoanalista: nessuno di noi può fondarsi da solo poiché necessitiamo di riferimenti che ci indichino la nostra posizione soggettiva. Altrimenti sono guai.
Questo funzionario/pensatore, dimettendosi allora dal suo incarico come protesta per quella che considerava una pericolosa attività distruttiva impostata ideologicamente, diceva agli indifferenti burocrati che dettavano le nuove regole fondatrici:” Voi volete allontanare l’Islam! Ritornerà con il coltello in pugno!”. Profetico mi pare.
Il libro, o meglio in quel caso “Il Libro”, svolgeva una funzione fondamentale: esso indicava all’essere umano, dei due sessi, il suo posto strutturale, aprendolo al funzionamento razionale, della Ragione e non solo della materia .
Sappiamo tutti che un solo animale sa scrivere e quindi legge, ossia narra la sua storia attraverso documenti che rimangono a disposizione di tutti.
Si intravvede allora anche un’altra faccia di quella lontana situazione in apparenza così bizzarra: in quel modo, ripetendo senza comprendere veramente ciò che il Libro narrava, gli allievi acquisivano comunque il sentimento della comunità di cui facevano parte e si vedevano consegnare un modo di vivere fatto di memorie, di tradizioni e di costumi nonché, appunto, l’impegno di conservarlo e trasmetterlo. Un’etica di vita a cui attenersi. In altri termini, il Libro è un modello di funzionamento della Ragione umana e se il sentimento è necessario, la Ragione è indispensabile.
In definitiva non possiamo tagliare impunemente le radici che ci caratterizzano a meno di funzionare come automi guidati da un solo programma che prevede una sola specie di motivazione: il nostro piacere personale, sempre e comunque. Questo e non altro sono la violenza e il piacere che la sostiene.
Certe esecrazioni, che non comportano alcun riferimento né ai parametri che ho descritto né all’inclinazione che essi coprono, in questo modo sembrano a volte esprimere perfino una sorta complicità nascosta, una scarsa volontà di occuparsi dell’insieme della situazione, forse perché questo metterebbe in questione tutta una concezione attuale del nostro modo di intendere la vita e, in più, il modo in cui tentiamo di costruirla di conseguenza.
Il nostro sentimento di identità è una appartenenza che ci colloca come anelli di una catena. Esso ha basi razionali che derivano dalle costruzioni della Ragione.
Proporre come ragionevole la ricerca del modo di imporre la propria volontà è implicito nella natura della nuova specie di essere umano “globale”, senza radici identitarie, senza storia, senza tradizioni, senza una cultura che lo collochi in un legame sociale in grado di fornirgli il sentimento della propria esistenza particolare. Questo vale tanto più se a sostenere questa situazione si creano vasti apparati pubblicitari di ogni tipo.
Per forza di cose assisteremo allora allo scatenarsi di una violenza temibile, diffusa, quasi senza limiti, ritorno a ciò che precede la ragione, il “logos” greco: l’infanzia passionale, animalesca e quindi irragionevole, capricciosa, esigente, prepotente, cinicamente violenta in nome del proprio diritto a sottomettere il mondo intero.

