La forza di questo interrogativo, probabilmente vecchio quanto l’umanità, anche se di certo non sempre formulato in termini così chiari da essere alla portata di tutti, è testimoniata dal numero e dalla qualità dei testi, sacri e profani, che da sempre si occupano del mistero della presenza del male nel mondo.
Si sarebbe tentati di chiudere la questione rispondendo con una parafrasi della famosa affermazione di un mistico medioevale, Angelo Silesio, il quale, parlando della rosa dice solo: ”la rosa è senza perché”.
Anche il male é senza perché?
Se anche fosse così, la nostra curiosità non sarebbe certo soddisfatta. In un certo senso, questa è la posizione anche della psicoanalisi.
All’origine, l’esigenza di definirlo per controllarlo meglio
Del male, nel tempo, si racconta in genere in due modi diversi che corrispondono a due livelli diversi di pensiero. Dapprima, ma si tratta di un “prima” molto relativo, esso si presenta sotto forma di una teodicea, ossia rientra nella trattazione del problema più generale del rapporto della divinità con il mondo e con l’umanità, ossia ne interroga semplicemente lo scandalo: perché?
Successivamente una demonologia, una scienza degli spiriti maligni, lo riveste di un nome. In questa manovra ciò che conta non è tanto il nome in sé, che può essere diverso secondo le culture e i tempi, quanto il fatto che esso è assegnato per incapsulare il fenomeno. Definendolo con un nome si pensa di poterlo controllare meglio: il male esiste come emanazione degli spiriti del male.
A questo punto è già presente il problema del male rispetto al bene e la dicotomia bene/male fonda un ordine e dà senso all’esistenza umana. Questo ordine è riferito poi a qualcosa che trascende, identificato con gli dei del cielo, il divino. In conclusione: mentre gli dei possono essere anche benevoli, vi sono invece spiriti malvagi ai quali si attribuisce un nome maledetto per dare figura al male e dirigere su di lui l’emotività diffusa trasformandola in pensiero.
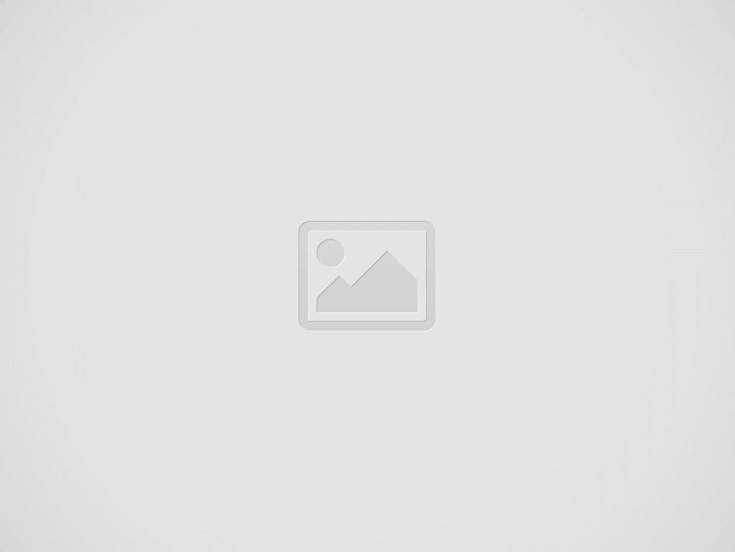
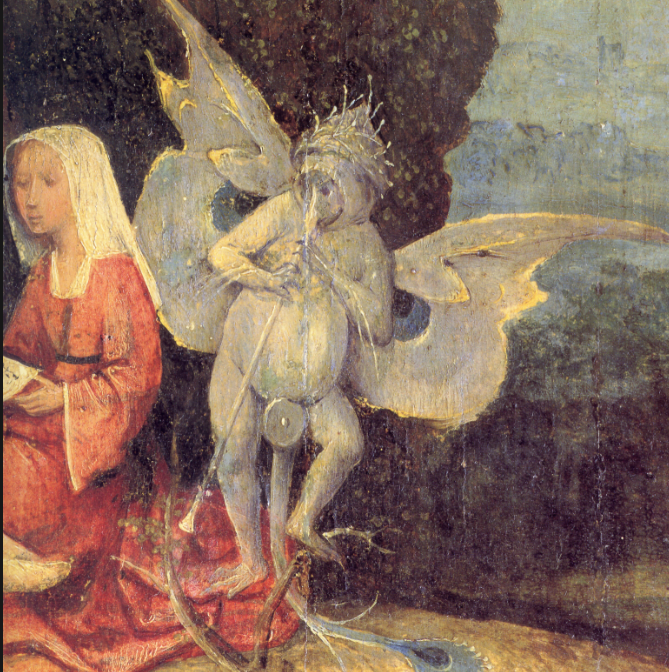
Se si guarda un poco oltre, appare chiara una visione comune a tutti i tempi e tutti i luoghi della terra: il male è la discesa dell’anima nel corpo, dello spirito dall’alto del cielo nella materia della quale è costituito il nostro mondo. Si capisce subito che il problema vero è costituito dalla caducità della materia poiché la materia si corrompe e finisce ossia l’essere umano muore e la morte è una punizione.
Per noi occidentali, questo fatto è narrato dapprima nel libro biblico di Enoch, dove si narra la leggenda dei figli (maschi) degli dei i quali scendono sulla terra per accoppiarsi con le figlie degli uomini in un rapporto da cui nasceranno i malvagi giganti. La narrazione biblica ha in realtà un’origine più antica, babilonese, e rinvia a un’idea dell’aria popolata di spiriti maligni, responsabili delle malattie, delle sventure e in ultimo anche della morte degli esseri umani.
Naturalmente una narrazione di questo tipo non risolve molto. Per esempio non chiarisce perché e come la lubricità degli angeli ha perturbato l’ordine cosmico originando il male. Neppure spiega perché da questo turbamento sono sorti i demoni, figure del male, o anche perché infine gli dei hanno voluto punire gli esseri umani riducendo la durata della loro vita ossia introducendo la morte.
Interrogativi di questo tipo ci conducono sul piano dei miti, delle leggende e delle religioni, che in genere vedono il male come qualcosa che è sempre esistito sotto ogni cielo, ma nello stesso tempo si guardano bene dall’attribuire all’essere umano una responsabilità sia rispetto alla sua origine sia rispetto alla sua esistenza: sarebbe come conferirgli una sorta di libero arbitrio, nei riguardi del male, ma allora anche rispetto al bene, un’autonomia che presupporrebbe un potere riservato agli dei.
Insomma sarebbe un sacrilegio come, fra innumerevoli altri, quello che ci mostra l’esempio di Prometeo che ruba il fuoco per aumentare l’indipendenza dell’umanità.
L’idea che sembra accomunare tutte le narrazioni sul male pare dunque straordinariamente comune: il male è letteralmente caduto dal cielo.
Noi, gli esseri umani intendo, non c’entriamo.
La responsabilità umana, la colpa, la punizione e l’espiazione
Non pare del tutto vero né verosimile e infatti, a un certo punto, si cominciò a ritenere, non a torto, che vi fosse una responsabilità umana almeno nel seguire certe inclinazioni e da qui, insieme con quello di una certa autonomia, nacque naturalmente anche il concetto di colpa seguito da quelli di punizione ed espiazione.
Come sempre, la letteratura costituisce una sorgente inesauribile per alimentare la riflessione sul tema.
André Gide scriveva che non si fa della buona letteratura con i buoni sentimenti. Anche ammettendo che questo sia vero, resta comunque un interrogativo: come mai allora si fa della buona letteratura con i cattivi sentimenti?
Consideriamo per esempio un grande autore come Shakespeare che ha creato molti personaggi abitati dal demone del male: Riccardo II°, Iago, Edmund nel Re Lear, infine forse la figura più tragica di tutte, Macbeth, anche se probabilmente sarebbe meglio dire “i Macbeth”, ossia la coppia unita in una sola figura malvagia.
Tutti costoro hanno una caratteristica comune troppo evidente perché ci possa sfuggire: direttamente o per interposta persona essi fanno il male nella sua forma più primitiva: uccidono come se fossero animati da una forza che supera ogni scrupolo (che pure in certi momenti sembrano avere) e ogni esitazione.
A volte si ha l’impressione che Shakespeare in fondo non faccia altro che riprendere in molti modi l’antico racconto biblico dell’uccisione di Abele da parte di Caino, oppure anche la rivolta di Lucifero contro Dio e la successiva caduta dal cielo sulla terra, anzi ancora più in basso, nel sottosuolo dove in genere si pongono gli inferi.
A volte, è il caso di Macbeth, sembra che la sete di morte accompagni l’odio per la vita e, quasi a suggello, l’incapacità di darla poiché i Macbeth non hanno figli. Essi sembrano incarnare l’aspetto peggiore in cui il male si può manifestare: il gusto di farlo, il piacere di infliggere dolore e sofferenza senza riguardo per coloro che subiranno.
Il male e la psicoanalisi
Questa escursione teatrale mi dà l’occasione di parlare di un’esperienza che tutti gli psicoanalisti fanno comunemente e di continuo nel corso della loro attività: essi constatano quanto l’oscurità di certi spiriti, la loro propensione al male, abbia un forte potere eccitante sull’immaginazione.
Effettivamente, pare che Gide non abbia tutti i torti: il male è un notevole eccitante sia intellettuale sia affettivo, capace di stimolare potentemente l’immaginazione di coloro che sanno creare, gli artisti, ma anche di calmare le tensioni di quelli ai quali, invece, piace consumare queste creazioni.
Infatti è innegabile che noi facciamo un consumo impressionante di male sotto varie forme: violenze aggressive e sessuali, omicidi e massacri, scontri di ogni genere sia nella finzione del cinema o in quella dei videogiochi ma anche nella realtà quotidiana. Sono elementi di malvagità che possono svolgersi nel quadro del presente, del passato o anche del futuro (la fantascienza), che possono avere come ambiente un interno o un esterno, ma che in fondo presentano sempre più o meno la stessa tessitura anche se con svolgimenti diversi. Non ce ne stanchiamo mai, si potrebbe dire.
Nulla di strano. Tutte queste forme di creazione ci danno, infatti, la possibilità di concederci delle soddisfazioni, impossibili o proibite, in modo del tutto inoffensivo e perfino profilattico.
Pensiamoci: anche se personalmente non ucciderei mai, posso benissimo immedesimarmi nel tizio che, sullo schermo, stermina una schiera di nemici o semplicemente di avversari che lo ostacolano nelle sue mire e trarne un’indubbia soddisfazione, ossia rivelare che vi sono in me fantasie di questo tipo. É un fatto: il carattere imponente di queste produzioni cinetelevisivodigitali la dice lunga sui nostri bisogni in questo senso.
D’altra parte è notazione corrente, non solo psicoanalitica, che spesso il successo corona più il vizio della virtù.
Tuttavia, fino a questo punto, noi restiamo ancora nel campo del male che eccita la fantasia, non ancora in quello del male come violenza cieca e paranoica, persecutoria e agita nella realtà della vita.
Quest’ultima prospettiva ci introduce più addentro alla concezione che la psicoanalisi ha del male, che essa intende sia come tendenza impersonale, sia come entità materiale, la malattia subita o inflitta.
Anche se, come dicevo, il male in fondo è senza perché (non ne ha bisogno per esistere), la sua struttura, poiché il male ne possiede senza dubbio una, in psicoanalisi è sempre la stessa al di là dei modi in cui esso si può manifestare.
Si può dire che assistiamo alla ripetizione di uno schema: dapprima il male si definisce in relazione a una proibizione (ricordate il paradiso terrestre e le ragioni della sua perdita?) e al desiderio di godere della sua trasgressione, sia negli atti, sia nella fantasia come quando siamo spettatori di una scena teatrale, di un film, di una fiction.
Successivamente si può scivolare ad altri aspetti più incisivi e temibili, la distruzione pura e semplice, integrale e, in quanto tale, pericolosa soprattutto perché si può verificare solo a posteriori, quando è già avvenuta e non vi è più rimedio possibile. Si tratta insomma della realizzazione di quelle tali fantasie che a volte non possono essere trattenute e controllate sostanzialmente per due motivi: evitare un pericolo per se stessi o trarre un piacere da quello che si fa.
Cosa esprime questo schema? Un’ipotesi psicoanalitica: noi esseri umani siamo animati da due forze la prima delle quali manifesta il nostro fondo biologico, la nostra natura primitiva come tendenza animalesca si potrebbe dire. Successivamente questa forza cede allo sforzo di guidarla e non esserne schiavi, di emergere da essa per costituire legami e fondare così la vita.
Non si tratta di un generico vitalismo di impronta romantica, ma di un riferimento e un’indicazione del compito principale che ci compete come esseri umani: noi siamo impegnati da un lato a far prevalere la vita sulla morte, la creazione sulla tendenza a distruggere che è una parte importante e pericolosa della nostra natura, e dall’altro ad assumere la nostra identità sessuale alla quale è affidata la costruzione di legami e quindi la vita della società umana, la vita civile.
Insomma siamo chiamati ad addomesticare il nostro fondo biologico, a fare in modo che esso non prevalga: uno sforzo quotidiano, molto impegnativo La psicoanalisi, che chiama pulsione questo fondo biologico, nei suoi due aspetti vitale e distruttivo, mortifero, realisticamente afferma che in realtà esso non potrà mai essere completamente addomesticato: non potrà mai accadere che noi diventiamo perfetti come vorremmo, esseri spirituali come gli angeli non ancora caduti dal cielo.
Tuttavia sorge anche un altro problema. Mano a mano che la vita pulsionale si addomestica, per parti più o meno estese, creando un ambiente culturale, civile al quale si apparterrà come “civites”, cittadini, nell’intreccio dei due, natura biologica e cultura civile, si svela un destino, il nostro destino personale, di ognuno di noi. Malauguratamente noi lo cogliamo normalmente solo a posteriori, quando i fatti sono accaduti si potrebbe dire, nella doppia, evidente opposizione di vita e morte, di femminile e maschile che indirizzano la nostra esistenza.
Natura biologica e cultura civile: la sintesi nella parola
Come si può tentare di addomesticare il fondo dell’animale che in origine, alla nascita, siamo tutti più o meno? Usando una sua caratteristica, unica fra gli esseri viventi: l’uomo è l’unico animale che parla.
La parola è lo strumento privilegiato e potente attraverso il quale noi esseri umani possiamo, se vogliamo, sostituire gli atti del corpo, i comportamenti, con atti della mente, i pensieri. Dire: ti ammazzerei! È diverso dal farlo realmente, conveniamone.
Questa differenza implica che esista un giudizio il quale ci permette di distinguere tra quello che ci può venire in mente e quello che facciamo. Non accade sempre così: a tutti può capitare di fare qualcosa “impulsivamente”, ma per alcuni questo può essere il modo abituale di funzionare. Non a caso ho usato in precedenza l’espressione: per parti più o meno estese. Come accennato, riusciamo ad addomesticare i nostri moti più primitivi sempre solo in parte, in modo diverso da persona a persona, perché in realtà la nostra tendenza sarebbe quella di far subire sempre agli altri gli effetti di quello che a noi non piace.
In altri termini, quando incontriamo qualcosa che non ci piace, semplicemente cerchiamo di sbarazzarcene lasciando che altri paghino il conto che noi ci rifiutiamo di saldare.
Insomma, all’origine, ancor prima di distinguere quello che è nostro da quello che sta fuori di noi, facciamo una operazione davvero singolare: mi piace lo tengo per me, non mi piace lo espello, lo sputo come un cibo disgustoso.
Così si identificano da un lato piacevole, buono e bene e, per contro dall’altro spiacevole, cattivo e male. Per la psicoanalisi ogni neonato funziona più o meno in questo modo.
Il problema sorge quando rimane in noi una quota eccessiva di “neonato” ossia di qualcuno che considera male tutto quello che non gli piace, in fondo tutto quello che si oppone alla realizzazione delle sue pretese, indipendentemente dal fatto che esse siano positive, utili, valide e non pericolose. Mettendo fuori di noi quello che non ci piace e trattandolo come male, mettiamo il male nel mondo, nella vita. Si possono capire così molti fenomeni: la diffidenza verso lo sconosciuto, il rifiuto dell’estraneo, l’ostilità verso chi è così diverso da noi da impedirci di riconoscerci in esso, il senso di minaccia che ci viene da presenze ignote e così via.
In genere quello che non possiamo cogliere, il buio o l’invisibile o anche l’incomprensibile, suscita un moto di chiusura e di rifiuto. È il male per definizione, ma non ancora il male quale l’uomo, unico, può concepire. Diceva Einstein, con ragione certamente, anche se nessuno può essere certo che egli l’abbia veramente detto, di non conoscere un topo che costruisse trappole per topi.
L’uomo, oltre al male, conosce anche la sua malignità, il piacere di fare del male sia per attenuare una tensione personale, sia per trarre piacere dalla sofferenza e dal dolore inflitti. Inflitto per non subirli e non soggiacervi? Dare la morte allora per non morire?
Può anche essere e questa è l’ipotesi che la psicoanalisi propone: mettiamo fuori il male sia in fantasia sia con gli atti e i comportamenti per evitare che esso ci attacchi e ci conduca alla morte da dentro. Così facendo, però, si finisce per proclamare che tutto quello che esiste, all’infuori di se stessi, non ha senso, non ha scopo, ma dipende solo dal potere di chi può esercitarlo per imporre la propria volontà a chiunque, ridotto solo a oggetto delle proprie mire.
Non c’è un perché al male perché il male non esiste, ma esistiamo invece noi, forse malati di male e, se non vi poniamo attenzione, la nostra malattia può contaminare il mondo.
Saper fare qualcosa della propria finitezza significa anche saper essere attratti dal legame sociale, dall’oggetto come dice la psicoanalisi, amare la civiltà ossia partecipare alla civitas, amare le nostre spinte vitali nella loro dimensione collettiva, al servizio di una durata temporale più estesa, storica e non solo individuale. È la via maestra per entrare nella condizione comune di esseri parlanti che, in quanto tali, ci sappiamo sessuati e mortali, condizione necessaria per vivere e riprodursi.
La capacità del neonato di sentirsi soddisfatto, riposa sull’illusione di essere lui stesso il dispensatore del suo benessere quando noi sappiamo che esso proviene, in genere, dalla madre. Vi è di più perché l’esistenza di un principio di questo tipo implica conseguenze paradossali ossia che noi distinguiamo fra piacevole e spiacevole come forme di bene e male, ancor prima di distinguere ciò che ci appartiene e ciò che invece è esterno a noi.
A cosa riportare queste tendenze allora? A dei moti molto primitivi che potremmo riassumere in questo modo: negare la realtà per realizzare quello che si vuole e peccare d’orgoglio, ossia ritenere giusto che il nostro vantaggio prevalga su ogni altra considerazione. In questo modo il male entra nella vita umana e nella realtà psichica come volontà di potere, come distruttività cioè come insensibilità al dolore degli altri. É in questo che risiede il male. Quindi il cattivo non è colui che fa il male, può capitare, ma colui che ama il male, ama farlo, infliggerlo, anche a se stesso/a.
Quindi perché il male? perché vogliamo prevalere su tutto, a discapito di chiunque. E’ forse questo ciò che il Cristianesimo chiama peccato orginale?
(nella foto in apertura: particolare della Cattedrale di Notre dame, a Parigi)

