PROLOGO
Nell’anno 1957, al festival del cinema di Cannes, fu premiato il film “Il settimo sigillo” di Ingmar Bergman. Erano trascorsi solamente dodici anni dalla fine di una lunga guerra, devastante per il corpo e per lo spirito. Un tempo, un’epoca che aveva imposto selvaggiamente il ritorno del volto della morte a un mondo che stava tentando di dimenticarla come per convincersi di poterne fare a meno, decretandone l’eclissi.
Il film é un interrogativo sulla morte al quale il regista non si sottraeva, sfidando gli altri a imitarlo. Non sono pochi i pensatori i quali, in ogni tempo, hanno ritenuto che questo interrogativo stia alla base della nostra possibilità di pensare, che esso sia la ragione, il movente del fatto che siamo esseri pensanti, capaci di pensiero. Bergman dava alla vicenda un orizzonte nel solco della nostra tradizione culturale europea, un orizzonte religioso: nella declinazione tradizionale europea un orizzonte cristiano.
Egli la proponeva in forma di metafora, quella a tutti nota, del viaggio, che il protagonista, il cavaliere Antonius Block, crociato e scettico, aveva intrapreso, alla ricerca di una risposta. Di quella risposta. Questo breve prologo affinché quello che segue abbia un senso.
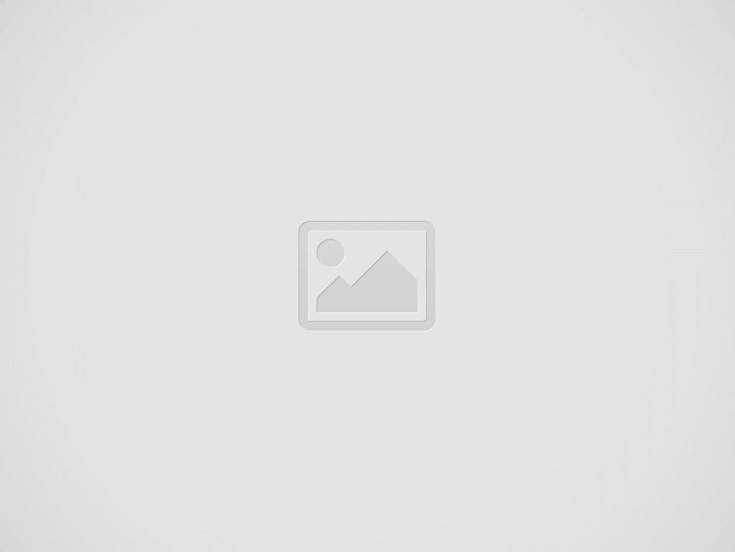

Siamo esseri umani: entriamo nel tempo e poi ne usciamo. É così: é sempre stato così, da milioni di anni, da sempre si può dire.
Nel film di Bergman, quando la morte si presenta al cavaliere Antonius Block egli le chiede: “Dammi ancora del tempo” ed ella gli risponde: “Tutti lo vorrebbero”.
A volte ci accorgiamo improvvisamente che il tempo avanza e talora perfino che forse la maggior parte del nostro tempo se ne é andata. Non tutto però, per fortuna e quando vogliamo portare un contributo intorno a quel che resta del giorno, certamente scorgiamo alternarsi in noi ricordi, pensieri, riflessioni, auspici e anche speranze. Molte speranze, si spera.
PROSEGUENDO…
Le restrizioni che gli ultimi avvenimenti hanno imposto a tutti, suscitano reazioni intense, varie nella forma, ma improntate in fondo a un’affermazione comune: ci viene tolto qualcosa. Qualcosa di molto importante ci viene sottratto: una parte di tempo della nostra vita. Così é lecito affermare che ci viene impedito di vivere e in questa prospettiva tutte le reazioni delle quali siamo testimoni sono perfettamente comprensibili, qualunque ne sia la forma o anche l’intensità.
Non a caso per molti quello che sta accadendo evoca scenari di guerra.
L’eclissi della morte non é più possibile in momenti come questo perché il pensiero, suo malgrado, spinto dalla forza di una realtà che sta sotto gli occhi di ognuno e che mette tutti sullo stesso piano, ritorna inesorabile sull’argomento, si pone una domanda ineludibile: cosa pensi di tutto questo?
In questi tempi tanto più problematici in quanto inaspettati sia per la subitaneità con la quale i fatti ci sono piombati addosso, sia per il sentimento di impotenza che essi risvegliano in tutti noi, si avverte con forza quello che il poeta romantico tedesco Hölderlin chiamava, con linguaggio singolarmente moderno: “La diversione (ma anche lo sviamento o la sottrazione) categorica di Dio”.
Pare, infatti, che l’umanità sia abbandonata al proprio destino e quando le potenze che dovrebbero proteggere il nostro destino sembrano abbandonarci , ci invade un senso di angoscia come non é difficile intravedere dietro molte reazioni attuali che esprimono sgomento, impotenza, a volte vera disperazione.
In questo quadro certamente triste, se non proprio fosco come quello del film, una misura dell’intensità della sofferenza diffusa, fatta di senso di incertezza, di precarietà, é il riferimento forte e continuo alla speranza, per esempio nell’auspicare che finirà tutto bene.
Anche se esso non manca mai negli auguri che accompagnano l’inizio di ogni anno nuovo, lo si intende con forza particolare in questa occasione, quando forte é il timore circa l’esistenza nostra o quella delle persone che sono con noi a dare un senso al nostro vivere.
Ci auguriamo: speriamo che le cose migliorino. Vogliamo sperare, anche se ci manca la certezza. Forse dicendoci che finirà tutto bene stiamo in realtà pensando che anche solamente se finisse sarebbe già un bene.
ULTIMA DEA
“Spes ultima dea” dicevano i latini. Oltre che essere un auspicio questo detto ha anche il senso di una constatazione: la speranza non viene mai meno, essa non può venir meno.
Da quegli stessi antichi la Speranza era personificata e venerata come una divinità, rappresentata in piedi, con un bocciolo di fiore nella destra e la veste sollevata sul fianco sinistro. Essa aveva una specifica e privilegiata collocazione nella considerazione umana poiché aveva scelto consapevolmente di restare fra gli uomini anche quando gli altri dei parevano averli abbandonati, come il Dio del poeta, per ritirarsi sull’Olimpo, in una distanza incommensurabile che li lasciava soli con pene e affanni, segno della loro caducità.
Per qualche ragione che in gran parte ci sfugge, la speranza non abbandona mai gli esseri umani anche nelle circostanze più difficili. Forse al suo nascere diede un contributo il vedere che il sole tramonta ma poi risorge, come il dio Rah esso risorge sempre e la luce dell’alba ritorna regolarmente a scacciare le tenebre della notte e le minacce che esse rinserrano. Forse il ripetersi regolare e sicuro di questo evento ha contribuito al sorgere, nei nostri avi più antichi, persi per noi nel buio dei tempi, della fiducia che ogni tunnel abbia un fondo che una luce ci indicherà.
Restava e resta dunque fra gli umani, la Speranza, a consolarli e sostenerli: per noi moderni più come sentimento forte che come divinità dell’antichità classica a cui oggi non ci riferiamo più. Infatti, secondo il dizionario Treccani, la speranza é un sentimento e precisamente : “il sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione, presente o futura, di quanto si desidera”.
Aspettazione fiduciosa evoca esplicitamente la fiducia o detto in altro modo la fede. La definizione del dizionario introduce un elemento nuovo del quale, quando si pensa alla speranza, é necessario tenere conto. La speranza si nutre della fiducia e su di essa si basa per mantenere vivo in ciascuno di noi il sentimento concreto che la vita valga sempre la pena di essere vissuta anche se non possiamo mai sapere quanto durerà il nostro tempo.
Ne sono consapevoli i teologi cristiani che, come sappiamo, annoverano la speranza insieme appunto alla fede e alla carità, fra le grandi virtù umane, virtù teologali cioè infuse direttamente dalla divinità nell’essere umano come spinta a operare il bene.
Il grande teologo che fu Dante Alighieri ne scrive esplicitamente nella Commedia (Paradiso, XXIV, 64): “fede é sustanza di cose sperate”: la speranza ha un contenuto che le dà sostanza e che si chiama fede. Siamo nel campo della religione cristiana ma quanto detto vale sempre, anche fuori dall’ambito strettamente religioso, per il motivo che la religione é un fatto sociale, qualcosa che lega insieme gli uomini con un legame che può essere così esclusivo da far considerare nemico chiunque non lo condivida.
Se noi vogliamo dunque che la speranza non sia ridotta a mera enunciazione, a una banalità verbale fra le altre, ad aspirazione astratta, se vogliamo che essa esista invece come realtà concreta capace di indirizzare gli esseri umani stimolandone l’attività, essa deve avere un contenuto che le permetta di avere forma visibile.
Certo ci si può chiedere: ma se gli dei si sono ritirati sul loro Olimpo, se Dio ha preso un’altra strada, in cosa si può avere fede? E senza la fede, cosa diviene allora la speranza?
Può esistere speranza solo come attesa passiva di qualche intervento esterno, quello di una divinità che appunto ritorni facendo sì che le nostre aspirazioni si avverino? Il passo verso la superstizione sarebbe allora molto breve: il destino….la fortuna….la buona o la malasorte….i tarocchi, veggenti, maghi e indovini, il caso eccetera.
Discorso molto complesso.
(Mi appello alla vostra comprensione se prima di approdare al campo che più mi é consono, quello della psicoanalisi, sto così avventurandomi, a mio rischio e pericolo, fra religione e arte).
L’ARTE, INFATTI
Aristofane, nella commedia “La Pace”, una fra le sue creazioni più premiate dagli antichi anche se non fra le più note per noi moderni, ricorda che la vita e la morte che la chiude, sono cose sacre. Oggi ancora la voce del poeta si può sovrapporre alla ferocia del male che ci assale senza distinzioni di classe, di censo, di rango, di nazionalità.
Esiste ancora il senso del sacro o esso si é perso come alcuni affermano? E, aggiungerei, oltre al senso del sacro anche quello del tragico della nostra vita possono ancora avere spazio nel nostro convulso modo di vivere moderno? Intendo quel sacro e quel tragico dei quali le religioni in fondo si sono sempre fatte carico nutrendo, con l’idea dell’ultraterreno, la speranza di un mondo di luce senza fine al quale si può aspirare fiduciosamente.
Per millenni le religioni hanno incaricato l’arte di rappresentare questo aspetto peculiare della loro ragion d’essere: rappresentare fiducia e speranza per sostenere il peso del sacro e del tragico, della vita e della morte.
Nella nostra tradizione artistica le potenze che proteggono il nostro destino ci parlano nei libri, nelle composizioni musicali, ci guardano dai quadri e dagli affreschi, ci osservano nelle statue e nei monumenti che ammiriamo, sono ciò di cui sono fatte la nostra cultura e la nostra civiltà.
Esse sembrano sostenerci, consolarci e incoraggiarci: osservate quanto facilmente ritroviamo la fiducia in noi e nella vita, la serenità che sembrava smarrita se solo ci fermiamo un attimo per ascoltare un brano di musica o per leggere un libro o per contemplare un quadro. Queste espressioni artistiche sembrano assumere un senso più pieno se poste al servizio dello spirito religioso come interprete del senso della vita, quando rappresentano la religione come fenomeno sociale che ci lega e dà senso al nostro stare insieme di comunità umana.
Esse svolgono allora un compito ben preciso: collegano fra di loro i singoli esseri facendone una comunità.
Gli affreschi delle nostre cattedrali non sono solo opere d’arte, ma mettono l’arte e l’artista al servizio della religione come fatto sociale che si fa carico del bisogno di speranza che anima tutti gli esseri umani e li spinge a cercarsi.
Sempre e non solo nei momenti difficili: noi abbiamo bisogno di sentirci sempre animati dalla speranza e dal suo nerbo, la fiducia, anche quando il sole risplende sulla nostra giornata.
Il cupo senso di esasperazione che emana da molte manifestazioni attuali, una per tutte “generazione interrotta” (veramente?) fa pensare che spesso sia difficile mantenere viva la speranza affidandola unicamente alla soddisfazione di bisogni concreti, al senso di piacere che si può provare quando siano soddisfatti i nostri impulsi più generici, i nostri bisogni più elementari. La soddisfazione, per quanto necessaria, non può dare un senso alla vita. Per quanto dolce essa possa apparire occorre altro ossia occorre trovare spazio alla nostra voglia di vivere sempre e comunque.
Chi ha visto il film di F. Fellini “La dolce vita” ricorderà infatti il profondo senso di disperazione che spingeva i personaggi ad agitarsi senza uno scopo in un’apparenza di vita dolce solo in senso ironico, e ricorderà anche come Fellini chiudesse il suo film su una nota di speranza rappresentata dal richiamo e dall’invito che una fanciulla rivolge al protagonista, all’alba, sulla spiaggia.
Cosa accadeva però in concreto?
Quella fanciulla rappresentava la voce della speranza ma chiuso nel fragore del suo vuoto mondo vorticoso, il protagonista non la udiva, non capiva e quindi non era in grado di ascoltarne il richiamo per seguirla, ma continuava invece la sua vita insensata, fatta di apparenze.
La lezione di Fellini mi é apparsa alla mente perché mi pare sempre attuale, pensando a come la Speranza, per avere un posto, chieda capacità di ascoltare: fermarsi per poter ascoltare.
Che aspetto può prendere alla fine tutto questo in una prospettiva meno orientata dalla fiducia nella trascendenza, in oscure forze ultraterrene, ma che si riferisca alla normale fiducia che ogni essere umano dovrebbe possedere circa il fatto che le cose possano evolvere, più o meno, anche in senso favorevole?
CONCLUDERE DA PSICOANALISTA
In ambito psicoanalitico fede e speranza esprimono una disposizione positiva di fondo, generale, nei confronti del fatto che siamo immersi nella realtà del mondo in cui viviamo e ne siamo parte essenziale. Questa disposizione fa sì che noi passiamo attraverso le vicende della vita considerandole come episodi, positivi o anche negativi, ma che non possono mai lacerare completamente il tessuto della nostra esistenza.
Questa disposizione non é innata in sé pur basandosi su fattori che senza dubbio dobbiamo considerare innati. L’essere umano é una creatura molto particolare perché non esiste in natura. Esso é costituito dall’intreccio di una base biologica, il nostro corpo, e dell’influsso che l’ambiente in cui nasciamo e la cultura che lo caratterizza, esercitano su questa base.
Un esempio di questo influsso é costituito dal linguaggio, dalla nostra capacità di parlare. La parola non ci serve solo per esprimere, almeno in parte, il nostro pensiero, ma soprattutto influisce sul nostro modo di pensare. Parlare italiano significa avere schemi concettuali, di pensiero, diversi da chi parla un’altra lingua, anche se noi consideriamo questi schemi come qualcosa di naturale, che dunque esiste già prima che noi sappiamo parlare.
L’influenza dell’ambiente si esprime quindi in modo particolarmente efficace quando il nuovo essere é più permeabile dunque più influenzabile e malleabile, ossia nei primi due – tre anni di vita, proprio quando si impara a parlare e si inizia a farlo.
Questa é l’epoca nella quale si struttura il rapporto con il mondo e con la vita, si crea la fiducia (o la sfiducia assoluta nei casi estremi) nelle opportunità che essa ci offre e sulla base di questa fiducia in sé e negli altri, nella realtà interiore e in quella esterna in generale, si costituisce lo spazio della speranza.
I modi nei quali questa strutturazione si manifesta sono il risultato della relazione che si crea tra ogni neonato e l’ambiente che lo accoglie o, per meglio dire, tra il luogo in cui esso viene al mondo e l’accoglienza più o meno adeguata che riceve. In questo modo la speranza prende consistenza, non si limita a un auspicio, ma implica la possibilità reale di intervenire, nei limiti delle proprie capacità, affinché quanto viene auspicato si possa realizzare.
La capacità di attivarsi, di intervenire é basata sulla fiducia di potere agire sul proprio destino in modo da orientarne le sorti, naturalmente sempre in misura parziale, affinché esse aderiscano il più possibile a quello che ognuno auspica.
Di contro vi sarà anche la ragionevole fiducia della cordiale accoglienza dei nostri sforzi da parte di un mondo orientato in senso abbastanza favorevole nei nostri confronti. Si tratta della continua attivazione di un ricordo positivo, iscritto nel corpo prima ancora che nel cervello, ricordo della risposta ambientale alle manifestazioni primitive, vaghe e incerte dell’essere umano alla nascita.
Riassumendo, certo in modo riduttivo, queste risposte danno luogo a due generi di impressione, di sensazione.
Da un lato piacere, soddisfazione, benessere dunque e sentimento che il mondo ci capisca e sia disponibile perché amico e quindi ben disposto verso di noi.
Sul lato opposto sensazione di dispiacere, di insoddisfazione, malessere e sentimento di un mondo chiuso, ostile, che rifiuta perché ci é nemico.
Prevale in genere una ragionevole mescolanza delle due componenti: un ambiente sufficientemente buono, ossia anche sufficientemente cattivo, ci basta per costituire in noi un patrimonio di fiducia e di speranza utilizzabile in ogni circostanza, perché queste sensazioni, consolidandosi, daranno origine a un modello personale che permane fuori dal tempo. É il nostro modello di vita o anche, detto diversamente, il nostro modo inconscio di vedere la vita: fiducia verso diffidenza, speranza verso sconforto.
Un modello che resiste alle circostanze e che si riassume bene nel detto popolare “finché c’è vita c’é speranza” che ha un senso profondo: per quanto dure, le vicende della vita sono solo una parte di essa.
Possiamo provare dolore, tristezza, timore, ma ritrovare poi il senso della nostra vita o meglio, il sentimento che la nostra vita continui ad avere un senso.
È un’esperienza che origina presto, ma si consolida e si affina con il tempo, con l’età e con l’esperienza quando siamo capaci di farla. Si tratta quindi del patrimonio particolarmente prezioso della maturità.
Al di là dello scorrere del tempo, un segno di maturità può consistere nel fatto di riuscire a sentire in noi la speranza nella capacità della vita di avere il sopravvento e di spingerci ad adoperarci per risolvere, finché c’é vita, i casi che essa ci presenta.
Come nel caso di Antonius Block il quale chiede più tempo a una divinità dalla quale si sente abbandonato (anche per sua personale e precisa responsabilità) affinché gli sia dato di poter sfruttare il tempo che gli é concesso per fare qualcosa di utile.
Un’ultima speranza e la speranza ultima, come quella che resta sempre con noi, ultima che non ci può abbandonare mai.


View Comments (1)
Grazie davvero a Voi tutti per permettere a chi segue il Vostro sito un arricchimento speciale leggendo con interesse questi articoli.
Grazie !!