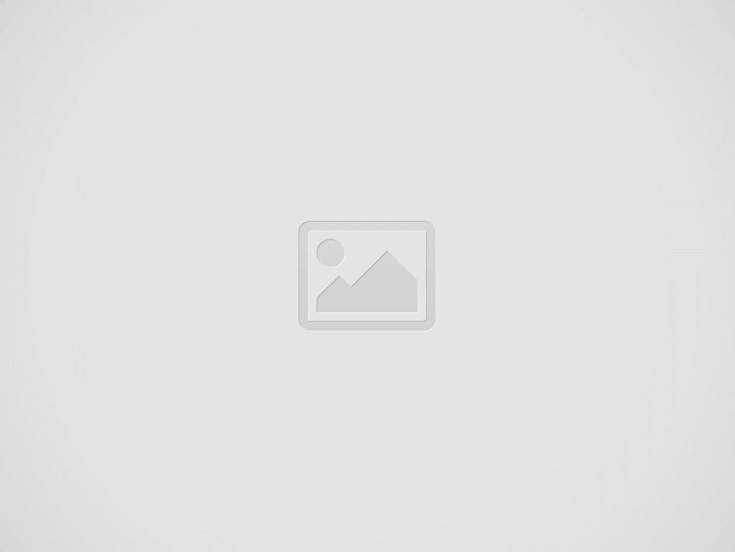Il camion è rosso e ha sul radiatore un mosaico di luci a forma di croce. Oggi però è sporco, grigio, ricoperto dalla polvere della cava. Il cassone posteriore è pieno di sabbia, quintali di sabbia destinati a diventare palazzi, ponti, autostrade. Dalla cava si vede il mare. Il sole di giugno riluce sulla cresta bianca delle onde, che il vento accende e spegne cambiando direzione.
Dal cassone spunta fuori una manina, si aggrappa alla ribalta e poi sparisce. Il camion sale e scende dalle dune. A ogni discesa il carico sobbalza e una risata di bimbo riecheggia. La superficie della sabbia è calda. Il bimbo ci si è steso sopra e osserva il cielo. Aspetta con ansia l’aereo che ha attaccato alla coda lo striscione della pubblicità.
A ogni curva il motore arranca, il camion si sbilancia sul ciglio dei fossati, si inclina, e poi torna in equilibrio come succede alla vita nei film. Il vento che soffia dal mare solleva i granelli di sabbia nel cassone, facendoli mulinare nell’aria. Il bambino ride e fa capriole. Rotola su e giù, galleggia sulla superficie, sembra senza peso. Oggi compie quattro anni.
A un tratto il camion sbanda, il bambino si aggrappa alla ribalta che però gli sfugge, grida qualcosa di incomprensibile e una tosse improvvisa lo zittisce.
Sul sentiero le ruote sobbalzano. Lo sterrato si sfarina come la scia di una cometa. Nella nuvola di polvere il bambino alza la testolina, la scuote, i capelli sono diventati bianchi. Ha gli occhi rossi e sputa saliva. Con le manine cerca di arrampicarsi, ma la ribalta ora è troppo in alto per lui. Le ruote slittano ancora sul terreno, il camion frena e il cassone si solleva, poi ricade con un tonfo sordo. In una frazione di secondo il carico scivola verso la motrice, si accumula, cresce, è una montagna, è l’onda di uno tsunami che si ripiega all’indietro, precipita, dilaga sul fondo del cassone, soffocando un gemito.
Il bambino respira ancora quando sparisce sotto quintali di sabbia. Oggi ha compiuto quattro anni.
L’uomo alla guida ha il braccio fuori dal finestrino, fischietta il ritornello di una canzone volgare e ripete alcune strofe a squarciagola. Il camion percorre a velocità sostenuta un tratto di dune che costeggia la spiaggia. Gli pneumatici incidono sul terreno piccole croci e tagliano in due i cespugli di elicriso che ricoprono il suolo. Quando il veicolo raggiunge lo spiazzo al centro della cava, si ferma. L’uomo scende e sbatte lo sportello con forza. Sputa a terra. Si passa una mano sulla fronte scura e sudata, poi la strofina sui pantaloni. Raggiunge il retro del camion imprecando.
«Luigi, scendi che ho caldo» grida sbottonandosi la camicia. «Luigi! Dai!»
Sullo spiazzo della cava, nella canicola del primo pomeriggio, lo stridio delle cicale è l’unico suono. L’uomo sbuffa, si passa di nuovo le mani sulla fronte lucida. «Luigi! Se non scendi, ti lascio lì dentro!» C’è un odore nauseabondo nell’aria. L’ala rosicchiata di un gabbiano spunta da un cespuglio grigiastro. L’uomo fissa il rimorchio e aspetta qualche secondo, poi fa un gesto stizzito. «Vai al diavolo!» dice, e si allontana storpiando la rima più volgare della canzone.
Sotto il sole cocente il camion è un grosso animale stordito. L’uomo tossisce e cammina verso l’ombra di una tettoia. A un tratto si volta. Fissa il rimorchio. Si toglie la camicia, la arrotola e se la passa dietro la nuca. Si asciuga la fronte. Sputa a terra e poi torna a fissare il cassone del camion. Fa un passo in avanti, poi un altro. Si ferma. Resta a gambe divaricate e mani sui fianchi.
«Luigi!» grida. «Adesso vedrai quante te ne prendi!» Non riceve risposta. Nel cielo passa un aereo con un lungo striscione pubblicitario legato alla coda. Il mare è dietro le dune, e da qualche anno le spiagge anche a giugno sono affollate di bagnanti che comprano creme solari della stessa marca stampata sulla pubblicità.
L’uomo segue l’aereo con lo sguardo, poi sembra risvegliarsi da un sogno. Getta la camicia a terra e si muove verso il camion con passo deciso. Continua a fissare il rimorchio come se all’interno si nascondesse un nemico.
«Luigi!» grida avvicinandosi. «Luigi! O scendi o ti ammazzo!»
Poi a un tratto si ferma. Si toglie una scarpa e la lancia contro la ribalta. Fa ancora due passi in avanti, senza far caso al pietrisco che gli ferisce la pianta del piede nudo. «Luigi!» grida di nuovo, ma stavolta l’urlo è meno deciso.
L’uomo è immobile. All’improvviso sembra incapace di procedere. Barcolla incerto, tenendo sollevato il piede senza scarpa. «Luigi» sussurra, spingendo la testa in avanti con la speranza di cogliere una risposta. «Luigi» ripete, alzando la voce e facendo ancora un passo. Silenzio. Allora l’uomo si lancia verso il camion, le mani affondate nei capelli. «Luigi!» grida, battendo forte i palmi sul cassone. Adesso sbava, un rivolo di saliva gli scende dalla bocca mentre con un balzo si arrampica sulla ribalta chiusa. «Luigi!» grida ancora, ma la voce è stridula, rauca, i piedi immersi nella sabbia calda che lo inghiotte imprigionandogli le gambe. A ogni movimento scomposto affonda un po’ di più. È una palude asciutta la tomba di suo figlio.
Riesce ad aggrapparsi alle sponde, riemerge, grida: «Venite! Aiuto! Venite!».
L’urlo è un vetro spezzato, taglia l’aria densa, giunge fino a un enorme mucchio di sabbia ai margini dello spiazzo. Un operaio a torso nudo, scuro, lucido come il cuoio, spunta fuori con una pala in mano.
«Venite! Aiuto!» L’uomo sul camion non smette di gridare. Dal pulviscolo emerge un secondo operaio. Anche lui ha addosso solo un minuscolo paio di calzoncini che quasi non si vedono, coperti dal suo ventre debordante. Corre ansimando, mentre attraversa il piazzale della cava con un badile in mano. «Capo! Cosa succede, capo?»
«Madonna!» urla l’uomo che adesso spunta dal cassone con tutto il busto. È irriconoscibile sotto la maschera di sudore e polvere. Le mani sono raggrinzite e la pelle intorno alle unghie sanguina. Ha scavato, ha rovistato nella sabbia. «Madonna» ripete adesso sottovoce. «Aprite! Aprite la ribalta! Tiriamolo fuori!»
I due operai si scambiano uno sguardo. Restano imbambolati per qualche istante. «Aprite!» grida allora a squarciagola l’uomo sul camion. «Aprite! Aprite! Tiriamolo fuori!»
Gli operai si piazzano sui due lati del camion, sganciano i fermi che bloccano il cassone.
L’uomo imprigionato nella sabbia resta aggrappato con tutte le sue forze al bordo. La ribalta crolla a terra con un rumore di ferraglia.
La sabbia scivola sul piazzale come l’onda di un mare grigio. Si riversa al suolo allargandosi intorno al camion. In quel deserto c’è qualcosa di rosso, sembra uno straccio.
L’uomo intanto è riuscito a saltar giù. Raggiunge lo straccio e lo afferra. Ora tra le braccia ha un bambino.
Gli operai arretrano, si guardano senza dire una parola. Questa volta nei loro occhi c’è terrore.
«Dobbiamo portarlo nella cava» dice l’uomo che tiene in braccio il bambino. Intorno alla bocca gli si è rappresa una bava bianca, somiglia a panna, quella che ha mangiato dopo pranzo per festeggiare il compleanno di Luigi.
«Cercate un buco! Cercate un buco per metterlo dentro!» farfuglia, sputando la sabbia che ha in bocca.
Gli operai sono sgomenti, sotto il sole implacabile. Negli occhi hanno una luce sinistra. La luce della paura.
La donna cammina verso la luce, raggiunge la strada che corre lungo la spiaggia, entra in un locale che ha le vetrine coperte da carta rossa. Sono le otto della sera. È mercoledì. Sul pavimento, al suo passaggio, cadono granelli di sabbia.
«È la donna della sabbia» dice sottovoce la cameriera all’uomo grassoccio seduto alla cassa. «Tavolo 8.» Lui scrive “8” sopra un pezzetto di carta bruna e lo infilza sullo spillone delle ordinazioni dove ha impilato altri foglietti.
Spaghetti di riso con verdure. Il tavolo 8 ordina “Spaghetti di riso con verdure” ogni mercoledì.
La donna, in attesa del suo piatto, ha l’abitudine di scarabocchiare il tovagliolo di carta su cui sono appoggiate le posate. Abbiamo costruito sul bordo dell’oceano e… L’inchiostro nero penetra nella carta e i bordi delle parole si slabbrano. Stasera la donna lascia alcuni spaghetti sul fondo del piatto e prima di alzarsi li fissa per qualche istante, come fondi di caffè da cui attende risposte. Entra sempre sola nel ristorante, mangia sempre sola al tavolo 8, quello nell’angolo.
La donna si alza e altri granelli di sabbia cadono sul pavimento che ha le piastrelle sbiadite. L’uomo grassoccio alla cassa ha mandato a memoria il menu. Mentre la donna si avvicina, lui annota il totale su un foglietto che stira con il palmo della mano sul piano del bancone. La donna infila in tasca una mano, estrae alcune monete e per contarle le appoggia sulla testa in rilievo di un dragone rosso.
Fuori non c’è più luce. È ottobre. Non si distingue il cielo dal mare.
«Sul bordo dell’oceano…» La donna ripete a bassa voce la frase, camminando sul marciapiede con la borsa dei libri a tracolla, come il matto del suo paese. Da piccola lo vedeva passare per le vie, sempre solo, con un borsone. Per fargli dispetto, i ragazzi glielo riempivano di sassi. Ma ora non vuole ricordare quella storia. Quando si affaccia sopra l’alta muraglia che tiene lontani i pensieri nocivi, la ricaccia indietro. Non sempre è riuscita a tenere a bada il passato, però adesso si sforza. Sa che i ricordi possono ammassarsi a tradimento e sbucare fuori tutti insieme. Sa che potrebbe soccombere, se succedesse. Lei li avverte come fossero solidi, percepisce il loro peso quando si muovono nella sua testa, fino a sbilanciarla, fino a farle perdere l’equilibrio.
Gira la chiave nel portone di casa e la nausea la tormenta. Si siede sul gradino per recuperare le forze. Non è colpa degli spaghetti, è un’altra faccenda. Poi entra nell’androne. Preme il bottone dell’ascensore. Sale. Si chiude la porta alle spalle. Toglie le scarpe e resta a piedi nudi. Cammina lungo il corridoio illuminato da un abat-jour. Tutto è come l’ha lasciato prima di uscire, e questo è ciò che distingue le persone sole dagli altri. Poggia le chiavi vicino al vaso di porcellana blu, in cui non ci sono fiori da parecchio tempo.
Nello studio apre un cassetto della scrivania, dove ha riposto i taccuini per appunti su cui non scrive più da sei mesi. Li tira fuori. Toglie l’elastico che li tiene insieme. Ne apre uno, lo sfoglia e lo richiude subito. Rimette l’elastico intorno al plico e lo appoggia sul piano della credenza nel corridoio.
Dalla camera da letto viene un profumo intenso di ambra. Appoggia la borsa sulla coperta azzurra, la osserva affondare lievemente nella stoffa. Poi si volta verso la parete.
Nello specchio è riflessa una figura alta, con i capelli bruni che ricadono sulle spalle, un velo di rossetto e un’espressione stanca. Porta un impermeabile stretto da una cintura e un paio di jeans con una libellula cucita sulla tasca posteriore. Sul bordo della tasca è ricamata una e. Prima degli spaghetti di riso del mercoledì, prima dell’appartamento piccolo ma pulito in cui regna un ordine perfetto, Elena viveva con i suoi due fratelli, la madre e il padre in una casa non lontana dalle dune. È una casa bassa, addossata a una collinetta, con il tetto spiovente che pare abbia preso un pugno su un lato. È una casa scialba, sempre invasa dalla sabbia, una patina di polvere copre gli arredi. La madre usa la scusa della sabbia per non pulire. «Tanto è inutile» dice alzando le braccia al cielo con un’espressione tra la resa e l’improvvisa liberazione da un fastidio.
La famiglia di Elena non era povera, ma ha vissuto come se lo fosse. Erano poveri nei gesti, nelle parole, poveri per il loro modo trasandato di stare al mondo. Prima che il fratello piccolo ci morisse, il padre aveva fatto i soldi con la cava, vendendo tonnellate di sabbia ai costruttori. Si alzava la mattina quando era ancora buio. Muovendosi per la casa, faceva rumore: rovistava tra gli utensili nella sua borsa da lavoro e batteva la suola delle scarpe contro il muro per liberarle dal fango indurito. Non era grossolano per sbadataggine, le cattive maniere avevano un significato più profondo. Volevano dire: “Io lavoro mentre voi dormite. Io produco, mentre voi siete una zavorra senza alcun valore”.
In pochi anni le dune intorno a casa sono scomparse. Erano fatte di sabbia, vero e proprio oro per tutti quelli che si sono arricchiti con la costruzione di nuovi mondi in riva al mare. Le dune erano parte di un universo primordiale, cancellato da colate di cemento. Erano il prima di un dopo in cui “costruzione” non può prescindere da “distruzione”. A ogni duna che spariva la gente del litorale era un po’ più ricca, ma anche molto più povera. Povera perché in casa si parlava solo di soldi. Povera perché le dune erano la protezione dal mare, preziose barriere difensive distrutte in nome di quell’idea fissa di diventare ricchi. Soprattutto il padre di Elena. Parlava sempre di soldi e di sabbia. Per lui “sabbia” voleva dire bella vita. A ogni stagione comprava un camion più grande. Elena ne ricorda uno rosso, che sul radiatore aveva un mosaico di luci a forma di croce. Il sabato sera lo parcheggiava, ben lucidato, sul marciapiede di fronte alla balera del paese. Nel locale lo aspettava sempre una donna diversa, con la fame di denaro negli occhi.
In paese tutti sapevano che aveva molte amanti, amanti da quattro soldi, ma comunque tante. Per questo la madre di Elena aveva smesso di farsi vedere in giro e di pulire la casa. O forse aveva smesso quando era morto il bambino, seppellito due volte dalla sabbia.
L’incidente succede in un pomeriggio di giugno. La strada sterrata davanti a casa sembra tremolare per la calura. Il padre porta il bambino alla cava. È un bambino vivace. Troppo vivace, dice il padre, troppo irrequieto. Lo fa scendere dal camion e poi lo lascia sul piazzale della cava per un minuto, giusto il tempo di smontare a sua volta e non trovarlo più. Un’ora dopo lo ripescano da un buco gli operai, due uomini che parlano in dialetto e d’estate sono scuri come cuoio.
«È caduto in un buco» dice il padre quel giorno. «La sabbia l’ha sepolto vivo.» Il fratello di Elena era morto “in circostanze misteriose”. Così si diceva in paese. Il padre però raccontava la sua versione con insistenza, aggiungendo particolari ogni volta più convincenti. E poi c’erano i testimoni. Gli operai avevano visto e l’avevano giurato davanti al giudice.
Quel pomeriggio alla cava arrivano tante macchine, che ripartono poco dopo sollevando nuvole di polvere. Elena, dall’alto della collinetta, le osserva. È abituata a vedere auto dirette alla cava quando nuove imprese edili piazzano in zona le baracche prefabbricate per i muratori. Qualche mese dopo l’arrivo di quelle auto, come sintomi di una malattia che ha bisogno di incubazione spuntano all’orizzonte le gru e, poco dopo, i tetti di nuove case, di alberghi, edifici progettati con stile ogni volta diverso, forme disparate che sbucano all’improvviso dal paesaggio marino, come una coltellata.
Elena è là anche quel giorno, in cima alla collinetta dove va tutti i pomeriggi dopo la scuola. Ha sei anni, ha fatto la prima elementare. Indossa il grembiule rosa con il fiocco, la divisa delle femmine. Lei va a scuola, e tutti devono saperlo, perché a casa nessuno ha studiato.
Il fratello piccolo compie quattro anni. Per questo il padre l’ha messo nel cassone del camion. È il suo regalo. Al bambino piace affacciarsi dal rimorchio e prendere l’aria fresca sulla faccia mentre il camion sale e scende dalle dune.
Elena è là, seduta tra i pochi ciuffi d’erba del prato. L’odore della terra si mescola al profumo dolce dei tigli che arriva dai viali lontani della città.
Elena piange perché è successo di nuovo, succede ogni anno alla conclusione dell’anno scolastico. Per festeggiare la fine della scuola, il fratello più grande brucia i capelli di una delle sue bambole. Stavolta se l’è presa con Mokita, la bambola con cui Elena dorme. Quando la mostra a suo padre, bruciacchiata e senza capelli, lui si mette a ridere. Ride in modo sguaiato. Ride della bambola e ride di sua figlia, dei suoi sentimenti, tutte cose inutili che vanno bruciate per il suo bene, dice il padre, se vuole crescere forte, capace di difendersi dai lupi che troverà fuori casa il giorno in cui la lascerà per sempre.
L’unica volta che suo padre non ride è al funerale del bambino, quando la bara bianca scende nel suolo sabbioso del cimitero. Non ride, controlla. Prima di uscire dalla chiesa prende da parte Elena, la madre e il fratello grande. «Non dovete piangere» dice. «Luigi è in Cielo e non voglio vedere lacrime.» Obbediscono. Di fatto obbediscono sempre, contro ogni ragione, contro ogni dolore.
Elena ha sei anni, la madre ventotto. Elena non le perdona quell’obbedienza silenziosa, quel suo restare composta nella fotografia che li ritrae sui gradini della chiesa, con la bara del fratello davanti e una coda di pettegolezzi cattivi alle spalle.
Ma prima che arrivi quel giorno, prima della penombra nella chiesa fresca d’incenso, Elena ha già fatto scorta di lacrime. Sta piangendo quando il fratellino muore, ne è sicura. Non l’ha visto morire, il padre non le ha mai detto cosa è successo veramente, ma è certa che mentre Luigi viene seppellito dalla sabbia della cava, mentre lui muore, lei piange. Lo aspetta per ore sulla collina. Non arriverà. Piange per la bambola bruciata e per se stessa, lassù, sola, con indosso il grembiulino delle elementari, piange perché, se non troverà il coraggio di scappare, sarà destinata a una vita arida.
Il racconto continua….
di Laura Calosso
- ISBN: 9788893903097
- Pagine: 240 pp
- Prezzo: 18 euro
- Per acquisti online
Elena ha da sempre un rapporto traumatico con il padre, arricchitosi negli anni Sessanta estraendo sabbia da una cava e distruggendo le dune che proteggevano il litorale dalle mareggiate. Giovanissima, decide di scappare lontano da una famiglia che non la ama e su cui incombe la misteriosa morte del fratellino. La vita la porta a viaggiare per il mondo lavorando come giornalista freelance a vari reportage. L’ultimo riguarda le “mafie della sabbia”, organizzazioni criminali che rubano la preziosa materia prima a tutte le latitudini per venderla dove è più richiesta, ovvero nelle nuove megalopoli o nelle popolose aree costiere in cui speculatori privi di scrupoli costruiscono isole artificiali e grattacieli. Studiando questi traffici illeciti e il loro catastrofico impatto ambientale, Elena scopre la verità su alcuni fatti avvenuti nella sua infanzia… Lungo il romanzo corre parallelamente una tormentata storia d’amore. Per colmare il proprio bisogno di affetto la protagonista ha una relazione con un uomo che tende a idealizzare, pur vedendone i limiti. Di che cosa ha bisogno veramente? Forse solo arrivando a una resa dei conti con il proprio passa-to riuscirà a trovare una risposta.
Laura Calosso si conferma con questo romanzo un’autrice capace di intrecciare in modo innovativo narrativa e inchiesta giornalistica.