Roberto Bazlen, il più talentuoso e meno appariscente tra gli editor dell’editoria italiana, è per Montale una leggenda cartacea inattendibile, un maestro inascoltato, un confessore inconfessato. Un giudizio un po’ freddo e distaccato per il revisore segreto delle Occasioni. Bazlen, che una leggenda silenziosa lo è stato davvero, un uomo vivo nei libri di altri, un uomo schivo che tratteneva a sé le sue passioni, viene ricordato troppo spesso solo per le sue potenzialità espresse parzialmente e per l’aura attorno alla sua memoria. Eppure la sua visione dell’editoria è diventata forma, il progetto della casa editrice ideale. La sua coccolata e interminabile lista di libri, molti dei quali rifiutati dalle altre case editrici, sono diventati un unico libro di libri, una teoria di libri unici. Ma i progetti che stancano il tempo hanno radici profonde: il suo è un percorso limpido nel Novecento europeo, da solista e con l’appoggio di sodali affascinati. Luciano Foà, per esempio. Loro due, la mente visionaria e l’organizzatore, erano editorialmente una cosa sola fin dai tempi di Adriano Olivetti alle Nuove Edizioni Ivrea. Sì, perché durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale Olivetti aveva incaricato Bazlen di mettere a punto il programma per una casa editrice che fosse in grado di affermarsi rapidamente dopo la caduta del regime; sognavano di “diffondere in Italia tutto quello che, per via del crocianesimo o del fascismo, era stato fino a quel momento tenuto fuori dai confini”. Di quel progetto non se ne fece nulla e solo alcuni dei titoli proposti da Bazlen confluirono nel successivo catalogo delle Edizioni di Comunità.
Però il disegno originario – pubblicare classici assenti, scansati, tenuti lontano, ripubblicare tutto ciò che era stato pubblicato male – persiste e si amplia nella memoria del suo artefice, resiste altri vent’anni, ed è finalmente Adelphi. Così, tra il 1962 e il 1963, grazie all’aiuto finanziario di Roberto Olivetti e della famiglia Zevi, nasce l’Adelphi, e si manifesta a immagine e somiglianza di Bazlen anche se nei primi tempi l’anima della casa editrice e la natura del filo che lega tutte le pagine è chiara solo a lui. I primi volumi (“Classici”) sono una prova generale; escono l’anno successivo, nel 1963, e sono le opere di Georg Büchner, “Robinson Crusoe” di Defoe, le novelle di Gottfried Keller e “Fede e bellezza” di Niccolò Tommaseo. Bazlen, nel frattempo, aveva portato nella squadra un promettente giovane di ottime letture che aveva avuto un maestro d’eccezione, Mario Praz. Si trattava di Roberto Calasso che compiva ventuno anni proprio il giorno in cui venne reso partecipe del progetto, a Bracciano durante una festa di Ernst Bernhard, in una bella serata del maggio.
I libri di Bazlen, i “suoi” libri, quelli della Biblioteca, che non riuscirà a vedere perché morirà in una stanza d’albergo nel luglio del 1965, saranno “L’altra parte” di Alfred Kubin, ‘Padre e figlio” di Edmund Gosse, “Manoscritto trovato a Saragozza” di Jan Potocki, poi in ordine sparso, in varie collane, un trattato giapponese sul segreto del Teatro Ny, un libro su un immaginario mondo a due dimensioni, un testo religioso tibetano; e ancora Le grand jeu di Daumal e Gilbert-Lecomte, Kafka, Schnitzler, Freud, Bachmann, così tanta felice Austria al tramonto che Arbasino propose di cambiare il nome della casa editrice in Radetzky. L’Adelphi diventa presto il propulsore di una letteratura definita d’élite, e un’élite iniziata e molto selettiva, di proposte di spiritualità orientale, di mitologia classica e no. Classici difficili ora, inarrivabili allora. Per Bazlen erano semplicemente i libri che avevano “il suono giusto”, in cui si avvertiva chiara la “prima voltità”, la testimonianza pregnante di qualcosa che è accaduto o l’indizio di qualcosa che potrebbe accadere. Un criterio di scelta semplice e affascinante.
Ma Adelphi s’accolla pure il fardello di Nietzsche. A sentire Bazlen era l’unico modo per dar fuoco alle polveri di un nuovo progetto editoriale, visto che alla Einaudi non se la sentivano di pubblicare l’opera completa del temuto filosofo. Un mare di critiche. Dietro la compostezza della grafica beardsleyana e i placidi pastelli si nasconde una casa editrice votata all’irrazionalismo e alla decadenza, diranno fin dall’inizio. Compiacimento dello stupro, razzismo e una adelphizzazione della lingua, qualunque sia il libro, poi. E di vero c’è che Adelphi, tra i tanti percorsi, foglio dopo foglio, recupera “a sinistra” gli autori dell’irrazionalismo reazionario, del pensiero “negativo”, del Sacro e della Tradizione, che prima erano letti soltanto da una certa destra. Di vero c’è che Adelphi educa, propone un modo d’essere, impone letture non le suggerisce. Fa editoria come l’aveva fatta Manuzio o Wolff, i maestri sottili. E così fino a puntellare l’ipoteca idealista – con pubblicazione del Nietzsche debole, ma non solo – con un bel pugno nello stomaco al dilagare del perbenismo marxista, e la vittoria del moto profondo dell’anima, degli istinti e delle necessità superiori.
Se l’Einaudi era Giulio Einaudi, Calvino, Vittorini, Pavese, se la Longanesi era Leo Longanesi, se la Bompiani era Valentino Bompiani, allora Adelphi era e continua a essere Bazlen e applicazione del suo precetto.
Ma andiamo con ordine. Roberto “Bobi” Bazlen nacque nel 1902 a Trieste, quando Trieste, città di rinunce digerite in silenzio e di tragedie inespresse ma mediatrice culturale fra il cadente impero asburgico e l’Europa, aveva ancora davanti a sé diciotto anni di Austria. Nasce e cresce coccolato da tre madri e un padre che non era il suo. Bazlen è “mezzo ebreo” in una città di cui rifiuta perfino la definizione più diffiisa d’allora: “A occhio e croce, direi che Trieste è stata tutto meno che un crogiolo: il crogiolo è quell’arnese nel quale metti dentro tutti gli elementi più disparati, li fondi, e quel che salta fuori è una fusione, omogenea, con una distribuzione uguale di tutti i componenti, e con tutte le caratteristiche costanti – ora, a Trieste, che io sappia, quel fuso, non s’è mai prodotto…”.
Fino a sedici anni studia al Reai Gymnasium, una scuola in lingua tedesca, ed è allievo del professor Mayer, un uomo illuminato sempre teso a stimolare un atteggiamento critico e individuale che, anche grazie alla solidità dell’impostazione tedesca orientata a un confronto diretto con i testi letterari, proietteranno il giovane Bobi nel vivo della cultura mitteleuropea. Bazlen ignora i classici italiani, greci e latini e la letteratura italiana fino al Novecento. Come era prevedibile Trieste stessa e il complicarsi delle vicende familiari si riveleranno presto una morsa difficilmente sopportabile: “Spero di andar via da Trieste […] la vita qui mi è resa impossibile”, scrisse a Montale del 1926, otto anni prima di lasciare per sempre la città. Dopo Trieste sarà sempre un cercare rifugi senza mai piantare radici. Genova, Milano, Roma, via Margutta, 7. Siamo nel febbraio del 1939. Bazlen costruisce a margine delle sue solitudini una fitta rete di rapporti umani e professionali. Disinteressato al denaro, dotato di una proverbiale infaticabile curiosità, passava una buona parte della sua giornata a divorare libri, disteso sul letto, circondato ogniddove da volumi ordinati in un labirinto. Un vero e proprio mestiere di leggere che coincideva con il suo mestiere di esistere: interesse letterario e umano erano la stessa cosa: trattava gli autori, compresi i defunti, come persone conosciute, ne parlava come se ricordasse le loro parole – che doveva aver sentito con le sue orecchie – a memoria. La letteratura però per lui rimaneva solo un mezzo, uno strumento conoscitivo antropologico.
Ecco come descrive le sue giornate alla “négresse inconnue” Lucia Rodocanachi, traduttrice occulta per conto di Vittorini, Montale e Sbarbaro: “…ho poco da raccontarti, faccio una vita signorilmente ritirata, vedendo pochissime persone, e ora che è venuta a mancare la complicità antifascista, è venuto a cadere l’unico legame che avessi con tutta questa brava gente che ha aspettato ventidue anni per cominciare a far carriera… sono venuto a compromessi coi tempi che corrono, e sono decaduto a tal punto da bere vino dei castelli, però in belle bettole mit schoenen lauben [con bei pergolati] di cui ne scopro una ogni sera”.
Con una memoria sbalorditiva e una capacità di fare collegamenti fuori dal comune, curioso di tutto quello che in letteratura avveniva in Italia e fuori, Bazlen è esattamente come appare in un appunto di Valentino Bompiani del 21 maggio 1945: “Bobi Bazlen. Disposto a una più vasta, anche totale collaborazione: letture, segnalazioni, dirigere una collana. È straordinario, ha la memoria a bottoni. Si direbbe che ha letto tutto. Senza fermarsi? Gli dico di sì, subito, ma non si fermerà neppure con me; comincia a fiutare un compenso fisso; vuole un tanto al libro; poi si vedrà. Cos’è che lo muove e lo chiama; è tutto cultura e si direbbe non contenga altro dentro di sé. Ma qualche segno avverte che non è vero: forse legge per non pensarci. Si agita sulla sedia come se avesse la coda”.
All’inizio degli anni 50, una decina d’anni prima della nascita di Adelphi, Bazlen era già consulente editoriale di alcune tra le principali case editrici italiane, ricercato perché lettore raffinatissimo e profondo conoscitore della letteratura tedesca, francese e anglofona. Aveva scoperto Italo Svevo (“Vorrei far scoppiare la bomba Svevo con molto fracasso”, scriveva a Montale nel 1925), aveva suggerito e tradotto per primo Freud in Italia, ed era amico e editor segreto di Montale.
Bompiani, Foà, Calvino, Saba chiunque rimaneva colpito dalla sua enciclopedica conoscenza di autori e generi e dalla capacità di dare giudizi editoriali lungimiranti. Le sue frasi, quelle ricordate o quelle scritte da qualche parte, sono paradigmi lapidari e perentori: “Fino a Goethe: la biografia assorbita dall’opera. Da Rilke in poi: la vita contro l’opera”.
Proprio di quegli anni è una sua memorabile lettera editoriale a Luciano Foà, allora dirigente Einaudi. Consiglia e sconsiglia, perché Einaudi in fondo è una casa editrice popolare, la pubblicazione del “Der Mann Ohne Eigenschaften” di Robert Musil, “L’uomo senza qualità”. “Come livello non si discute, e (malgrado le riserve che vi farò e le infinite altre che si possono fare) va pubblicato a occhi chiusi. Come valore sintomatico, […] come valore assoluto […] rimane una delle faccende più grosse tra tutti i grandi esperimenti di narrativa non conformista. Da discutersi molto, invece, dal punto di vista editoriale-commerciale. […] Il romanzo è: 1) troppo lungo; 2) troppo frammentario; 3) troppo lento […]; 4) troppo austriaco. […] Però malgrado che il livello dei lettori italiani sia infinitamente più alto di quanto si ritenga comunemente, pubblicare un libro di questo genere è un rischio un po’ grosso; per leggerlo ci vuole tempo, pazienza, premesse culturali in comune con l’autore, e via dicendo.”
O ancora qualche anno dopo, è anche lui tra i lettori del discusso “Gattopardo”: “Suspicione verso il Gattopardo: giustificatissima. […] è il libro di un provinciale colto; con vera cultura (molto passata) nel sangue; responsabile; intimamente soigné, piuttosto simpatico; e ciò che in Italia conta molto, ricco (materialmente). – Come costruzione è affrettato […]; non è gran che; comunque la pagina più brutta vale tutti i ‘gettoni’. Riassumendo, un buon technicolor da e per gente per bene”. Non correva buon sangue – chissà perché – con Vittorini, che per ragioni diverse aveva anche lui bocciato il romanzo, ma in più di un’occasione non aveva esitato a manifestare senza mezzi termini e con un pizzico d’invidia a Calvino e Ponchiroli la sua antipatia per Bazlen. “Bazlen io lo lascerei ad Astrolabio.”
E tra i giudizi non editoriali è emblematico quello su “Ladri di biciclette”, un film amatissimo: “…credo sia il punto più basso nel quale sia caduta l’Italia – è piaciuto a tutti, perfino ai comunisti che hanno scambiato Stalin con De Amicis, e tutta Roma, compresa gran parte dei miei amici, ha pianto disperatamente – avevo detto per scherzo che un mondo che piange per ‘Ladri di biciclette’ non può che morire d’influenza – ma pochi giorni dopo è cominciata a Roma un’epidemia d’influenza in seguito alla quale la gente s’è messa a morire per davvero – abstossend!”.
Cosa ci rimane di Bazlen oltre ai ricordi di chi l’ha conosciuto? Poche pagine di riflessioni sui libri degli altri, il suo “Capitano di lungo corso” eternamente incompiuto e pubblicato postumo, altri quaderni di appunti. Molto o quasi niente per dirla come l’avrebbe raccontata lui che, come un mistico dell’anonimato, non voleva lasciare tracce tangibili del suo transito e gli piaceva vivere negli interstizi della cultura e della storia. Ci rimane il sentore della sua straordinaria capacità di influire sulle vite degli altri e di occultare la propria, la sua libertà di pensiero, il suo coraggio di dire ciò che pensava.
Bobi era sempre al di fuori e al di là di tutto pur continuando a rimanere dentro il fenomeno; la sua personalissima dicotomia arte-vita si risolveva nell’opposto della normalità: la letteratura non è una rappresentazione, ma il mezzo per ampliare la sua interazione con il mondo.
Ci rimane il suo non aver prodotto un’opera ma una limatura di frammenti, un ingarbugliato filo d’Arianna denso di paradossi ed enigmi. “Io credo che non si possa più scrivere libri. Perciò non scrivo libri. Quasi tutti i libri sono note a piè di pagina gonfiate in volumi. Io scrivo solo note a piè di pagina”.
Chissà se quella ferma decisione di restare inedito – anche le traduzioni che faceva erano con un nome fittizio o con le sue iniziali – fosse connaturata nella consuetudine di affidarsi a segreti quaderni e fogli, la paura di deludere chi da lui si aspettava qualcosa di immortale o una maturata convinzione che la grandezza può stare nella rinuncia, nel silenzio. “Un tempo si nasceva vivi e a poco a poco si moriva. Ora si nasce morti – alcuni riescono a diventare a poco a poco vivi”, scrisse una volta Bazlen convinto che vivere non fosse altro che inventare nuovi luoghi dove naufragare.
E forse chi ci ha permesso di comprendere più a fondo l’animo di Bazlen è stato Daniele Del Giudice col suo sofferto Bildungsroman “Lo stadio di Wimbledon”. Del Giudice sceglie di sviscerare Bazlen per penetrare sé stesso. La disamina del sacrificio dell’intenzione della scrittura andava scandagliata attraverso i luoghi della memoria, interviste a chi Bazlen lo ha conosciuto e una ricostruzione incrementale degli stati d’animo. Una pacata ma sismica presa di coscienza che trova compimento nelle parole che Del Giudice fa dire alla compagna di sempre di Bobi, Ljuba Blumenthal: “La sua vita erano le altre persone, quello che lui poteva capire di loro, o fargli capire”, “lui non cercava di immaginarsi come fosse una persona, lui lo era. E quando ha scoperto che questo era il suo posto nella vita, non ha potuto più scrivere. Aveva capito dove stava la sua forza, e stava nelle persone…”.
Quello di Bazlen è un naufragio volontario perché l’incompiutezza non è un limite ma un punto d’arrivo, vivere cancellando, e forse è anche per questa ultima coerente contraddizione che affida i suoi scritti, pubblicati postumi da Adelphi, a Silvana Radogna con l’ordine di distruggerli sapendo benissimo che mai l’avrebbe fatto. E lui finalmente può vivere nei campi, come un giglio.
Di Leonardo Luccone

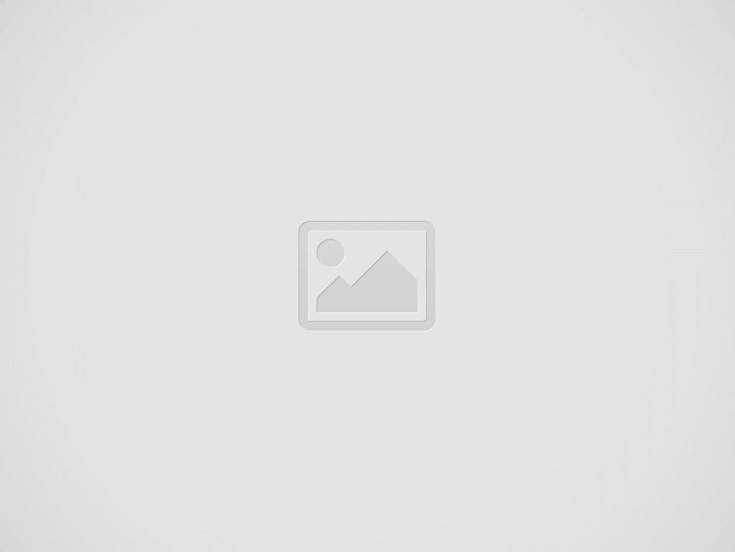

View Comments (1)
grazie per questa bellissima testimonianza su un personaggio cruciale nel mondo letterario italiano - e le cui tracce sono ancora vivissime - ma di cui, in realtà, ben poco si sapeva - se non l'ammirazione che i più grandi avevano per lui !