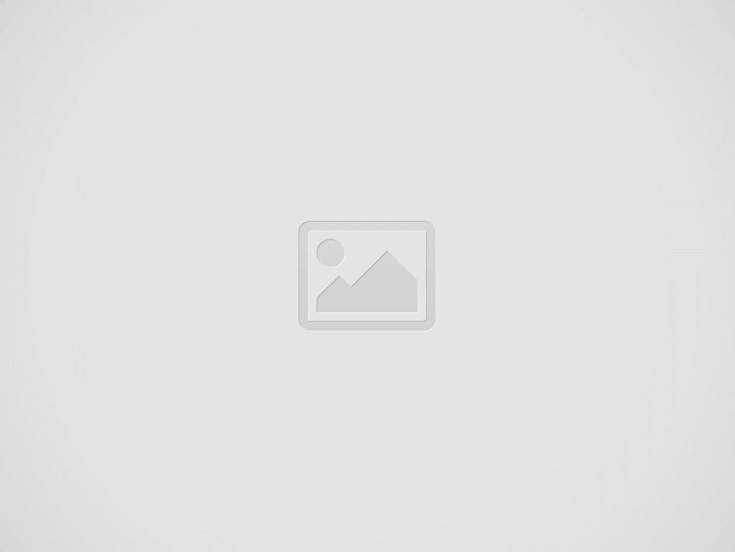Quando avevo comperato Tacì, un cucciolo di siamese, Remo aveva subito posto le sue condizioni, “non voglio avere niente a che fare col gatto”. Abitavamo in una casa molto grande dove lo studio era separato dalla zona giorno da un corridoio di tredici metri e non c’era quindi pericolo che il cucciolo potesse disturbarlo. Tacì avevo presto intuito che non io andavo sedotta (lo ero già), non il personale di servizio (addetto al suo cibo e alle sue pulizie), ma quel personaggio silenzioso che non si occupava di lui.
La seduzione non avvenne nei luoghi deputati per la conquista, dove si mangia o si gioca, ma nella stanza proibita, lo studio con vista sulla terrazza dove Remo pensava e scriveva. Sicuro di sé, tempo una settimana Tacì era balzato con eleganza sulla scrivania, si era accovacciato su un foglio bianco e aveva cominciato a fissare Remo con occhi innocenti. Di tanto in tanto quello sguardo fu ricambiato, tutti e due avevano occhi azzurri, finché, calcolato il momento opportuno, il cucciolo s’inerpicò sulla spalla di Remo in un tripudio di fusa. Era molto leggero, pochi etti di pelo color tortora e mascherina marrone, e Remo non ebbe il coraggio di ribellarsi a feste così disinteressate. Disinteressate, sì, perché mentre da noi pretendeva cibo, e correva in cucina a chiederlo con miagolii prepotenti, quando il filosofo faceva colazione si limitava a fargli compagnia come un ospite molto corretto. Un ospite tanto discreto che Remo, abituato a distendersi dopo mangiato, gli aveva concesso di fargli compagnia anche a letto in quella mezz’ora pomeridiana.
Fu in quell’occasione che ci rendemmo conto che il gatto era geloso come un Otello. Conquistato quel diritto pomeridiano, se entravo in camera per pochi minuti si ergeva come un piccolo serpe e soffiava furioso per mandarmi via. Me ne andavo. Nessuno poteva intromettersi nel suo tête à tête.
(da: Maria Brunelli Cantoni, “Il filosofo e il suo gatto”, in “Remo Cantoni”, a cura di M. Cappuccio e A. Sardi, Cuem, Milano 2007, pp. 47- 49)