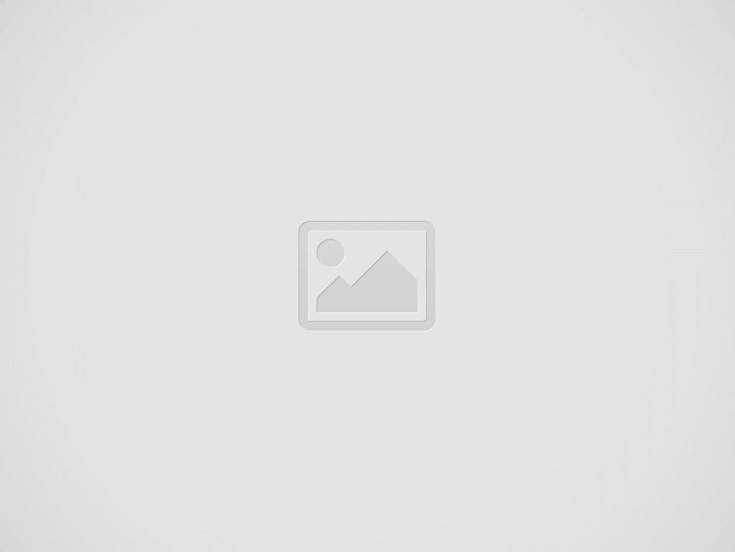Dopo https://www.grey-panthers.it/ideas/letture/approfondimenti-sullo-stato-islamico/ continua l’approfondimento sullo Stato Islamico
Lo strano caso di John Cantlie
C’è un altro uomo con la tuta arancio nella storia recente del califfato. Prigioniero come gli altri. La fine per lui dovrebbe essere quella di sempre. Verrà decapitato. Jonh Cantlie, reporter inglese rapito in Siria nel novembre 2012 è stato il compagno di prigionia di James Foley (di cui il mondo ha guardato la decapitazione), ma la sua vicenda a un certo punto ha preso un’altra piega e ci ha messo di fronte a un altro livello di questa sfida che impegna, non solo gli strateghi militari, ma ognuno di noi, costretto a fare i conti con un racconto di cui – malgrado noi stessi – stiamo diventando strumenti.
Cantlie compare per la prima volta il 18 settembre 2014. Noi quel giorno vediamo un singolo video dal titolo “Lend me your ears” che più o meno vuol dire “A me le orecchie (…)” cioè “statemi a sentire” e il sottotitolo è “Messaggi da un detenuto britannico”. John Cantlie è il prigioniero, davanti a due telecamere, sapientemente illuminato, appoggiato a un tavolo e ha un messaggio da dare al mondo. Ed è un messaggio tanto complesso che nessuno è ancora in grado di capirne fino in fondo la portata.
Cantlie racconta la storia della sua cattura e, a un minuto dall’inizio del filmato, dice «Sì, sono un prigioniero, questo è vero, ma il mio governo mi ha abbandonato (…)» e continua «voglio usare questa opportunità per raccontare alcuni fatti (…)».
Il gioco è svelato. Il prigioniero Cantlie diventerà lo strumento della controinformazione del califfato. Lo capiamo quando, a 1’03”, fa irruzione nel ragionamento la parola “fatti” pronunciata da un giornalista britannico che non nega la sua condizione, ma ci fa capire che comunque ha da dire delle cose diverse da quelle che ci aspettiamo.
È quello il momento del ribaltamento di piani, il sovvertimento delle regole della comunicazione. Si affaccia sulla scena una realtà diversa da quella che fino a quel momento era chiara nella mente di ognuno. C’è un altro angolo della storia che, da qui in poi, verrà veicolato dal prigioniero reporter; è la dichiarazione della necessità della controinformazione: «vi dimostrerò la verità su come i media occidentali tentano di trascinare l’opinione pubblica verso l’abisso di una nuova guerra contro l’islam» dice, annunciando la serie.
Quel che si vede è studiato con tanta sapienza da farci venire il legittimo dubbio che questo, ancor più che le decapitazioni cruente, sarà lo strumento violento del jihad contro i suoi nemici: noi. Uno strumento ancor più efficace perché cela la sua crudeltà dietro il racconto, perché riesce a farci dimenticare che John Cantlie è un prigioniero e lo ammanta falsamente di quel ruolo da narratore tanto coerente con il suo accento British.
Certo è che, nelle ore in cui la Casa Bianca, contraddicendo ogni annuncio precedente, sta nuovamente prendendo in considerazione l’ipotesi di tornare in Iraq “boots on the ground” con i marines per liberare Mosul, suonano ancora più sinistre le parole che lo sconosciuto e geniale regista dell’operazione Cantlie fa recitare al suo personaggio nella terza puntata della serie “Inside”, quella dei reportage sul campo. Il britannico ricorda che i combattenti dell’IS sono preparati alla battaglia e spiega agli americani di non illudersi che non ci sarà alcuna “operazione chirurgica” che possa portarli a ottenere risultati sul terreno, che bisogna per forza sporcarsi le mani. E spiega: questa per IS è una «win-win situation». Nel suo lungo discorso Cantlie cita i giornali delle settimane precedenti, gli articoli, gli opinionisti. Solo l’arancio della tuta da prigioniero sottolinea la sua condizione.
Ma quando John Cantlie il 28 ottobre appare dentro Kobane assediata per mostrarci l’altra faccia della realtà, diventa davvero difficile ricordarsi che lui è il prigioniero e non il reporter che sta dalla parte dell’IS. E questa volta il video ha la nuova sigla dedicata ai reportage “Inside”. La rappresentazione della verità dell’IS deve basarsi su fatti, convincenti, verificabili. Per questo il reportage si apre con immagini dall’alto che la didascalia ci precisa essere prese da un drone dell’esercito dello Stato Islamico. A 34” dall’inizio, con un effetto grafico non banale dal punto di vista della complessità di realizzazione, entra sulle immagini in movimento il reporter Cantlie che non indossa più la tuta arancio da prigioniero. Piuttosto è completamente vestito di nero come la maggior parte dei combattenti dell’IS quando non indossano le mimetiche. Il racconto di Cantlie è una sfida alla strategia americana, è ironico nei confronti delle dichiarazioni di Kerry, sembra molto più tranquillo. La barba sta ormai crescendo sul suo viso e, soprattutto, la regia del suo racconto si fa sempre più accurata. Nonostante si tratti di riprese in esterna in una città in cui si combatte, il regista del video ha anche questa volta due telecamere a disposizione. La registrazione viene fatta in modo accurato, con calma. Non c’è nessun segno che faccia pensare alla fretta. Cantlie confuta le informazioni venute dal fronte curdo che parlerebbero di grandi battaglie. Dice «la situazione è calma, ci sono sparatorie sporadiche, come sentite» e ricorda in chiusura che comunque la vittoria è dei mujaheddin che sono specializzati nella guerriglia urbana.
Cantlie dà voce a quello che tutti temono. Esattamente come nel filmato di Mogadiscio, tutto sembra fatto per “essere vero”, solo che la verità è verosimiglianza, null’altro. Una verosimiglian- za sapientemente ricreata attraverso codici a noi familiari. Una verosimiglianza fatta dall’uso delle parole, della grafica, delle luci. Fatta di “pose” narrative in cui ci lasciamo andare – nostro malgrado – a seguire il racconto dimenticandoci che lo strumento della propaganda è un uomo che potrebbe essere ucciso alla fine di ogni reportage. O, perché no, magari un giorno anche durante uno di questi.
Con il secondo dei reportage della serie di “Inside”, quello sulle strade di Mosul1, diffuso in rete il 3 gennaio di quest’anno, il senso di normalità viene accentuato dal giro in motocicletta che il prigioniero reporter (sempre più reporter e meno prigioniero, almeno nella rappresentazione) fa nella città governata da IS. C’è una distanza siderale tra il racconto della città tranquilla e le descrizioni occidentali della vita nei luoghi caduti nelle mani dello Stato Islamico. Il senso di rilassatezza, di tranquillità apparente si coniuga perfettamente con i racconti fatti nei siti web dai giovani foreign fighters che incitano gli altri amici rimasti in Europa o in America a partire per l’eccitante avventura della “guerra santa”.
È il 9 febbraio che John Cantlie riappare con un giaccone marrone, apparentemente in ottima forma, alla periferia di Aleppo. Si prepara a realizzare l’ennesimo reportage della serie “Inside”, dalla città martoriata da anni di guerra civile. Cantlie annuncia che sarà l’ultimo di questa serie.
Cosa significa? Nessuno può dirlo. Potrebbe essere che i geniali registi dello Stato Islamico si stiano preparando a nuove serie ancora più efficaci, utilizzandolo come anchor. Potrebbe significare, impossibile dimenticarlo, che Cantlie sta per essere ucciso, esattamente come è accaduto ai suoi compagni di cella. Se così fosse è possibile immaginare che proprio il giorno della diffusione del video il rituale si sia già compiuto. Ma in fondo, perché sbarazzarsi di un cantastorie tanto efficace? A questo, sostanzialmente, è legata la sopravvivenza di John Cantlie. In questo ultimo reportage di 12 minuti il prigioniero reporter ci porta nelle strade della città massacrata, e da lì descrive ancora una volta quelle che chiama «le menzogne dell’occidente». Si visita un silos di grano «che viene distribuito alla popolazione a prezzi più bassi di quelli del mercato», e una scuola dove alcuni alunni recitano il Corano e vengono formati i guerriglieri di domani. «Non è vero che sotto lo Stato Islamico l’educazione soffra», dice Cantlie che mostra anche la sala d’attesa di un tribunale della sharia, la legge islamica definita da Cantlie «giusta e semplice». Dal mercato di Aleppo si fanno vedere i droni degli Alleati che sorvolano una zona “completamente civile” e sganciano bombe con il rischio di uccidere innocenti. Poi, l’intervista a due mujaheddin. Il primo si dice convinto che non serve a niente uccidere i capi di Isis: «Andremo avanti più forti». Il secondo invece parla perfettamente francese. È un foreign fighter, è evidente, e proprio in francese rende omaggio agli attacchi di Parigi. E va oltre: «incoraggio tutti i miei fratelli rimasti in Francia e in Occidente a difendere la religione (…) siete seduti sui vostri divani mentre altri musulmani si stanno facendo massacrare, quale sarà allora la vostra scusante davanti ad Allah? (…)». L’incoraggiamento è a prendere la via del jihad, a gettarsi nella lotta. Il meccanismo del reclutamento è stato messo in atto ancora una volta in questo video di grande qualità visiva e grafica. Ma un piccolo passaggio ci fa tornare a quanto raccontato fin qui. C’è una sorta d’inciso, nel racconto, che fa pensare a quei fogli di contro informazione prodotti nel 2007. Cantlie, infatti, attraversa una strada e mostra una piccola costruzione prefabbricata che definisce il “media center”. Sul banchetto che s’intravede all’interno fanno bella mostra di sé diversi computer. Un ragazzino stampa fogli e li distribuisce ai passanti. È il modo per dire quello che lo stato islamico sta realmente facendo per i suoi cittadini, almeno secondo la loro visione.
Dal media center di Falluja di Musab Abu al-Zarqawi del 2005 siamo arrivati qui. Dieci anni dopo l’esigenza è esattamente la stessa. Costruire un sistema di controinformazione che dia ai cittadini la possibilità di “informarsi” al di fuori dei circuiti ufficiali gestiti dai soliti protagonisti: gli americani e gli stati del Golfo, ognuno con una sua agenda specifica.
Nel frattempo, finché il giochino vagamente sadico continua, Cantlie è diventato il reporter multimediale dell’IS. I suoi articoli appaiono anche su Dabiq, la patinatissima rivista dello Stato Islamico giunta al suo settimo numero. Una rivista tutta pensata per la comunicazione globale, per la diffusione del messaggio attraverso codici che anche i musulmani cresciuti in Occidente o i convertiti possano riconoscere come propri.
Dabiq, un magazine patinato per il jihad globale
La voglia di dotarsi di un sistema di comunicazione articolato, multimediale, su diversi piani è presente in tutte le aggregazioni jihadiste e anche nel peculiare mix d’insorgenza legata alla dinamica territoriale e jihad che caratterizza lo scenario iracheno dopo il 2004.
L’idea di produrre un magazine patinato, in grado di veicolare il proprio messaggio, ma anche di ricomporlo in un quadro analitico più complesso, che vada al di là della singola comunicazione puntuale, è parte di questo progetto. Al-Fursan, Sada al- Rafidayn sono le riviste del jihad iracheno del 2006 e 2007. Si tratta di prodotti editoriali piuttosto impegnativi, corposi, spesso dotati di un significativo impianto fotografico, che rimangono comunque ancorati a una rappresentazione tradizionale sia dal punto grafico che dell’impostazione generale della rivista. Il salto nella contemporaneità mediatica, dal punto di vista della carta stampata, il qaidismo lo fa con Inspire. È il vero magazine moderno pensato per un pubblico globale, giovane, radicalizzato e di lingua inglese. L’ultimo numero è di dicembre 2014. Tra le notizie politiche, i consigli operativi (persino su come farsi le bombe, antico tema legato a tutte le eversioni e non certo solo agli estremismi mediorientali) e le testimonianze dei mujaheddin. È proprio nel numero di marzo del 2013 che Inspire mette il nome di Stephane Charbonnier, direttore del settimanale satirico Charlie Hebdo, nell’elenco dei 10 most wanted del qaidismo.
Inspire è considerato il prodotto di riferimento della galassia qaidista. Per questo, alla sua nascita, il califfato non ha potuto far altro che produrre autonomamente un magazine concorrente (ancorché del tutto coerente dal punto di vista del messaggio): e così nasce Dabiq.
Dabiq è patinato, sofisticato, pubblicato in diverse lingue a partire dall’inglese. Si autodefinisce come un «magazine focalizzato sulle questioni del tawhid (l’unità), manhaj (la ricerca della verità), hijra (le migrazioni), il jihad (la “guerra santa”) e la jama‘a (la comunità)».
La cosa impressionante è la modernità con cui questi temi vengono trattati: ancorché intrisi di analisi dottrinali e di considerazioni filosofico-religiose, i pezzi seguono la comune articolazione dei magazine di current affairs: ci sono gli editoriali, i reportage, le analisi.
Ma per capire la genesi di Dabiq e gli obiettivi del suo messaggio è essenziale partire dal nome. Secondo i riferimenti letterari dell’islam, Dabiq, piccola cittadina del nord della Siria al confine con la Turchia è teatro, nel hadith 6924 (la raccolta dei pensieri di Maometto), della battaglia finale contro i “crociati” prima che il “Messia” ritorni. Il simbolo è fortissimo, eppure secondo gli accademici più raffinati di studi coranici, questa sarebbe una lettura riduttiva di un hadith assai più complesso, che richiederebbe ben altra lettura. Ma non è a quello che punta il califfato. L’elemento chiave è la simbologia guerresca nel suo grado di massima semplificazione. E non è un caso se – ancora una volta a provare il legame profondo tra l’oggi del califfato e il passato di guerriglia in Iraq – a usare questa stessa simbologia è proprio Abu Musab al-Zarqawi poco prima di essere ucciso dai missili americani nel 2006. «La scintilla è stata accesa in Iraq – dice – e le sue fiamme cresceranno fino a bruciare gli eserciti dei crociati a Dabiq». È quella stessa frase di Dabiq che appare sopra l’indice, all’inizio di ogni numero della rivista. Abu Musab al-Zarqawi è – come già avevamo visto – ancora una volta indicato come il vero referente intellettuale e politico, il precursore del califfato e del suo sistema simbolico e valoriale. Lui, e non Osama bin Laden, dunque il califfato, e non al-Qaida, costituiscono il modello vincente.
Il riferimento a Dabiq torna a galla continuamente. L’ultima volta in ordine di tempo è il 16 novembre 2014 quando viene pubblicato nel web il video in cui il boia dall’accento cockney comunica la morte dell’ostaggio Peter Kassig (un ex ranger americano convertito all’islam): lo si sente dire letteralmente «qui seppelliamo il primo “crociato americano”, a Dabiq, e attendiamo desiderosi l’arrivo del resto delle vostre armate», mentre la telecamera inquadra la testa mozzata del giovane. Gli uomini vestiti di nero attendono l’arrivo delle armate di Roma, dei “crociati”, dunque. Le armate di cui parlava l’hadith 692420. Le armate che arrivano a Dabiq. Guarda caso il nome del magazine più trendy dell’IS.
È il codice altamente simbolico cui lo Stato Islamico ci ha ormai abituato. Nulla è lasciato al caso. Un nome antico di secoli usato per un magazine patinato, un messaggio legato agli atti del profeta mediato dalla storia e dalla tradizione, viene però impiegato strumentalmente nella confezione di un contenuto mediatico di contemporaneità impressionante: il risultato deve far riflettere.
Altro elemento fondamentale – e lo vedremo nell’analisi puntuale dei numeri pubblicati – è che spesso all’interno del nuovo numero della rivista ci si riferisce a fatti avvenuti solo pochi giorni prima. Questo significa che Dabiq non nasce in modo casuale, amatoriale, ma al contrario esiste una vera e propria redazione che vaglia i contenuti, li scrive “giornalisticamente”, li impagina graficamente in modo impeccabile e li pubblica in più lingue. Tutto in pochissimi giorni.
Se analizzati uno a uno, i titoli della rivista pubblicati dallo scorso giugno a oggi sono evocativi, puntano a diffondere un messaggio assai preciso, in grado d’incuriosire e coinvolgere: ad allargare la platea dei lettori potenziali. E, in effetti, è evidente come il target di Dabiq sia un lettore interessato ai temi dell’islam politico, certo, ma non necessariamente un jihadista già convinto.
È un lettore cui, con grande abilità, vengono spiegate passo dopo passo le ragioni, il senso e la progettualità del califfato. Una miscela esplosiva per chi è già avviato sulla strada del jihad; un messaggio “d’ispirazione” per chi, non jihadista, sia attraversato dal dubbio.
Il primo numero di Dabiq è del 5 luglio 2014. È passato un mese dalla conquista di Mosul. E il titolo di copertina recita: “Il ritorno del califfato”. È un numero politico, programmatico in cui il programma dello Stato Islamico viene declinato con grande attenzione. Spiega già, per attrarre altri, quanto il progetto del califfo al-Baghdadi sia vincente, quanto il controllo territoriale sia forte, quante tribù abbiano già aderito al progetto. Chi scrive gli articoli sa che la posta in gioco è alta: l’IS in questo momento sta lanciando l’attacco a tutte le altre formazioni jihadiste a livello globale (al-Qaida in primis). Con questo numero di Dabiq lo stato islamico vuole lanciare il messaggio che la proclamazione del califfato è corretta, sia da un punto di vista politico sia dottrinale, e che al-Baghdadi e i suoi stanno riuscendo meglio degli altri a combattere il proprio jihad, di cui in questo momento parlano con toni vittoriosi.
Ogni numero di Dabiq meriterebbe un’approfondita analisi a sé stante: il secondo esce il 27 luglio 2014, e s’intitola: “l’Alluvione”. Il terzo è di ottobre e parla della chiamata alla migrazione “hijra”, paragonando il viaggio di chi sceglie di migrare e trasferirsi nello Stato Islamico con il viaggio del Profeta da Mecca a Medina. Ma è la copertina del quarto numero, quello pubblicato il 22 ottobre, che getta nel panico più di un responsabile della sicurezza in Occidente. Sull’obelisco in piazza San Pietro, grazie a un fotomontaggio, sventola la bandiera nera del califfato. “La crociata fallita” è il titolo di prima pagina, che rimanda a un articolo interno e descrive il fallimento di tutte le azioni militari delle forze della coalizione contro IS.
Dabiq numero cinque è pubblicato il 22 novembre 2014, col titolo programmatico: “Consolidarsi ed Espandersi”. Il ragionamento politico è la continuazione ideale del primo numero: l’obiettivo evidente è quello di porsi come riferimento centrale di tutti coloro che conducono la “guerra santa” e non solo. È quella di essere riconosciuti come “il califfato” da tutte le cellule qaidiste sparse nel mondo. È l’idea di diventare l’entità politica e religiosa di riferimento cui corrisponde anche una realtà territoriale. Diversi messaggi, in rete, sui social network, attraverso i siti d’informazione “ufficiale” accreditano questa stessa visione. Ma è significativo che l’Organizzazione Centrale senta il bisogno di esprimerla in modo organico sul magazine ben confezionato di risonanza globale.
Nel sesto numero di Dabiq l’articolo di copertina è dedicato a un reportage su al-Qaida nel Waziristan. All’interno il tema viene sviluppato in un lunghissimo reportage, di notevole interesse, in cui un mujaheddin giordano racconta il suo viaggio attraverso l’Afghanistan e la zona tribale tra Pakistan e Afghanistan; la sua ricerca del luogo ideale dove combattere il jihad, ma soprattutto fa capire le differenze d’impostazione tra alcune realtà qaidiste e la visione del califfato nella storia che si sviluppa giorno dopo giorno. Al di là delle valutazioni filosofico-religiose, il reportage – oltre a confermare la posizione critica (specie sul piano dottrinale e operativo) del califfato nei confronti di al-Qaida tradizionale, offre uno spaccato unico sulla vita da jihadista contemporaneo e, soprattutto, ha il sapore della grande avventura. Un elemento irresistibile per ragazzi alla ricerca di modelli eroici.
Per questo vale la pena fermarsi un istante sullo stile adottato dall’autore del reportage e dal suo traduttore. Il lungo racconto è punteggiato da decine di termini legati al jihad che non vengono semplicemente tradotti in inglese, al contrario, vengono sistematicamente lasciati in arabo e poi tradotti. È un metodo preciso, educativo, che rivela la volontà di costruire una familiarità con i termini jihadisti anche per chi ha poca dimestichezza con l’arabo. Siamo di fronte a un prodotto perfetto per il reclutamento dei foreign fighters: il proselitismo su scala globale è in opera.
Altri due elementi chiave intervengono nella costruzione del numero sei del magazine: l’ennesimo reportage di John Cantlie, ormai trasformatosi (ma fino a quando?) nel raccontatore multimediale dello stato islamico; e il pezzo di apertura dedicato all’attacco alla cioccolateria di Sidney. L’elemento più interessante è che il racconto è tutto mirato a far vedere come i media occidentali abbiano macchiato il personaggio di Haron Monis (un mujaheddin dello Stato Islamico) facendone un ritratto negativo per discreditarlo. È il ritorno alla guerra mediatica: alla battaglia delle informazioni per la quale gli uomini dello Stato Islamico decidono di combattere sistematicamente. L’analisi dell’azione di Sidney e la critica ai mezzi d’informazione occidentali fa il paio con il contro-racconto di Cantlie a Kobane, Mosul e Aleppo.
Ma non è finita qui. Sulla piattaforma multimediale della comunicazione dello Stato Islamico, gli elementi più succulenti della narrazione vengono valorizzati. Esattamente come si fa nei media occidentali, le “esclusive” devono essere fruite dal maggior numero di lettori e ascoltatori possibili. Per questo, l’esclusiva del numero 6 di Dabiq è la confessione di Muadh al-Kasasbeh, il pilota giordano fatto prigioniero dopo l’abbattimento del suo jet.
Ma il numero 7 supera, in termini di “contemporaneità” tutto quanto analizzato fin qui. È sostanzialmente un numero tutto di risposta a quanto accade in Europa. Viene pubblicato l’11 febbraio 2015, a un mese esatto dalla manifestazione di Parigi ed è tutto sulla rivendicazione dell’attacco a Charlie Hebdo, con l’intervista alla moglie di Coulibaly (qualcuno dubita dell’autenticità di questa testimonianza), con il racconto dei due jihadisti belgi sfuggiti ai servizi segreti di tutta Europa e la giustificazione religiosa della decisione di mandare al rogo Muadh, il pilota giordano. Insomma: la reazione mediatica a tutto quel che è accaduto nell’ultimo mese. È la dimostrazione che in questa fase informazione e controinformazione giocano sullo stesso terreno, negli stessi tempi e con mezzi sempre più simili.
L’intervista, o meglio la confessione trasformata in intervista, del pilota giordano pubblicata su Dabiq n. 6, merita una riflessione. Ancora una volta in rigorosa osservanza dello stile d’impaginazione dei media occidentali, il redattore della rivista (sembra davvero opportuno chiamarlo così), alterna domande e risposte con i neretti: quando c’è la domanda della “rivista” scrive Dabiq, quando c’è la “risposta” del pilota scrive murtadd (l’apostata). Ma questo stile fa sì che il lettore abbia la sensazione che chi fa domande per conto della rivista sia un elemento terzo del discorso. Un soggetto che fa un oggettivo racconto della situazione. Un intervistatore, e non l’aguzzino che sta interrogando il pilota.
E, infatti, l’articolo, che comincia descrivendo l’abbattimento del jet di Muadh e i fatti successivi, introduce il seguito dicendo «E questa è l’intervista con il murtadd, con l’apostata». La propaganda sapiente è esattamente questo: trasformare in un’intervista per lettori globali, un interrogatorio a un prigioniero che di lì a poco verrà arso vivo.
Le foto a corredo dell’“intervista” sono fatte in contemporanea con il video che ritroveremo nel filmato agghiacciante del rogo; forse sono addirittura frames estratti dal video stesso. Il testo dell’intervista è la trascrizione letterale dell’interrogatorio- confessione contenuto nel video stesso.
Se ne deduce che il messaggio preparato per la diffusione video viene utilizzato su tutte le piattaforme a disposizione: la propagan- da del califfo conosce già le regole dell’ottimizzazione nella produzione dei contenuti. E la riflessione sull’incrocio tra i vari media e l’utilizzo multipiattaforma dei contenuti, ci porta dentro la questione della costruzione del video, dovremmo meglio dire del film, del rogo in cui viene ucciso Muadh al-Kasasbeh. Proviamo a ripercorrere insieme quei 22 minuti.
L’inizio è quello classico del film d’azione americano (potrebbe essere uno della serie dei “Bourne”). Viene costruito l’antefatto: sequenze di re Abdallah di Giordania che parla in inglese con gli alleati americani, che manda uomini armati verso altri fratelli musulmani. In risposta, alternati nella sequenza, i canti della battaglia. L’alternanza continua, appaiono le immagini dei luoghi della battaglia: musulmani contro musulmani.
Gli inserimenti grafici e gli effetti sonori sono ancora una volta quelli da videogame militare. Si nota una qualità straordinaria di montaggio e selezione immagini. Viene ricostruita in 3D la sagoma del caccia in volo verso la Siria, poi appaiono le fiamme nel villaggio, i pezzi dell’aereo e il titolo “Healing the believers chests (…)”.
Un montaggio sincopato di tutti i telegiornali del mondo arabo che danno la notizia dell’abbattimento del caccia, ci riporta nella storia. Le infografiche si susseguono poi sentiamo la voce del pilota che ricostruisce punto per punto la missione (è esattamente il testo pubblicato come “intervista” su Dabiq).
È evidente il grande lavoro di documentazione che i “registi” del film hanno dovuto fare: vengono inserite tutte le immagini delle piste di volo degli aeroporti da cui decollano gli aerei della coalizione, le coordinate geografiche dei raid. L’obiettivo di Muadh è Raqqa, Siria. È il 24 dicembre.
L’intervista-interrogatorio è girata con due telecamere. Lo stile e l’impostazione della luce e delle riprese sono assolutamente simili ai primi video di John Cantlie: c’è una mano, o almeno un’uniformità di specifiche tecniche, assolutamente evidente. L’importante lavoro grafico crea uno sganciamento dalla realtà, ci trasporta in codici che tipicamente associamo alla cinematografia, al “verosimile” e non al “vero”. Ci distaccano dalla compassione e dall’orrore istintivo per quel che sta toccando in sorte al giovane pilota giordano.
Le sequenze d’immagini del jet in volo si susseguono con il dramma dei suoi obiettivi: villaggi distrutti, bambini mutilati, bruciati. La costruzione della vittima è chiara. Il pilota viene descritto come un essere che si è macchiato di crimini atroci e la sua fine crudele potrà essere solo considerata un atto di giustizia. Nessuno lo dice. Questo non è un video esplicitamente a tesi. Sono le immagini a dirlo, è la costruzione del racconto a portare a queste conclusioni. Le stesse che faranno sì che quando, il 5 febbraio, il video verrà mostrato nelle strade della città siriana di Raqqa22, verrà accolto con approvazione, non con orrore, da uomini e adolescenti spettatori.
Dalle immagini di guerra, dalle scene sincopate del topgun in azione c’è un salto. Uno stacco narrativo secco. Perfetta costruzione di climax. Dal caos della guerra siamo in una situazione sospesa, rarefatta. Muadh cammina attraverso le macerie (forse quelle stesse provocate dalle bombe del suo caccia?). Una luce straordinaria sospende il tempo, c’è un silenzio irreale. Lui cammina lento, attraversa il silenzio. Alcuni rapidi fotogrammi della notte della battaglia attraversano come rapidissimi flash la sua camminata. Tutto attorno appaiono loro, i combattenti dello Stato Islamico. Ma le loro divise raccontano qualcosa di nuovo. Questa non è più una brigata raffazzonata di persone con addosso abiti militari recuperati alla bell’e meglio. Le divise di questi uomini mascherati sono immacolate. Nuovissime. Loro, perfetti. Lui li guarda, muto. Un’aria stupita, sorpresa. O forse solo stordita (non sappiamo quanto sia stato picchiato, se sia stato drogato). Certo lo sguardo di Muadh al-Kasasbeh è il tassello chiave di una costruzione filmica straordinaria.
Poi un altro cambio di ritmo, un’altra sequenza. Lui è già nella gabbia: la sua tuta arancione da prigioniero, bagnata. Gli uomini in divisa immobili, tutti intorno. Disposti da un regista sapiente. Solo uno è in azione. Ha in mano bastone intriso di liquido infiammabile. La voce fuori campo ce lo descrive come il «comandante di una regione dello Stato Islamico colpita dai bombardamenti».
Le sequenze che seguono descrivono l’incubo di un uomo arso vivo. Eppure le sue grida sono tenute a volume basso, vengono quasi coperte. In questo punto esatto si ha l’idea che qualcuno abbia deciso quale è il livello “accettabile” dell’orrore. Il messaggio ha un suo dosaggio ad hoc.
La scena del rogo viene tagliata. È il cadavere carbonizzato ora a venire mostrato, e la ruspa, che era apparsa nelle prime immagini si muove, gli butta addosso sassi e detriti. Lo copre di pietre. La sequenza finale riprende il ritmo e lo stile dell’azione iniziale: questa volta non è più il racconto dell’operazione di attacco ma le foto, i nomi, le carte d’identità di cinquanta piloti giordani che ogni giorno si alzano in volo contro l’IS. La fine del film è tutta per loro. Sono i nomi e i volti dei most wanted del califfo che chiudono il film d’azione.
L’intreccio tra le varie parti della narrazione: interrogatorio, camminata, gabbia, fanno pensare a una registrazione avvenuta in momenti diversi fra loro, secondo un copione scritto a priori. Nulla è lasciato all’improvvisazione: gli uomini in divisa, la luce nei vari punti dell’azione, i simboli.
Ottenere un prodotto finale di questo livello non è banale, nemmeno per case di produzione occidentali. La coerenza tra i diversi video, l’uniformità di metodi di ripresa e montaggio, la diffusione sistematica e coerente sui social network, fanno pensare a una regia unica. O almeno a una mente (o un piccolo gruppo) assolutamente sofisticata, che conosce alla perfezione le tecniche di montaggio, di scrittura, di spettacolarizzazione. Tecniche al crocevia tra cinematografia e produzione di videogames. Per queste ragioni alcuni analisti tendono a porre al vertice dell’organizzazione che si occupa di social media e produzione multimediale, tra gli altri, Ahmad Abu Samra.
Lui, cresciuto a Stoughton, in Massachusetts, è un genio all’università, un’eccellenza accademica. Diventa un grande esperto nel campo della comunicazione e dell’informatica, arriva a essere assunto in una società di telecomunicazioni statunitense. È lì che Abu Samra interiorizza la logica del marketing che ora starebbe applicando nella promozione del brand IS. Sarebbe la sua, la mente brillante alla base dell’idea di ricostruire una “narrativa” ad hoc per le imprese del califfato traducendole in una serie filmata tra l’action e il videogame; trasformando i simpatizzanti del web in combattenti virtuali. Il risultato sono momenti di adrenalina a basso costo condite da epica e senso di «una missione da compiere per ristabilire la giustizia» che diventano materiale esplosivo nella campagna di reclutamento tra i giovani sensibili al richiamo del jihad.
Secondo le ultime informazioni il trentaquattrenne vivrebbe in Siria, nella zona di Aleppo e sarebbe ancora una volta lui dietro il lancio della app “Dawn of Glad Tidings” l’alba delle buone novelle scaricabile dallo store “Google Play” per diffondere notizie e notifiche con lo scopo d’ingigantire la macchina mediatica dello Stato Islamico per farla sembrare ancora sofisticata in termini d’infrastrutture tecniche.
«Ci sono diverse divisioni dentro IS che si occupano di social media: l’account ufficiale pubblica tutti i video, gli account provinciali pubblicano i racconti locali. Gli account dei singoli mujaheddin permettono ai combattenti di continuare il proprio racconto di vita quotidiana ed esperienze sul terreno». Lo dice Abu Bakr al-Janabi, un supporter dello Stato Islamico che spesso traduce e diffonde i messaggi del gruppo.
Dietro a tutto questo ci sono diverse organizzazioni di centralizzazione e ridiffusione del messaggio. La principale è al-Furqan Media, che invia continuamente in rete documenti di battaglie epiche e del mondo idilliaco del califfato. Accanto lavora Fursan al-Balagh Media, che si occupa delle traduzioni per la diffusione globale del messaggio. Insieme hanno fondato una vera e propria agenzia di comunicazione, al-Hayat Media Center, che si occupa di postare i video dell’Isis e di diffondere i messaggi dell’organizzazione.
Eppure questa ricostruzione è del tutto parziale: non si contano i “centri di produzione dei video”, i luoghi di organizzazione e diffusione della propaganda. E poi il lavoro dei singoli che contribuiscono con la propria capacità e creatività alla costruzione di un impianto narrativo imponente.
Conclusioni
Lo Stato Islamico, nelle sue scelte di comunicazione, ci ha fatto capire alcune cose in modo assolutamente chiaro.Innanzitutto:
- le modalità di comunicazione del califfato non sono casuali ma perseguono con precisione e lucidità diversi scopi. Il primo: essere percepiti come un’organizzazione statale a tutti gli effetti con regole, progetto politico, strutturazione e strategia di lungo periodo. Il secondo: fare proseliti all’interno dei propri territori e, soprattutto, sul piano globale.
- Gli obiettivi della narrativa più sofisticata sono i giovani delle seconde e terze generazioni musulmane in ogni angolo del pianeta e non solo. Il messaggio roboante di lotta all’ingiustizia e un’epica trascinante, come pochi dei messaggi occidentali ormai sono in grado di essere, si trasformano in straordinari catalizzatori della voglia di ribellione nei confronti di un Occidente percepito come ingiusto, aggressivo e corrotto.
- C’è poi un terzo livello della comunicazione: quello destinato a tutte le realtà jihadiste a livello globale. Lo Stato Islamico si pone come esempio di successo della costruzione di uno stato in cui vige la sharia, in cui la legge islamica permette una riscrittura delle regole e dei comportamenti secondo una lettura oscurantista del Corano. Il califfato rappresenta, fin qui, una storia di successo che diventa polo di attrazione e imitazione per tutti gli altri gruppi radicali del pianeta, ed è proprio per questo che tanta parte della propaganda è dedicata a far vedere come l’interpretazione più corretta del Corano sia quella del califfo e i veri jihadisti siano solo coloro che hanno unito i propri passi a quelli dello Stato Islamico. L’IS insomma ha lanciato la propria campagna di aggressione a tutte le altre sigle in un disegno che vede collegate e coordinate le varie realtà. Il califfato ha progetti globali e lo fa intuire attraverso le proprie scelte di comunicazione.
- Twitter, Facebook e internet sono diventate gli strumenti contemporanei con i quali veicolare il più arcaico dei messaggi. Lo Stato Islamico, che ha distrutto in un rogo migliaia di libri a Mosul, è assistito da giovani comunicatori cresciuti con i miti hollywoodiani che attraverso i social network rimandano una visione del mondo che ha solo il linguaggio e i codici formali dell’oggi.
- Il moltiplicarsi delle “comunicazioni”, dei messaggi, dei video, delle uscite delle riviste che provengono nelle ultime settimane dallo Stato Islamico danno la sensazione di una escalation in corso. Quanto questa escalation corrisponda effettivamente ad azioni sul terreno, a preparazione di attacchi terroristici, o sia semplicemente un’offensiva mediatica, allo stato attuale non è dato sapere. Certo, per quanto abbiamo visto fin qui, anche se si trattasse esclusivamente di attivismo mediatico, la cosa non può essere considerata con leggerezza.
- La proliferazione ossessiva delle testimonianze in fondo provoca già un primo risultato: annettere alla presenza su scala globale dello Stato Islamico un senso d’inevitabilità. L’IS s’impone ai nostri racconti, alle scalette dei nostri telegiornali, guadagna le prime pagine dei giornali. E questo, in sé è già un risultato. Lo stesso gruppo di uomini, moltiplicando la comunicazione delle proprie imprese crea, come in un sofisticato gioco di specchi, una rappresentazione ingigantita della realtà.