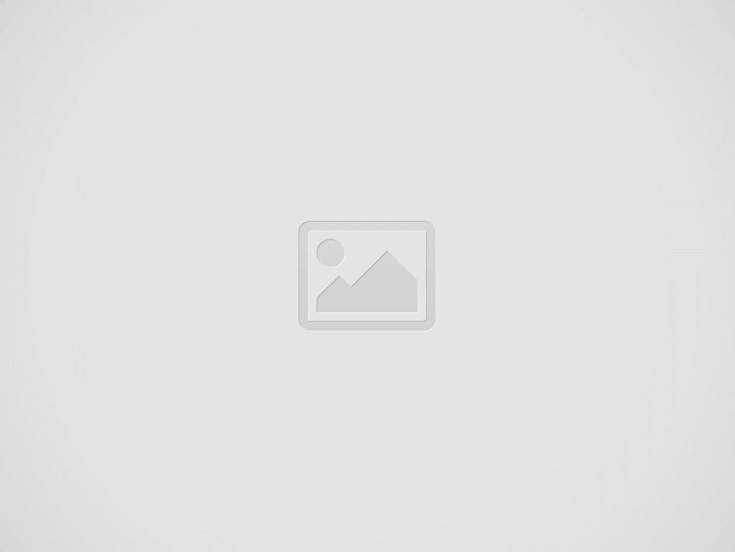La scarpa sfondata presa all’amo dal pescatore sfortunato, cara ai lettori della Settimana enigmistica, nella realtà – dice una ricerca pubblicata di recente – è meno comune rispetto a bottiglie e sacchi di plastica, rottami d’auto, vecchie reti e attrezzatura per la pesca, scaldabagni, motorini, vestiti, rifiuti di ogni genere giacciono nelle profondità dei mari europei.
A fotografare lo stato di salute delle acque del vecchio continente, mostrando come anche i fondali più profondi e più lontani dalle coste siano popolati da spazzatura, è un’indagine coordinata da Christopher Pham, dell’università delle Azzorre, e pubblicata su Plos One.
L’inquinamento da rifiuti negli oceani è un’emergenza ormai nota e studiata, che causa problemi a mammiferi e pesci quando se ne nutrono per sbaglio scambiandolo per cibo, e che danneggia l’ecosistema impigliandosi nei coralli o negli stessi pesci.
Per comprendere meglio l’estensione e la composizione dei rifiuti al largo delle coste europee, l’équipe ha analizzato circa 600 porzioni di fondali, in 10 anni, da 32 siti sparsi negli oceani Atlantico e Artico e nel Mediterraneo, a una profondità variabile dai 4 metri ai 4,5 km. La spazzatura è stata trovata in tutti i fondali studiati, da quelli più vicini alle coste fino a 2 mila chilometri dalla terraferma. E a tutte le profondità, dai 35 metri del Golfo del Leone ai 4.500 metri del canyon di Cascais di fronte alla costa del Portogallo. La più invasiva si conferma la plastica, che costituisce il 41% dei rifiuti che si trovano in fondo al mare, seguita da vecchia attrezzatura da pesca (34%). Sono poi stati trovati vetro, metallo, carta, cartoni, vestiti, ceramiche e altri materiali non identificati. “La maggior parte delle profondità marine non è mai stata esplorata dagli uomini e la nostra è stata la prima visita in molti di questi siti: eppure, la spazzatura è arrivata prima di noi e l’abbiamo trovata anche in queste aree più remote. Questi risultati scioccanti devono farci riflettere e spingerci a intervenire”, sottolinea Kerry Howell, coautore dello studio.